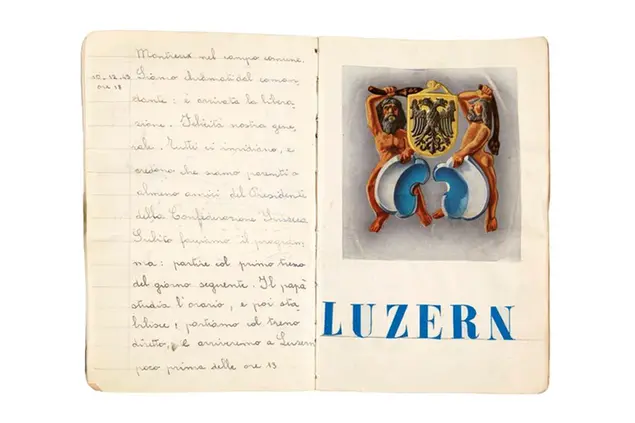L’amara verità, ancora più evidente oggi, è che la memoria della Shoah ha bisogno di una cura attenta. Perciò è così preziosa la testimonianza dei diari di infanzia di De Benedetti durante la sua fuga in Svizzera
Nonostante tutti gli sforzi – che forse ognuno di noi ha fatto – per mettersi nei loro panni, non siamo ancora in grado di comprendere fino in fondo lo stato d’animo di coloro che fuggivano dall’Italia delle leggi razziali e sentivano su di sé la morsa sempre più stretta della volontà di sterminio. Dall’autunno del 1943 alla primavera del 1945. Quando anche la speranza era un lusso. E la solitudine una condanna annunciata. Molti guardavano, impauriti, altrove. Pochi ebbero il coraggio di aiutare chi era destinato alla morte. Coraggiosi. Temerari.
Domanda alla quale non possiamo sfuggire: oggi noi come ci comporteremmo? Meglio dei nostri antenati? Ne siamo sicuri? In tutti questi anni siamo stati destinatari di tanti racconti della memoria della persecuzione e della deportazione. Vaccini della Storia. Una letteratura abbondante, testimonianze dettagliate e precise, opere cinematografiche immortali. Al punto che qualche volta siamo persino indotti a ritenere che sia stato scritto ormai quasi tutto. C’è ancora qualcosa da sapere? In realtà molto. Perché purtroppo non basta mai.
La cura della memoria
L’amara verità è che la memoria della Shoah e della persecuzione degli ebrei ha bisogno, nonostante tutto, di una cura attenta, non obbligata né rituale. Abbiamo scoperto, ormai ottant’anni dopo, quanto nella sua ormai incoraggiante vastità sia fragile e manipolabile.
E quanto siano ancora diffuse, tra le pieghe delle società occidentali, nel precipitato delle nostre culture nazionali, nel vissuto della cattolicità italiana, le tracce di antichi pregiudizi, di pericolosi distinguo e di comode distanze. Ancora oggi, nonostante tutto l’immenso dibattito storico che c’è stato, i tragici conti con la Storia che alcuni hanno fatto e altri no (i tedeschi certamente meglio degli italiani), non siamo in grado di dire che l’antisemitismo sia stato sconfitto.
Tutt’altro. Ha ricevuto persino nuova linfa dopo la reazione, spropositata e inaccettabile, di Israele al pogrom (perché di questo si trattava) del 7 ottobre. E ancora una volta le responsabilità di un governo sono diventate – persino agli occhi di intellettuali e docenti universitari che insegnano negli atenei più celebrati del mondo – le colpe di un popolo. E la solidarietà nei confronti degli abitanti della striscia di Gaza, che hanno sopportato dolori e perdite ingiustificabili, ha finito per assolvere Hamas da tutte le sue brutali idee e volontà terroristiche, tra le quali vi è anche la cancellazione dello Stato di Israele. Il pogrom del 7 ottobre, con le sue violenze inaudite contro donne e bambini, è stato derubricato. Quasi fosse un moto insurrezionale. E non lo era.
La Storia di questi ultimi ottant’anni non ha influenzato, come avremmo creduto, il racconto della cronaca. Ne è una prova l’isolamento in cui è caduto, per colpa del proprio governo, lo Stato di Israele. Non è una buona notizia per il mondo libero e per le democrazie rappresentative. Peccato che molti, là dove vi è una pubblica opinione libera, non se ne siano accorti.
Testimonianza cruciale
Questa ampia premessa mi è parsa doverosa perché Diario di un ragazzino rifugiato. 1943- 1945 non è semplicemente un frammento di memoria infantile. Un diario privato conservato gelosamente ma tenuto anche nascosto a lungo, come se lo si dovesse proteggere da nuove forme di pregiudizio. Questo volume non restituisce alla memoria collettiva solo i diari di un bambino, Carlo De Benedetti, classe 1934.
Vi sono riprodotti quaderni, disegni oltre a lettere personali, scambi di auguri, biglietti del treno o del cinema, comunicazioni al padre Rodolfo, alla mamma Pierina. Senza alcuna annotazione più recente, senza alcun commento. Vanno letti così: nella loro innocente e ingenua semplicità o nella loro composta normalità. Perché quello era, alla fine – seppur condensato soprattutto nelle parole semplici di un bambino – lo stato d’animo di molti dei perseguitati dal regime fascista e nazista. Un senso di incredulità sull’orlo dell’abisso. Ma anche, in alcuni scambi epistolari, l’espressione di un forte bisogno di normalità. La fabbrica che va avanti nonostante tutto, le relazioni personali, le carte annonarie svizzere, le scuole da frequentare, le difficoltà del tedesco da imparare. C’è la storia di una famiglia torinese che dopo le leggi razziali fugge in Svizzera. E riesce fortunatamente a ottenere asilo. A differenza di altri.
In quegli stessi giorni, Liliana Segre, classe 1930, insieme a suo padre Alberto è invece respinta. Saranno deportati dalla stazione centrale di Milano, dal binario 21 dove sorge oggi il Memoriale della Shoah, il 30 gennaio del 1944. Verso Auschwitz. Il padre di Liliana, come i nonni, verrà subito mandato nelle camere a gas.
Rodolfo De Benedetti raccomanda ai figli, Carlo e Franco, maggiore di poco più di un anno, di scrivere un diario. Non solo per passare le loro giornate e dare disciplina alla nuova vita di esuli, ma anche «perché qualcuno non crederà che tutto ciò che stiamo vivendo sia veramente avvenuto».
Il racconto della fuga
Carlo ricordò la frase del padre in un incontro, organizzato dalla società Carlo Cattaneo, che tenemmo all’Università della Svizzera italiana, a Lugano, il 10 ottobre del 2016. Fu quella un’occasione straordinaria perché l’ingegnere non era mai stato particolarmente incline al racconto di quel periodo di angoscia e smarrimento. Lo custodiva nell’album di famiglia, con istinto protettivo.
Ma si sentì in dovere di parlarne in quel Canton Ticino che aveva ospitato lui e la sua famiglia e nel quale aveva da tempo la sua residenza. «Si viveva con poco, ma sorprendentemente felici». Il fratello Franco ha raccontato, in una intervista ad Antonio Gnoli su la Repubblica, che la famiglia lasciò Saluzzo – dove era sfollata dopo i bombardamenti del 1942 che avevano distrutto la prima fabbrica a Torino (poi ricostruita e attiva nella produzione bellica ad Asti) – e arrivò a Cernobbio e a Chiasso.
La fuga verso la libertà avvenne a caro prezzo. Agevolata da un ex dipendente della fabbrica di famiglia che era diventato ispettore di dogana a Como. Fu lui a procurare a tutti i documenti falsi.
Dal diario di Carlo sembra quasi una gita. «Papà mi fa vedere, attraverso una finestra della cameretta dove siamo, una rete metallica alta e robusta e mi dice che al di là della rete c’è la Svizzera». È il 3 novembre del 1943. Carlo, che non ha ancora dieci anni, è preciso, ordinato. Segna anche l’ora, le 17. «Ci troviamo di fronte alla rete, in basso c’è un buco, ci infiliamo in grande fretta e passiamo di corsa. Di là della rete ci sono le nostre valigie. Un caporale svizzero ci arresta. Ora il papà mi spiega che siamo fuggiti in Svizzera per sfuggire ai tedeschi e ai fascisti».
Il ragazzino rifugiato non sembra particolarmente turbato dalla rivelazione paterna. Prosegue la sua cronaca. Non c’è traccia di paura. Prevale il gusto dell’avventura che si schiude davanti ai suoi occhi. Lo testimoniano le tante cartine geografiche, aggiunte alle pagine del diario, sulle quali resta intatta la libertà di sognare. Attento ai dettagli. «Dormiamo per terra su pagliericci di foglie di grano turco».
Poi, dopo tre giorni, l’arrivo a Lugano e il confinamento in un albergo, in uno stato di semilibertà, con una giornaliera passeggiata collettiva. «Non ci pare vero di dormire in letti comodi e con certi piumini che non avevo mai visto e che tengono deliziosamente caldo».
Carlo si illude per un attimo che quella sia una sorta di villeggiatura. «Ma il papà mi toglie un poco dell’entusiasmo dicendomi che questa cosa costa assai cara e che essendo noi fuggiti dall’Italia con pochi mezzi, occorre che facciamo bene i conti e allora mi spiega come valga poco la nostra lira qui in Svizzera. Ho subito imparato a calcolare per ogni prezzo in franchi il corrispondente valore in lire». Il cambio reale della lira continuava a peggiorare. L’attesa febbrile è per l’ordine di liberazione da parte delle autorità svizzere che arriva il 10 dicembre del 1943 alle ore 18. «Felicità nostra generale. Tutti ci invidiano e credono che noi siamo parenti, o almeno amici, del presidente della Confederazione svizzera».
I De Benedetti partono subito per Montreux e poi Lucerna. Di soldi ne sono rimasti pochi. «Fortunatamente anche Franco, qui in Svizzera, paga soltanto metà biglietto». Il racconto del Natale, con la messa nella chiesa di San Pietro (la nonna era cattolica) e l’omelia di don Guido, missionario italiano, è una scoperta di luci, sensazioni, regali inaspettati. L’ospitalità della famiglia Meyer-Keller, le lezioni e le gite con l’istitutrice Adrienne. Poi dopo la Pasqua, nel diario del ragazzino rifugiato, irrompe la Storia che viene documentata dai ritagli dei giornali dell’epoca. Tutti scritti in quel tedesco ostico che i fratelli erano stati costretti a imparare senza che questo rappresentasse un ostacolo ai loro percorsi di studi. Carlo nota con soddisfazione i successi scolastici di Franco che sta un anno avanti. Quando Roma viene liberata, Carlo è ricoverato in clinica.
Scrive dello sbarco in Normandia, dell’attentato a Hitler, della «sorpresa delle bombe volanti» su Londra. La guerra sta finendo. E la famiglia si interroga su quale sarà il proprio futuro. «Mio padre – ricordò Carlo De Benedetti, in quell’incontro di Lugano – ci disse che saremmo tornati in Italia se fosse rimasta nel mondo libero e se non fossero arrivati i comunisti, se no ce ne saremmo andati altrove, forse in Portogallo». Per fortuna loro (e nostra) i De Benedetti tornarono nel loro Piemonte in un’Italia liberata.
Pubblichiamo la prefazione di Diario di un ragazzino rifugiato. 1943 – 1945 (Treccani, 2024, pp. 328, euro 39). Il libro è una raccolta dei diari d’infanzia di Carlo De Benedetti (editore di questo quotidiano) durante il periodo in cui la sua famiglia è stata costretta a rifugiarsi in Svizzera per sfuggire alla persecuzione razziale nazifascista.
© Riproduzione riservata