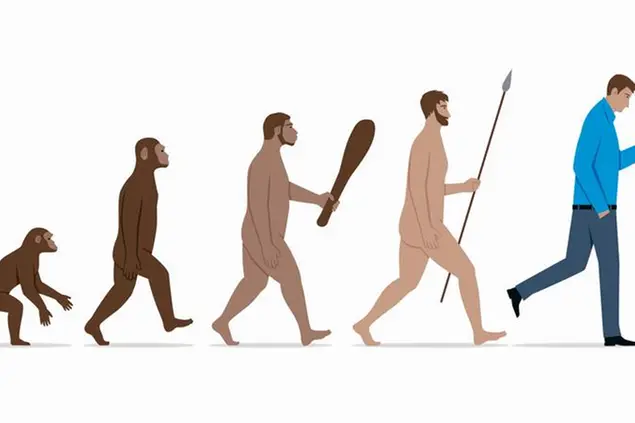C’è stato un periodo della storia degli ominidi che per cause climatiche scesero a circa 1.300 individui fertili. Se fossero scesi di qualche ulteriore centinaia di unità, forse l’Homo sapiens non sarebbe mai esistito.
Un importante passo in avanti nella comprensione dell’evoluzione degli ominidi che hanno portato anche al sapiens, arriva da uno studio genetico e antropologico pubblicato sulla rivista internazionale Science, alla quale hanno partecipato un gruppo di ricercatori cinesi e italiani, tra cui esperti dell’Accademia Cinese delle Scienze, dell’università Normale Orientale di Shanghai, dell’università del Texas, della università Sapienza di Roma e dell’università di Firenze. Grazie ad un innovativo metodo bioinformatico, chiamato “FitCoal” i ricercatori hanno esaminato i genomi completi di 3.154 individui attuali, appartenenti a 50 diverse popolazioni umane, e hanno combinato questi dati con informazioni paleoambientali (clima) e paleoantropologiche (fossili) che consentissero di risalire a periodi preistorici precedenti all’apparizione della nostra specie, come spiega il professor Haipeng Li, che ha coordinato la ricerca.
Il collo di bottiglia
I risultati dello studio hanno rivelato che tra 930 e 813mila anni fa la popolazione dei nostri antenati si ridusse di circa il 98,7 per cento, arrivando a contare solo circa 1.300 individui fertili: un numero paragonabile alle specie a rischio di estinzione, come sono ad esempio gli attuali panda. Tale fenomeno, noto come “collo di bottiglia” (o bottleneck) genetico, è stato con ogni probabilità dovuto ai drastici cambiamenti climatici che caratterizzano la cosiddetta «transizione medio-pleistocenica».
Successivamente a un milione di anni fa i cicli glaciali e interglaciali si ampliarono a livello planetario, portando a condizioni di estrema aridità in Africa e a estinzioni di intere comunità di grandi mammiferi. Queste avverse condizioni climatiche e ambientali resero la sopravvivenza estremamente difficile anche per i nostri antenati, portandoli sull’orlo dell’estinzione. L’evento sarebbe stato tanto catastrofico quanto generativo, dando probabilmente origine a una specie che viene ritenuta fondamentale per evolversi poi nell’Homo sapiens (cosa che avvenne successivamente in Africa).
Questi risultati genetici trovano conferma nell’assenza di fossili di ominidi di quel periodo. È stata infatti, rilevata una lacuna di circa 300mila anni che coincide quasi perfettamente con il periodo del collasso demografico rilevato dallo studio.
«Questo periodo di crisi demografica», spiega Giorgio Manzi della Sapienza, «potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione umana. Durante un bottleneck, i normali equilibri ecologici e genetici vengono sconvolti, aumentando la probabilità che si vengano a fissare varianti genetiche inattese, contribuendo all’emergere di una nuova specie».
«Questa nuova specie è probabilmente l’Homo heidelbergensis», sottolinea Fabio Di Vincenzo dell’università di Firenze, «che possiamo considerare un vero e proprio ultimo antenato comune, per tre diverse specie: Homo sapiens in Africa, Neanderthal in Europa e Denisova in Asia».
Storia di una stella inghiottita
È noto che i buchi neri sono in grado di “inghiottire” ogni cosa se un oggetto gli si avvicina al punto in cui la forza di gravità supera ogni altra forza che tenderà a farlo sfuggire. Ebbene, recentemente, gli astronomi hanno condotto uno studio forense approfondito su una stella che è stata fatta a pezzi quando si è avventurata troppo vicino ad un gigantesco buco nero e alcune sue parti interne sono state gettate nello spazio profondo.
Quasi da fantascienza, ma è realtà. I telescopi spaziali a raggi X denominati Chandra della Nasa e XMM-Newton dell’Esa, hanno studiato la quantità di azoto e carbonio vicino ad un buco nero. Gli astronomi pensano che questi elementi siano stati creati all’interno della stella poco prima che questa venisse fatta a pezzi mentre si avvicinava al buco nero stesso.
«Stiamo vedendo le viscere di quella che era una stella», ha detto Jon Miller dell’università del Michigan che ha condotto lo studio. «Gli elementi lasciati indietro sono indizi che possiamo seguire per capire che tipo di astro ha incontrato quella drammatica fine». Negli ultimi anni gli astronomi hanno trovato vari esempi di “eventi di distruzione delle maree”, una terminologia che indica un fenomeno dove le forze gravitazionali di un enorme buco nero distruggono una stella che gli passa lì vicino.
Ciò provoca un bagliore, spesso osservato nella luce ottica, ultravioletta e nei raggi X, poiché i detriti della stella vengono fortemente riscaldati. L’evento in questione, chiamato ASASSN-14li, si distingue da quelli osservati per diversi motivi. Per prima cosa, al momento della scoperta, nel novembre 2014, si trattava della “perturbazione mareale” più vicina alla Terra allora nota, circa 290 milioni di anni luce.
Grazie a questa vicinanza, ASASSN-14li ha fornito uno straordinaria quantità di dati sulla stella distrutta. Il gruppo di lavoro di Miller ha applicato nuovi modelli teorici per effettuare le migliori stime circa la quantità di azoto e carbonio presente attorno al buco nero. «Questi telescopi a raggi X possono essere utilizzati come strumenti forensi nello spazio», ha affermato la coautrice Brenna Mockler del Carnegie Observatories e dell’università della California, Los Angeles. «La quantità relativa di azoto e carbonio che abbiamo trovato indica materiale proveniente dall’interno di una stella che possedeva una massa circa tre volte quella del Sole».
La stella in ASASSN-14li è quindi una delle più massicce, e forse la più massiccia che gli astronomi abbiano visto finora fatta a pezzi da un buco nero. «La storia di ASASSN-14li è entusiasmante anche perché determinare la massa di una stella fatta a pezzi è tra le cose più difficili che si possano immaginare», ha affermato il coautore Enrico Ramirez-Ruiz dell’università della California, Santa Cruz. Un altro aspetto interessante del risultato ASASSN-14li è ciò che significa per gli studi futuri.
Gli astronomi hanno visto stelle moderatamente massicce come ASASSN-14li nell’ammasso stellare che circonda il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia. Pertanto, la capacità di stimare le masse stellari delle stelle disgregate dalle maree offre potenzialmente agli astronomi un modo per identificare la presenza di ammassi stellari attorno a buchi neri supermassicci nelle galassie più distanti che furono totalmente o parzialmente distrutti dal buco nero.
In altre parole è possibile risalire alla presenza di stelle attorno a buchi neri anche molto distanti semplicemente studiando ciò che i buchi neri hanno evitato di ingerire dopo aver mangiato una stella di passaggio.
Montagne calde
Le conseguenze del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti, ma le diverse aree del nostro pianeta non si stanno riscaldando tutte alla stessa velocità. Le aree di alta montagna soffrono particolarmente gli effetti del riscaldamento globale, ma fino ad oggi mancavano dati che coprissero ad elevato dettaglio e in tutto il mondo queste aree così delicate.
Il lavoro appena pubblicato sulla rivista Nature Communications prova a colmare questa lacuna. Un gruppo internazionale, coordinato da ricercatori dell’università degli Studi di Milano e dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Igg), in collaborazione con il MUSE-Museo delle Scienze dig Trento e la University of Texas-Austin, ha piazzato centinaia sensori per misurare la temperatura del suolo in prossimità dei ghiacciai che si trovano in diverse aree del mondo, dalle Alpi alle Ande del Perù fino alle isole Svalbard (vicino al Polo Nord). Questo ha permesso di produrre la carta più dettagliata ad oggi esistente della temperatura nelle aree di alta montagna, in grado di rilevare le differenze che in montagna possono esistere tra zone a poche decine di metri di distanza.
Analizzando i dati degli ultimi 20 anni, i ricercatori si sono accorti che alcune aree di alta montagna si stanno riscaldando ancor più di quanto atteso dai modelli globali. La situazione è particolarmente grave per le montagne delle aree tropicali e sub-tropicali, e per le zone in prossimità dei ghiacciai. Il ritiro dei ghiacciai e la riduzione del manto nevoso, probabilmente, stanno amplificando il tasso di riscaldamento.
La presenza di neve e ghiaccio può infatti, tamponare l’aumento della temperatura, ma la loro scomparsa dalle aree di alta montagna di tutto il mondo sta cambiando questi ecosistemi importantissimi ad una velocità senza precedenti.
Riguardo i numeri: considerando la media annua, l’incremento delle temperature del suolo nel periodo 2001-2005 rispetto al 2016-2020 è stato consistente, soprattutto nella zona intertropicale (+0.75 °C) e nell’emisfero australe (+1.02 °C). In tutte le fasce latitudinali, il riscaldamento è stato molto più intenso in prossimità dei ghiacciai (100 metri) che in aree locate a tre chilometri di distanza dai ghiacciai stessi. Riassumendo, nell’ultimo ventennio le aree prossime ai ghiacciai si sono scaldate circa il doppio di quelle situate a soli 3 chilometri di distanza.
Molto interessante anche la diminuzione della durata della stagione con neve al suolo, con pattern confrontabili a quelli di temperatura, ma ancora più evidenti. Anche in questo caso, riassumendo, negli ultimi 20 anni le aree prossime ai ghiacciai hanno sperimentato un fortissimo incremento medio della lunghezza della stagione senza neve al suolo: da due settimane a un mese per anno. Questi dati saranno utilissimi per predire come gli ecosistemi di alta montagna si modificheranno nei prossimi decenni.
© Riproduzione riservata