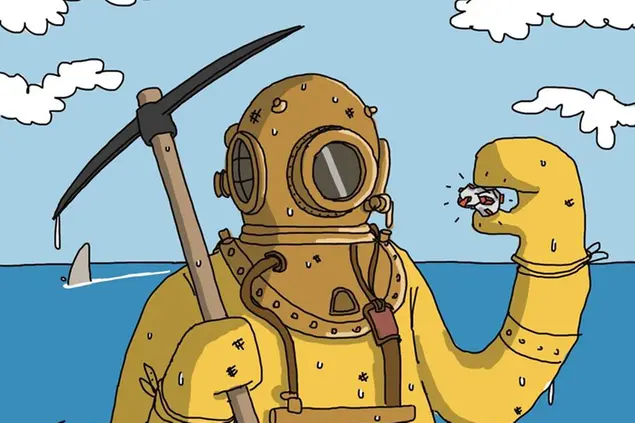- La richiesta di particolari minerali per l’industria elettronica ha ravvivato l’interesse nell’estrazione dei noduli minerali che si trovano sui fondali oceanici.
- Si stima che vi potrebbero essere 500 miliardi di tonnellate di noduli sparsi negli oceani.
- Senza una legislazione ad hoc però i danni delle estrazioni potrebbero essere gravissimi. Molti scienziati stanno prendendo posizione per una moratoria.
Circa mezzo secolo fa si iniziò a sognare di sfruttare i fondali marini profondi per estrarre minerali importanti. Da allora, quei sogni si sono lentamente trasformati in un incubo poiché le ricerche scientifiche hanno scoperto ecosistemi estremamente delicati e interconnessi tra loro presenti sul fondo degli oceani. Si sono così resi conto che l’estrazione mineraria avrebbe rischiato di sconvolgere la salute e il funzionamento dell’intero nostro pianeta. Per fortuna lo sfruttamento dei fondali oceanici non è ancora iniziato, ma è solo questione di tempo, di pochissimo tempo.
Paesi come Regno Unito, Francia, Belgio, Giamaica, Russia, Cina e Giappone hanno tutti gli occhi puntati sui metalli presenti all’interno di noduli delle dimensioni di una patata, sparsi in una vasta pianura abissale chiamata Clarion Clipperton Zone, a 5.000 metri sott’acqua nell’Oceano pacifico. I noduli metallici, sono delle concrezioni minerali che si trovano sparsi sui fondali di molti oceani. Sono composti per lo più da idrossidi di ferro e manganese che si aggregano attorno a un nucleo che può anche essere un piccolissimo detrito o fossile. Insieme al ferro e al manganese si può trovare nichel, rame, cobalto, ma anche titanio e bario. Generalmente hanno un diametro di 5-10 centimetri, ma possono raggiungere anche i 20 centimetri.
L’idea di sfruttare tali noduli ha avuto momenti alterni: da grande entusiasmo negli anni Settanta, fino a un interesse quasi svanito negli anni Novanta e Duemila soprattutto per i costi di estrazione. Ma ora che la richiesta di determinati elementi chimici è in forte aumento l’interesse sta tornando più vivo che mai. Nella corsa all’estrazione dei noduli comunque, c’è qualcuno che spinge più di tutti in questa direzione ed è lo stato insulare del Pacifico di Nauru, spiega NewScientist. Lo stato, utilizzando una disposizione controversa del diritto internazionale, ha dichiarato che una società appaltatrice della The Metals Company di proprietà canadese intende richiedere un permesso minerario nelle proprie acque territoriali dell’Oceano pacifico.
Ciò starebbe a significare che tra due anni l’International Seabed Authority «approverà in via provvisoria» la miniera di noduli di Nauru, che opererebbe secondo le normative ambientali in vigore oggi, così come saranno tra due anni: ossia nessuna. Le leggi in tal senso infatti sono attualmente in discussione e non sono neanche lontanamente pronte. Se l’estrazione dei fondali marini dovesse andare avanti senza alcuna regolamentazione seria, potrebbe scatenare un disastro ambientale. Le miniere di noduli potrebbero spazzare via specie e popolazioni marine uniche. I pennacchi di sedimenti che verrebbero sollevati dal fondo marino potrebbero soffocare gli animali, compresi quelli che vivono lontano dalle miniere.
Le acque reflue minerarie potrebbero inquinare le acque profonde. Dai tardigradi al tonno, ai polpi, ai coralli e agli squali balena, l’estrazione di noduli potrebbe danneggiare una vasta gamma di vita oceanica. La miniera di Nauru potrebbe essere rapidamente seguita da altre dozzine di miniere marine gestite da altri paesi e società, con un impatto su migliaia di chilometri quadrati di fondali marini per decenni a venire. Inoltre, potrebbe aprire la strada all’estrazione in prossimità di bocche idrotermali, che ospitano ecosistemi sorprendenti e ancora poco conosciuti.
Spiega Helen Scales, biologa marina della Cambridge University: «Oltre alla distruzione immediata, l’estrazione in acque profonde potrebbe avere impatti molto più ampi, interrompendo la regolazione del clima, il ciclo dei nutrienti e lo stoccaggio a lungo termine del carbonio nell’oceano. E se l’imminente catastrofe ambientale non è abbastanza allarmante, l’estrazione mineraria potrebbe danneggiare gli ecosistemi che contengono sostanze chimiche poco studiate con un enorme potenziale per nuovi farmaci».
Per fortuna l’estrazione in acque profonde non è inevitabile e c’è ancora del tempo per frenarla o fermarla. Continua Scales: «Ecco perché mi sono unita a centinaia di altri scienziati ed esperti di politica nel chiedere una moratoria globale. La nostra Dichiarazione sulla scienza mineraria in acque profonde chiede una pausa sull’estrazione mineraria fino a quando non comprenderemo quali potrebbero essere gli impatti completi sugli oceani ed è aperta a ulteriori firme da chiunque desideri mostrare il proprio sostegno». Raggiungere un tale obiettivo prima della fine del biennio sarà impegnativo, ma siamo ottimisti che possa succedere.
Una strada promettente sembra essere l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha dei precedenti. La risoluzione non vincolante su alcuni tipi di pesca in alto mare ha portato a una moratoria su alcune tecniche distruttive, che uccidevano un gran numero di delfini, balene, tartarughe marine e uccelli marini. Una risoluzione equivalente delle Nazioni Unite per una moratoria sull’estrazione dei fondali marini potrebbe portare ad un blocco delle estrazioni così vicine al via.
Rischio “acqua”
I rischi legati all’acqua in eccesso o in carenza dominano l’elenco dei disastri in termini di vittime umane ed economiche degli ultimi 50 anni. È questo il risultato del rapporto WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019), realizzato dalla World Meteorological Organization (Wmo) che sarà pubblicato prima dell’Assemblea generale dell’Onu a settembre.
Il lavoro ha realizzato tra l’altro una specie di classifica dei disastri che si sono verificati sul pianeta negli ultimi 50 anni e risulta che le siccità hanno causato 650mila morti, le tempeste 577.232 morti, le inondazioni 58.700 morti e le temperature estreme 55.736 morti. Le tempeste hanno causato 521 miliardi di dollari di danni, mentre le inondazioni 115 miliardi di dollari. Il rapporto getta un occhio anche sui disastri climatici di queste ultime settimane causati da precipitazioni estreme.
Secondo il Deutscher Wetterdienst (il centro per il clima tedesco), tra il 14 e il 15 luglio sono caduti 100-150 millimetri di pioggia in 24 ore. Tra il 17 e il 21 luglio, in alcune aree della provincia cinese centrale dell’Henan è piovuto di più che in anno intero. Va sottolineato che eventi estremi singoli non rappresentano la certezza che i cambiamenti climatici ne siano la causa, tuttavia, come sottolinea la Wmo, un numero crescente di studi sta scoprendo l’influenza umana sugli eventi di precipitazioni estreme che sono in continuo aumento rispetto al passato.
Un esempio sono le precipitazioni estreme nella Cina orientale a giugno e luglio 2016, dove è emerso che l’influenza umana ha aumentato significativamente la probabilità dell’evento. A far da contraltare a tutto ciò c’è un elemento positivo o perlomeno meno tragico e riguarda il bilancio delle vittime il quale risulta è in calo rispetto al passato. Questo lo si deve al miglioramento dei sistemi di allarmi tempestivi e alla migliore gestione delle catastrofi.
Città e gas serra
Stando a una ricerca pubblicata su Frontiers in Sustainable Cities, 25 metropoli sarebbero responsabili di oltre la metà delle emissioni di gas serra a livello globale. In realtà queste mega-città occupano appena il 2 per cento della superficie terrestre, ma sono tra le maggiori responsabili della crisi climatica che il pianeta sta vivendo. Spiega Shaoqing Chen, uno degli autori dello studio: «Più della metà della popolazione mondiale oggi vive nelle città, le quali sono responsabili di oltre il 70 per cento delle emissioni di gas serra a livello globale».
Lo studio dimostra che, come si può immaginare, sono soprattutto i paesi industrializzati a emettere maggiormente i gas serra, pur tuttavia con alcune eccezioni. La Cina, che generalmente viene ancora classificata come paese in via di sviluppo, ha in essa Shanghai che risulta una tra le città più inquinanti in senso assoluto. Europa, Stati Uniti e Australia emettono gas serra in quantità assai superiore rispetto ai paesi in via di sviluppo. I principali responsabili delle emissioni sono i consumatori di energia elettrica, tra cui edifici residenziali, commerciali, industriali e istituzionali, che nelle città europee e americane contribuiscono alle emissioni globali per il 60-80 per cento. In un terzo delle città analizzate, oltre il 30 per cento delle emissioni sono prodotte invece dai trasporti su strada, mentre meno del 15 per cento da treni, vie navigabili e aviazione.
C’è comunque un dato positivo: il fatto che alcune città hanno dato vita a un importante calo nelle emissioni, una prova che se si mettono a frutto gli Accordi di Parigi, entrati in vigore nel 2016, possono dare i loro frutti. Tra queste, le quattro più virtuose sono Oslo (Norvegia), Houston (Texas), Seattle (Washington) e Bogotà (Colombia). Al contrario, le città che hanno visto incrementare le proprie emissioni pro capite sono Rio de Janeiro (Brasile), Curitiba (Brasile), Johannesburg (Sudafrica) e Venezia.
La crescita del Mediterraneo
Nell’ultimo secolo e mezzo il Mediterraneo si è innalzato di circa 1,25 millimetri l’anno, un tasso più che raddoppiato rispetto agli ultimi 4mila anni. Il dato arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da un gruppo internazionale coordinato da Matteo Vacchi, ricercatore dell’università di Pisa. «Questo lavoro ci ha permesso di quantificare in modo dettagliato gli impatti delle emissioni di gas serra legate alla rivoluzione industriale sull’innalzamento del Mar Mediterraneo – spiega Vacchi, del Dipartimento di scienze della terra – questo ci permetterà di calibrare meglio gli scenari futuri, i modelli attualmente disponibili sono infatti rilasciati su scala globale e devono quindi essere calibrati su scala più piccola, in particolare per un bacino semi-chiuso come il Mediterraneo dove le conseguenze del cambiamento climatico sono significativamente diverse da quelle degli oceani globali».
Lo studio ha riguardato complessivamente l’andamento dei tassi di innalzamento del Mediterraneo centrale e occidentale negli ultimi 10mila anni. I dati sono stati ricavati da circa 400 indicatori di paleo-livelli del mare datati al radiocarbonio e derivati per la maggior parte da carotaggi e campionamenti subacquei effettuati tra il livello del mare attuale e circa -45 metri di profondità. Dall’analisi è emerso che tra i 10mila e i 7mila anni fa, durante la prima fase di fusione delle calotte glaciali, i tassi di risalita del livello del mare si sono attestati in media a circa 8,5 mm/anno. Da quel momento e per gli ultimi 4mila anni, con la stabilizzazione delle calotte glaciali, i tassi medi sono scesi e sono rimasti nell’ordine degli 0,45-0,55 millimetri l’anno.
Dal 1850 a oggi, si è registrata invece una nuova e rapida impennata con tassi medi che si attestano tra 1,1 e 1,3 millimetri l’anno come anche indicato dalle stazioni mareografiche più antiche del Mediterraneo a Genova, Marsiglia e Trieste.
© Riproduzione riservata