- I differenti corpi normativi che regolano il comportamento dei membri degli ordini religiosi durante i pasti in collettività sono consistenti e dettagliati.
- La storia del cristianesimo ci rivela che la condivisione della mensa ha rappresentato un momento di estrema importanza fin dalle origini.
- Gli esempi di benedettini e gesuiti raccontano di comportamenti che possono sembrare fuori dal tempo, ma lo sono davvero?
Vietato leccarsi le dita per i religiosi a tavola
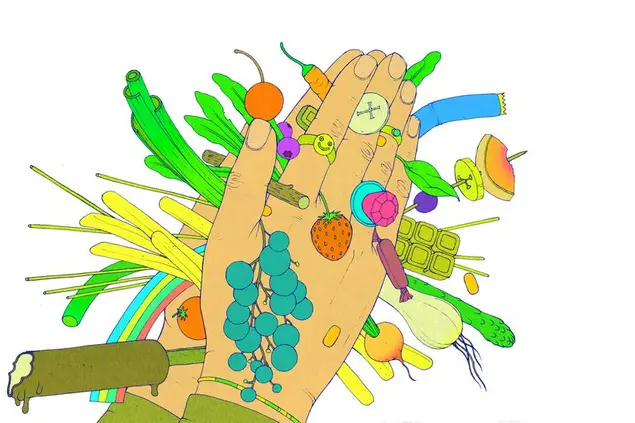
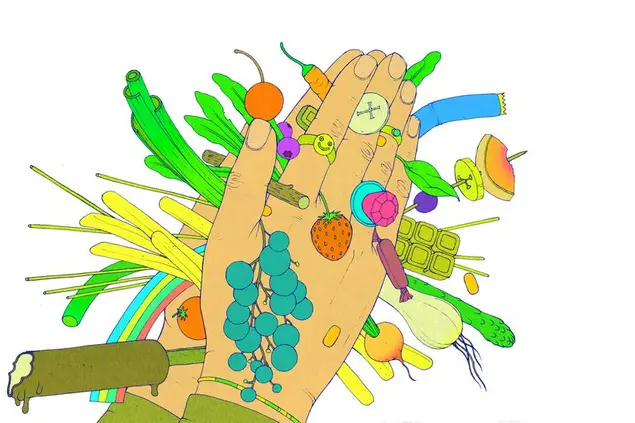
26 novembre 2022 • 15:00Aggiornato, 29 novembre 2022 • 11:19


