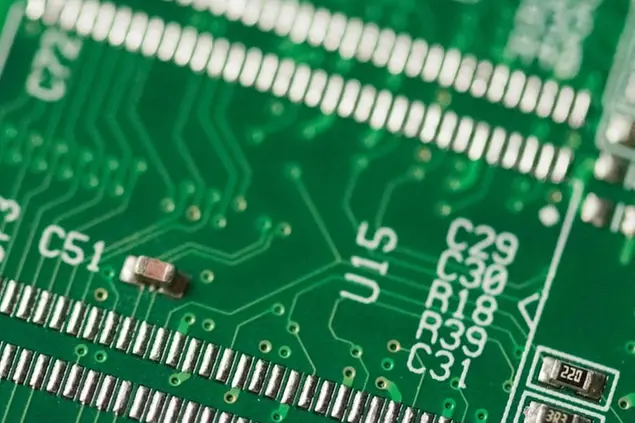- La funzione di alcuni software di ultima generazione è di affiancare se non addirittura di sostituire la figura dell’avvocato nella due-diligence sottesa a complesse trasformazioni societarie.
- Se certe mansioni, ritenute routinarie, potranno essere esternalizzate a un algoritmo, si dovrà ammettere, prima o poi, che è stato commesso qualche errore di (sopra)valutazione dei requisiti professionali fin qui richiesti per lo svolgimento di quelle stesse mansioni.
- La consacrazione della giustizia algoritmica passa per l’idea che ragionamento del giudice sia “programmabile”. Chi avrà il potere di scrivere l’algoritmo avrà anche in mano le sorti del processo, limitando l’orizzonte degli scenari rilevanti a fini decisori.
Prendo spunto dai pregevoli contributi dell’avvocato Bruno Giuffrè dello Studio DLA Piper di Milano e del professor Giovanni Pascuzzi dell’Università di Trento, apparsi entrambi il 5 febbraio su Domani, per tornare a riflettere sulle possibili ricadute dell’intelligenza artificiale sull’organizzazione della giustizia dentro e fuori i tribunali.
Sull’ultimo numero del NYU Journal of Law & Business è stato pubblicato un approfondimento dal titolo “Artificial Intelligence and the Vanishing Human Arbitrator”, scritto a quattro mani da Horst Eidenmuller e da Faidon Varesis, professore di diritto commerciale a Oxford il primo e fresco dottore di ricerca (PhD) a Cambridge il secondo. Quasi come su un sito di informazione comparativa, in questo articolo sono passate in rassegna – e, per l’appunto, comparate – le prestazioni rese da diversi prodotti informatici, attualmente disponibili sul mercato delle professioni legali, finalizzati a rendere più semplice la vita degli operatori del diritto: consulenti delle parti, conciliatori e decisori (siano essi giudici o arbitri).
Nella stessa Università di Cambridge lavora un gruppo di matematici che ha concepito un software, la cui funzione è di affiancare se non addirittura di sostituire la figura dell’avvocato, mediante tecniche di “apprendimento automatico”, nella revisione di contratti d’impresa e nella due-diligence sottesa a procedimenti di trasformazione societaria.
La prevedibilità è un’illusione
Va diffondendosi sempre più l’idea che alle macchine possa essere delegato lo svolgimento di mansioni umane ripetitive e dall’esito, per ciò stesso, prevedibile.
Non dispongo di argomenti idonei a contrastare i dubbi di chi si stia domandando se il mondo sia davvero arrivato al punto di vedere assegnate a un’applicazione informatica mansioni lavorative fino a oggi riservate a professionisti dagli ingaggi elevatissimi, non soltanto laureati ma anche in possesso di un titolo abilitante, preceduto e seguito da numerosi anni di pratica.
Un tentativo di risposta può svilupparsi lungo due diverse traiettorie.
Per un verso, se certi lavori potranno essere esternalizzati a una macchina programmata per l’esecuzione di mansioni routinarie, si dovrà ammettere, prima o poi, che è stato commesso qualche errore di (sopra)valutazione dei requisiti professionali fin qui richiesti per lo svolgimento di quelle mansioni. Se non altro, ciò avrebbe il merito di rendere più trasparente il processo di formazione del “valore aggiunto” sotteso alle parcelle concordate tra lo studio legale e il committente.
Per altro verso, lo sviluppo di tecnologie dirette allo snellimento delle mansioni simil-segretariali interne agli studi legali è un tema attinente al piano organizzativo e porta con sé la sempre allettante chimera di perseguire gli stessi risultati a costi e in tempi ridotti.
Giudicheranno i clienti
Tuttavia, come per qualsiasi scelta di riorganizzazione del lavoro, sarà il mercato – cioè i clienti – a determinare il successo o l’insuccesso dell’iniziativa. Alcuni, pur di ottenere un risparmio di spesa, saranno lieti di sapere che i contratti immessi nelle proprie imprese saranno revisionati da algoritmi programmati da un matematico. Altri clienti, invece, pretenderanno tutte le cautele di un essere pensante (in grado, per esempio, di riconoscere, nell’ambito di un trasferimento di azienda, i contratti stipulati per l’esercizio dell’attività d’impresa che, ai sensi dell’art. 2558 del codice civile, sono destinati a subentrare automaticamente nella titolarità dell’acquirente, enucleando i «debiti puri» che, salvo patto contrario, dovrebbero rimanere in pancia al cedente). E spetterà allo studio legale giustificare l’eventuale differenza di prezzo per la medesima prestazione, con o senza componente automatizzata.
Senza sottovalutare che alla base della diffusione di consimili strumenti di “intelligenza artificiale” potrebbero esserci ragioni del tutto slegate dal merito (come ad esempio il puro gusto dell’avvocato-imprenditore verso il “nuovo” o il desiderio di seguire l’onda del “così fan tutti” o, ancora, il timore di accaparrarsi l’ultimo ritrovato della tecnica in ritardo rispetto ai concorrenti), conviene ora uscire dalla logica aziendalistica sottesa a queste iniziali riflessioni e provare a dar voce alle ragioni di fondo che inducono a guardare con sospetto l’avanzata della c.d. giustizia algoritmica, specialmente in ambito civile.
L’anticamera della banalizzazione
Un elaboratore, per funzionare, ha bisogno di input espressi in un linguaggio standardizzato e richiede pattern di sviluppo, per l’appunto, routinari. Se volessimo estendere questo modus operandi al processo ordinario, dovremmo accettare che il ragionamento del giudicante sia “programmabile”, cioè riducibile a una più o meno corposa check-list di elementi il cui completamento sia preordinato a produrre un (pre)determinato output. Ciò porta con sé il rischio che nuove argomentazioni di parte, ove non perfettamente incasellabili in uno dei riquadri preconfezionati nella check-list in mano al giudice-robot, siano destinate a rimanere per ciò stesso escluse dal percorso di accertamento della verità (processuale), indipendentemente dal loro peso probatorio specifico. In questo modo la procedura vince sulla sostanza, che non mi pare un grande omaggio alla giustizia.
In fin dei conti, chi si occupa di programmare il ragionamento del giudice (check-list) ha in mano le sorti del processo, individuando ex ante quali tasselli probatori possono condizionarne l’esito, con esclusione di qualsiasi altro. Se, da un lato, la procedimentalizzazione del discorso giuridico fornisce un evidente contributo in termini di prevedibilità, dall’altro essa stessa si risolve in una pressoché arbitraria limitazione dell’orizzonte degli scenari rilevanti a fini decisori.
Non è mai una sola regola
Ma c’è una ragione – se si vuole – ancor più pregante per ritenere resistibile l’ascesa della giustizia algoritmica. Si tratta del difficile connubio tra la chiarezza dell’enunciato normativo (indispensabile punto di partenza di un’elaborazione algoritmica con finalità predittive) e la tecnica dell’interpretazione. Accedendo alle teorie più illuminate sull’ermeneutica giuridica, al centro di qualsiasi elaborazione è la Costituzione repubblicana e il costante bisogno di stabilire ragionevoli relazioni di compatibilità tra le regole di dettaglio e i principi-cardine dell’ordinamento. Non c’è mai una sola regola a disciplinare un fatto. Quando si dice “applicare la legge”, in realtà non s’intende la legge in senso stretto, bensì l’attuazione dell’ordinamento giuridico ormai italo-europeo nella sua complessità valoriale e unitarietà (Perlingieri). A tal fine un algoritmo non serve a molto: occorre una solida formazione giuridica faticosamente costruita con lo studio.
Un esempio, per chiudere. L’art. 129 del codice di procedura civile vieta di presenziare alle udienze a capo coperto. Sarà difficile far capire a un algoritmo che se l’avvocato di parte è una donna di fede musulmana (o una suora) l’unico modo per garantire il rispetto della legge è la disapplicazione della regola…
© Riproduzione riservata