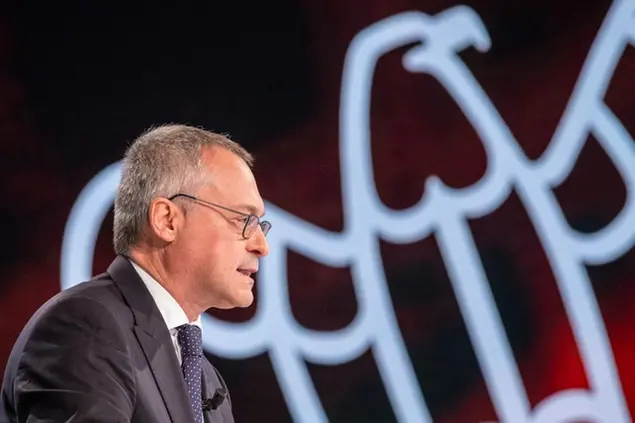- L’Italia è al 23esimo posto su 34 paesi dell’Ocse per il livello delle retribuzioni, che negli ultimi vent’anni sono rimaste ferme mentre in Francia e Germania sono cresciute rispettivamente del 21,5 e al 17,7 per cento
- Gli imprenditori dicono che il costo del lavoro da noi è alto, ma non è vero: nel 2022 era pari a 29,4 euro all’ora, contro una media europea di 30,5 euro all’ora. E per cuneo fiscale siamo al quinto posto in Europa, non siamo i peggiori
- È anche discutibile la tesi secondo cui le responsabilità è della scarsa produttività: si può dimostrare che una politica salariale poco attenta alle esigenze dei lavoratori rende le imprese meno innovative
Le difficoltà degli enti locali a realizzare i progetti finanziati dal Pnrr, la bassa natalità, la fuga dei giovani laureati all’estero, gli affitti inavvicinabili.
Fenomeni diversi ma legati da uno stesso filo conduttore: gli stipendi degli italiani sono troppo bassi. Il risultato è che i bandi dei comuni vanno deserti perché le retribuzioni offerte ad architetti e ingegneri sono fuori mercato, alberghi e ristoranti sono a corto di dipendenti e le aziende cercano inutilmente tornitori, saldatori o autisti. Gli imprenditori si lamentano della presunta scarsa voglia di impegnarsi dei giovani. I vari presidenti di Confindustria si susseguono a invocare un taglio dal cuneo fiscale.
E se gli si chiede perché i salari degli italiani non crescono la risposta è sempre la stessa: colpa della produttività che non aumenta. Quindi lo stato deve ridurre le tasse e i dipendenti lavorare di più. Ma forse è il momento di chiedersi se una parte della responsabilità non sia proprio degli industriali. E se la produttività non salga a causa delle paghe basse, e non viceversa.
La mappa dei salari
L’Osservatorio sui salari realizzato dalla società JobPricing sottolinea che «le retribuzioni medie degli italiani sono fra le più basse nei paesi del gruppo Ocse. Nella classifica 2021, la più aggiornata disponibile, l’Italia si colloca al 23esimo posto su 34».
All’interno dell’Eurozona, l’Italia si piazza all’11esimo posto su 17 paesi. Secondo calcoli della Fondazione Di Vittorio della Cgil, un lavoratore italiano in media guadagna 29.440 euro lordi, più di uno spagnolo (27.404 euro), ma molto meno di un francese (40.170) e di un lavoratore tedesco (44.468). L’Osservatorio di JopPricing mostra che i salari reali degli italiani dal 2000 ad oggi sono rimasti sullo stesso livello mentre in Francia e Germania sono cresciuti rispettivamente del 21,5 e al 17,7 per cento. Un quadro che si è aggravato con il riaccendersi dell’inflazione: nel 2022, a fronte di un carovita salito del 7 per cento, le retribuzioni sono salite solo del 4.
C’è chi obietta che il costo della vita in Italia è più basso rispetto alla Germania e alla Francia. È vero, ma non nelle grandi città e soprattutto non a Milano. Se si consulta il sito Numbeo con il suo database sul costo della vita nel mondo, si legge che nel capoluogo lombardo l’affitto mensile di un monolocale in centro si aggira sui 1.300 euro al mese, come a Berlino e più di Parigi.
E per un pasto in un ristorante economico si spendono in media 20 euro, contro i 15 di Parigi e i 12 di Berlino. Peccato però che lo stipendio mensile netto medio a Milano sia di 1.718 euro mentre a Berlino sfiori i tremila euro e a Parigi superi i 2.600 euro. Non si capisce quindi perché nella capitale italiana della finanza, del design e del lusso le paghe siano così lontane da quelle di Parigi o di Berlino.
Le false verità sul costo del lavoro
Gli imprenditori sostengono che il costo del lavoro è alto e che gli stipendi netti sono bassi per colpa del cuneo fiscale, cioè dell’insieme di imposte e contributi che gravano sulle retribuzioni lorde. Intanto non è vero che il costo del lavoro in Italia è elevato: le statistiche di Eurostat mostrano che nel 2022 era pari a 29,4 euro all’ora nel nostro paese, contro una media europea di 30,5 euro all’ora. In Francia il costo del lavoro orario supera i 40 euro, in Germania è di 39,5 euro.
Dunque siamo competitivi per i prezzi e non per la qualità? Forse sì: l’impressione è che ci siano ancora tante imprese, piccole e medie, legate ad un modello primitivo, convinte che la competizione si vinca abbassando i prezzi e di conseguenza i costi. Un modello perdente, a lungo termine. Anche sul peso del cuneo fiscale non siamo i peggiori d’Europa.
Se è vero che con un cuneo fiscale del 46,5 per cento (in calo dopo gli interventi dei governi Draghi e Meloni) l’Italia è ben al di sopra della media Ocse, pari al 34,6 per cento, è comunque al quinto posto in Europa dopo Belgio, Germania, Austria e Francia. Del resto è difficile che un paese ad alto debito, con molti pensionati, che tassa poco il patrimonio e con tanta evasione possa avere un cuneo molto più basso.
Mancanza di materia prima
Per quanto riguarda la mancanza di lavoratori, è un problema diffuso in tutta Europa. E anche qui c’entrano gli stipendi e le condizioni di lavoro. Wouter Zwysen, ricercatore senior presso l’European Union Institute (Etui) di Bruxelles, ha affrontato il tema in un recente studio in cui scrive: «Il problema è trovare persone che siano disposte a fare questi lavori faticosi per una paga così bassa e in condizioni così cattive. Ma il dibattito politico è dominato principalmente dalle narrazioni di una discrepanza nelle competenze e della necessità di incentivare una maggiore mobilità e migrazione. La carenza di manodopera è chiaramente aumentata di più tra i lavori con una retribuzione relativamente più bassa».
Anche la bassa natalità è, in parte, una conseguenza degli stipendi bassi: nel Report FragilItalia La crisi demografica italiana, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, gli intervistati indicano come principali cause della crisi della natalità gli stipendi bassi e l’aumento del costo della vita (70 per cento), seguiti dall’instabilità lavorativa e nella precarizzazione del lavoro e dalla mancanza di sostegni pubblici per i costi da affrontare per crescere i figli.
Produttività e innovazione
E veniamo alla presunta responsabilità della scarsa produttività degli italiani. Come si legge nell’Osservatorio sui salari di JobPricing, «il dibattito economico sulla dinamica salariale italiana, non proprio positiva a confronto con altri paesi europei, attribuisce le cause principalmente ad una questione di differenze di produttività.
Per quanto questa sia una tematica complessa e influenzata da fattori interdipendenti, la teoria economica concorda sul fatto che la produttività̀in Italia risenta prevalentemente di alcune debolezze, tra cui, ad esempio, una competitività sempre minore dell’industria italiana, la struttura del tessuto economico e imprenditoriale italiano, composto in maniera preponderante da micro e piccole imprese, la presenza di un sistema produttivo basato su un livello tecnologico tutt’altro che all’avanguardia e un alto grado di inefficienze normative e giudiziarie».
Quindi, come dice Alessandro Fiorelli, amministratore delegato di JobPricing, «non è colpa dei lavoratori se la produttività non cresce, ma degli imprenditori che investono poco. Troppe aziende vedono la retribuzione come un costo e non come un investimento».
Una tesi condivisa da Michele Raitano, professore di Politica economica alla Sapienza, secondo il quale c’è un ampia letteratura che mostra come tenere bassi i salari disincentiva le imprese a spostarsi verso attività più avanzate e innovative.
Risparmiare sul costo del lavoro sarebbe perciò una visione miope che condannerebbe un sistema economico verso la bassa produttività.
Naturalmente non tutte le aziende hanno questa visione antiquata. Ci sono molte imprese italiane che investono sui propri collaboratori e che li considerano una risorsa fondamentale, come ricorda Beniamino Bedusa, presidente e socio di Great Place to Work, società di ricerca e consulenza che interroga i dipendenti per capire come migliorare le condizioni di lavoro. «Non è raro incontrare aziende dove quattro lavoratori su cinque sono contenti» afferma Bedusa, che per una ventina d’anni è stato direttore delle risorse umane in grandi imprese.
«E anche tra le piccole e medie società troviamo imprenditori attenti alla soddisfazione del personale. Il problema è che molte aziende sono frenate da un sistema poco flessibile e incerto, che disincentiva una politica salariale più generosa». Per esempio, se un’impresa che ha investito sulla crescita del personale entra in difficoltà e intende chiudere il rapporto con uno o più dipendenti, non sa quali costi dovrà affrontare. Ed è praticamente impossibile sostituire una risorsa poco produttiva con un lavoratore più bravo. «Il Jobs Act aveva provato a definire il costo del recesso» aggiunge l’avvocato giuslavorista Attilio Pavone «ma la Corte costituzionale ne ha chiesto una revisione.
Certamente per le aziende sarebbe utile avere un’idea dell’importo dell’indennità dovuta in caso di licenziamento». Per Pavone, inoltre, «tra i motivi che dovrebbero indurre le aziende a pagare di più i dipendenti c’è il tema di come trattenere le risorse migliori».
Si possono aumentare?
Un aumento degli stipendi rappresenta una minaccia perché alimenta l’inflazione? Sarà. Ma di recente un articolo comparso sul blog della Banca centrale europea dice una cosa diversa: sono stati i grandi utili delle imprese europee ad aver scaldato il carovita, non gli stipendi.
E riguardo al rischio di mettere fuori mercato le imprese con retribuzioni più alte, Fiorelli di JobPricing sostiene che lo spazio c’è: «Le aziende possono investire di più sul personale usando non solo la leva dello stipendio ma anche quella dei benefit e del bilanciamento tra vita lavorativa e privata. Otterrebbero una maggiore motivazione, più produttività e anche un personale più fedele». Ma sganciarsi da un modello economico che oscilla tra l’eccellenza della Ferrari e la convenienza della Panda, senza avere in mezzo una solida Golf, non è facile.
© Riproduzione riservata