- Una riforma del sistema pensionistico dovrebbe affrontare un problema strutturale, quello della differenziazione delle età di pensionamento in base al lavoro svolto.
- I poveri muoiono prima dei ricchi, sia perché hanno con maggiore probabilità affrontato maggiori difficoltà e lavori usuranti e gravosi, sia perché le loro condizioni economiche non hanno consentito una vita accompagnata da tutele, prevenzione e migliori cure, anche nello stato di pensionati.
- Il risultato sul fronte dei bilanci pensionistici è paradossale: lavoratori poveri che hanno una “vita pensionistica” più breve rispetto all’aspettativa media di vita che determina il rateo pensionistico sui propri contributi versati, finanziano di fatto in parte le pensioni dei ricchi, che vivono più a lungo.
Vedo un unico traino possibile per garantirci un futuro come società e come economia avanzata: aumentare la quantità di lavoratori e la qualità del lavoro.
Il tasso di occupazione decide la sostenibilità del sistema pensionistico di oggi e l’equilibrio delle pensioni di domani, ovvero il futuro dei lavoratori. Il lavoro di oggi, infatti, determina la pensione di domani.
Questo vale sia per l’aspetto monetario individuale, e quindi il salario di un lavoratore di oggi determinerà il suo assegno pensionistico domani, sia per gli aspetti macroeconomici e di sostenibilità collettiva.
Ci chiediamo se i giovani di oggi prenderanno la pensione e quando, se la flessibilità del lavoro sia una opportunità o più spesso diviene una trappola di precarietà, se il salario sia davvero commisurato all’impegno richiesto al lavoratore.
Non si riflette abbastanza sul fatto che a fronte di un lavoro povero e saltuariamente retribuito, corrisponderanno pensioni povere; che il trend demografico imporrà uno sforzo pubblico ulteriore sul fronte dell’assistenza; e che durante la transizione demografica, tra tassi di uscita più accelerati verso le pensioni e tassi di entrata nel mercato del lavoro più lenti, lo squilibrio aumenta.
Ecco perché ogni intervento sul mercato del lavoro e ancor più sulle pensioni deve essere guidato da una “veduta lunga”.
Pensioni povere
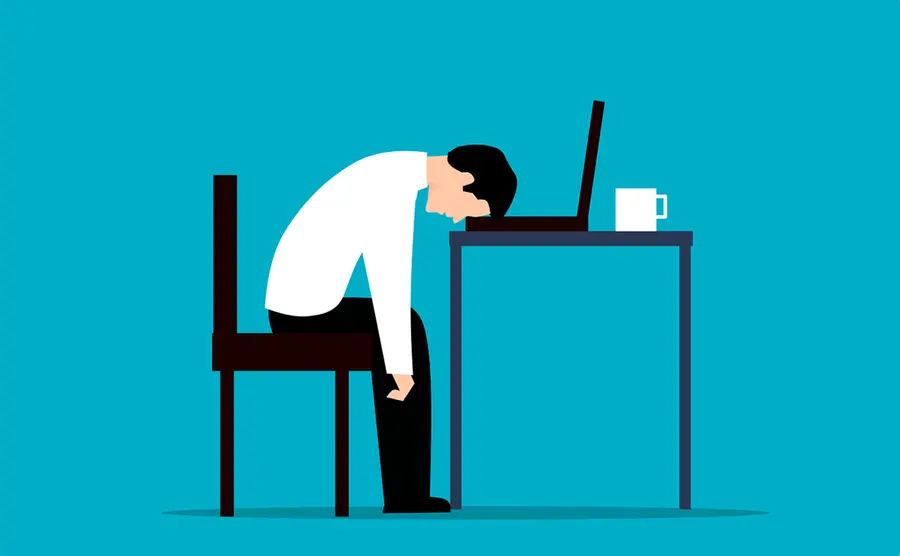
Nel ragionare su necessarie flessibilità in uscita anticipata dal mercato del lavoro, una riforma del sistema pensionistico dovrebbe affrontare un problema strutturale, quello della differenziazione delle età di pensionamento in base al lavoro svolto.
I poveri muoiono prima dei ricchi, sia perché hanno con maggiore probabilità affrontato maggiori difficoltà e lavori usuranti e gravosi, sia perché le loro condizioni economiche non hanno consentito una vita accompagnata da tutele, prevenzione e migliori cure, anche nello stato di pensionati.
Il risultato sul fronte dei bilanci pensionistici è paradossale: lavoratori poveri che hanno una “vita pensionistica” più breve rispetto all’aspettativa media di vita che determina il rateo pensionistico sui propri contributi versati, finanziano di fatto in parte le pensioni dei ricchi, che vivono più a lungo.
Negli ultimi 30 anni, tutti gli indicatori di disuguaglianza sono peggiorati: la disparità dei redditi annuali è cresciuta di quasi il 50 per cento (la varianza è passata da 0,48 nel 1985 a 0,72 nel 2018) così come la disuguaglianza salariale che è quasi raddoppiata (da 0,24 nel 1985 a 0,44 nel 2018), e la quota del reddito detenuta dall’1 per cento meglio pagato negli ultimi 10 anni è passata dal 6,5 per cento al 7,5 per cento, mentre quella detenuta dal 50 per cento meno pagato è passata dal 23 per cento al 18 per cento.
Le donne continuano a registrare dei salari inferiori del 25 per cento rispetto ai maschi, in media, e i giovani (under 35enni) nel 36 per cento dei casi hanno salari poveri, contro il 16 per cento degli over 35.
Oggi stimiamo un livello di lavoro nero che interessa ben oltre 3 milioni di persone, mentre i dati “in chiaro” ci parlano di circa il 13 per cento di “working poors”, lavoratori con salari lordi che non arrivano a 7 euro l’ora e che non raggiungono livelli retributivi dignitosi.
Il che si rifletterà sulle loro pensioni povere: i lavoratori che oggi stanno sotto i 9 euro lordi l’ora sono 4,3 milioni, e stimiamo che con 30 anni di contribuzione avranno una pensione di 750 euro circa.
In questo contesto occorre una riflessione più matura sia sul reddito minimo sia sul salario minimo, due concetti diversi anche se legati.
Inoltre, l’attuale contesto inflattivo ha un impatto negativo non solo sul potere d’acquisto dei lavoratori, che viene eroso, ma anche sulla sostenibilità dei conti pensionistici.
Per avere sempre l’equilibrio e la sostenibilità necessaria, non solo è importante spingere in alto il tasso di occupazione e combattere il lavoro nero, e quindi l’evasione contributiva, ma anche prevedere la giusta proporzionalità tra incrementi di salari monetari e adeguamenti di pensione.
Oggi, mentre queste ultime vengono adeguate, seppure in maniera decrescente al crescere dell’assegno pensionistico, i salari sono fermi, incidendo negativamente sulla crescita economica presente e sulla sostenibilità futura.
Più lavoratori
Aumentare il numero dei lavoratori attivi in Italia rimane dunque fondamentale. Abbiamo 3 milioni di cosiddetti Neet, persone che non lavorano e non studiano, e tassi di occupazione di giovani e donne nel Sud che sono la metà di quelli del Nord.
Anche se il tasso di occupazione sembra aver avuto di recente un miglioramento, salendo di poco al disopra del 60 per cento, il numero dei lavoratori in termini assoluti in Italia è diminuito: nel 2019 erano oltre 22,4 milioni, nel 2022 sono 22,2 milioni.
Questo anche perché si restringe la “platea” dei lavoratori attivi tra i 15 e i 64 anni, sia a causa della più bassa natalità e dell’invecchiamento della popolazione, sia perché la “fuga dei cervelli” o semplicemente dei giovani incide in modo costante sulle statistiche.
Il paradosso è che dal Sud (ma anche dal Nord) continuiamo ad avere una fuga di cervelli verso l’estero, e ciò a fronte di posti vacanti che non vengono occupati.
Il problema non è dunque solo un eccesso di offerta di lavoro, e quindi disoccupazione, ma anche incapacità di domanda di attirare competenze su posti vacanti esistenti, che vengono invece attratte da migliori condizioni e salari all’estero.
Proprio quest’ultimo fattore è un campanello d’allarme della nostra scarsa attrattività e produttività nel mercato del lavoro, portando a chiederci quanto siamo disposti a fare per aumentare i salari e investire in innovazione, creare lavoro di qualità e crescita delle competenze.
La nostra economia ha ancora una quota troppo elevata di lavoratori in settori di servizi a scarsa innovazione e produttività come ristorazione, logistica, guardiania, turismo, cura delle persone, con scarse capacità di crescita rispetto alla qualità dei prodotti offerti.
Non è un caso se i salari medi in Italia sono fermi da più di 30 anni, anzi sono diminuiti in media del 2,9 per cento.
Verso il lavoro buono
Occorre un massiccio investimento in innovazione e formazione delle competenze, e manca l’attenzione a remunerare un lavoro di qualità fornendo strumentazione che consenta il decollo di nuove capacità, e quindi di maggiore produttività.
Se si continua a fare competizione attraverso il costo del lavoro e la “flessibilità”, anziché tramite l’innovazione, anche in questi settori maturi, a rischiare non sono solo le pensioni di domani, ma anche la capacità di crescita dell’economia nazionale.
In questo contesto di bassi salari e precarietà, di declino demografico e nuovi bisogni di supporto sociale deve essere letta l’evoluzione dell’INPS negli ultimi anni.
Da ente previdenziale, conosciuto come l’ente che paga le pensioni, è diventato un ente più grande e più complesso, una vera Agenzia del Welfare nazionale, con una accresciuta vocazione verso l’assistenza, il sostegno al reddito, il sostegno alla famiglia ai figli, ai lavoratori tutti (autonomi, collaboratori, intermittenti e precari, oltre che subordinati), e ai pensionati, sempre più numerosi, in una visione più universalistica del welfare.
Di questo e di altro ho voluto trattare nel libro Il lavoro di oggi, la pensione di domani, scritto insieme a Enrico Marro per Solferino editore: per ricordare il fondamentale nesso tra il “lavoro buono”, di cui abbiamo bisogno per mantenere la stabilità del sistema di welfare, e il futuro pensionistico; ma anche per far conoscere meglio l’evoluzione e l’innovazione dell’Inps, un grande ente che interessa con i suoi servizi l’intera economia del Paese, che accompagna ciascun cittadino in ogni fase della vita. Il futuro del lavoro passa necessariamente da un nuovo Stato sociale.
© Riproduzione riservata


