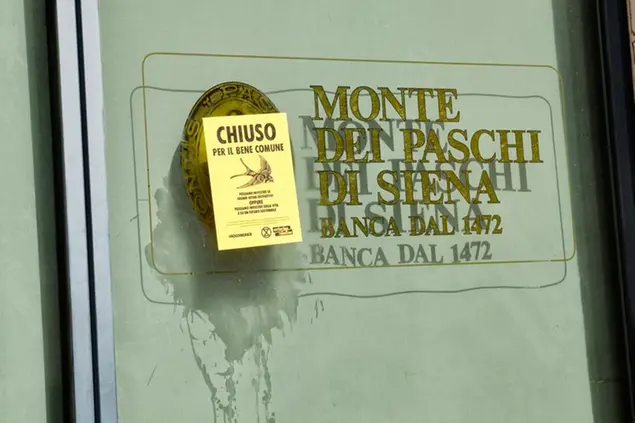- Il problema di Mps viene da lontano: è la coda della crisi globale dei sistemi bancari, figlia della recessione del 2008, e mai risolta definitivamente in Italia.
- Dopo il crollo di Lehman Brothers, il governo americano ha capito che di fronte a una crisi sistemica le risorse doveva intervenire direttamente ricapitalizzando le banche.
- Nel caso di Mps il governo ha dato, invece del capitale, un prestito estremamente oneroso: così, invece di risanare la banca, l’ha gravata dell’onere di ripagare prestito e relativi interessi. Rinviare il problema non ha fatto altro che ingigantirlo.
Mps non deve diventare un’altra Alitalia. Si deve smettere di iniettare capitali pubblici in aziende senza prospettive, anche a costo di pagarne il prezzo in termini di consenso.
Rinviando le scelte politicamente difficili, si finisce solo per pagare di più, senza nemmeno salvare i posti di lavoro, ammesso che tenere in vita imprese decotte sia un modo efficiente di gestire il welfare. Per lo Stato è arrivato il momento di uscire da Mps e saldare il conto, anche se indigesto e impopolare. Per capirlo bisogna fare un passo indietro.
L’origine del disastro
Il problema di Mps viene da lontano: è la coda della crisi globale dei sistemi bancari, figlia della recessione del 2008, e mai risolta definitivamente in Italia. Dopo il crollo di Lehman Brothers, il governo americano ha rapidamente capito che di fronte a una crisi sistemica le risorse richieste per i salvataggi bancari eccedevano le capacità del mercato dei capitali privati, ed è intervenuto direttamente ricapitalizzando le banche. Perché un’economia di mercato non sopravvive se collassa il sistema dei pagamenti e del credito.
L’Europa l’ha capito tre anni dopo, e come negli Stati Uniti, tutti i governi sono intervenuti ricapitalizzando le loro banche, anche se in ordine sparso poiché non c’erano istituzioni per la gestione comunitaria delle crisi.
Chi non aveva le risorse, come Spagna, Irlanda, o Portogallo, le ha chieste al Mes, accettando la condizionalità dei suoi prestiti. Unica eccezione l’Italia, dove vari governi, non avendo le risorse, ma non volendo subire le condizioni del Mes, hanno preferito - come al solito - tirare la palla avanti.
Nel caso di Mps il governo ha fatto anche di peggio dandogli, invece del capitale, un prestito estremamente oneroso: così, invece di risanare la banca, l’ha gravata dell’onere di ripagare prestito e relativi interessi. Rinviare il problema non ha fatto altro che ingigantirlo.
Nel 2015 l’Europa ha creato la Vigilanza unica e varato la normativa per risoluzioni bancarie. Avendo considerata chiusa la stagione dei salvataggi pubblici, la normativa non contempla la possibilità di nuove crisi sistemiche, imponendo così l’onere dei dissesti interamente sui privati (azionisti, detentori di subordinati, obbligazioni e, eventualmente, grandi depositi).
L’Italia, non avendo voluto affrontare la crisi delle sue banche, si è trovata in mezzo al guado: la crisi era sistemica, quindi il privato non poteva sopportarne l’onere da solo, ma l’Europa aveva chiuso la porta all’intervento pubblico.
I privati in molti casi sono stati comunque spazzati via, anche in banche formalmente non in dissesto (dal 2007, per esempio, i soci di Unicredit e Banco Popolare, hanno perso il 93 per cento); e lo Stato alla fine è dovuto intervenire, ma ingegnandosi per infilarsi tra le pieghe delle norme: con l’Amco, lo Stato ha rilevato le sofferenze a valori superiori a quelli di mercato (da Banche Venete, Carige o Mps), e fornito garanzie a pioggia con le Gacs (in entrambi i casi, spalmando nel tempo il costo degli interventi); finanziato con crediti di imposta l’acquirente di banche in dissesto (Marche, Etruria, Cesena); aggirato la normativa europea (usando la legge nazionale sulle liquidazioni) per dotare Intesa dei fondi per assorbire le Venete; nazionalizzato la Popolare di Bari; e per Mps una massiccia ricapitalizzazione precauzionale a carico dello Stato, una scappatoia, peraltro prevista dalla norma, visto che gli aumenti di capitale “precauzionali” non esistono: una banca, o è in deficit di capitale, oppure no.
Ritorno al punto di partenza
Quattro anni dopo l’aumento “precauzionale”, e dopo che gran parte delle sofferenze sono state scaricate su Amco, siamo al punto di partenza: o si ricapitalizzata ancora con soldi pubblici, e si tira la palla avanti senza risolvere nulla, o si vende.
Per farlo, lo Stato dovrà incentivare il compratore, ma sarà l’ultimo conto da pagare. Anche se l’impegno di uscire da Mps preso con la Commissione non pare cogente in questo momento, l’opzione di ricapitalizzare e rinviare è la peggiore delle opzioni.
I tassi Bce negativi ancora a lungo, e la curva dei rendimenti piatta, impediranno un aumento del margine di interesse. La crisi da Covid farà riapparire le sofferenze (un quarto dei prestiti di Mps sono in moratoria o con garanzia statale, e rimangono 4 miliardi di vecchie sofferenze lorde) che la banca senese non potrebbe sostenere.
La struttura dei costi è eccessiva, ma non ci sono le risorse per far fronte agli oneri di ristrutturazione, né, a differenza di un compratore, può utilizzare il negative goodwill per coprirli (la differenza tra il patrimonio contabile e il minor prezzo pagato), come Intesa con Ubi. Come non potrebbe beneficiare di ben 3,7 miliardi di attività fiscali.
Per dare un’idea del problema, ho confrontato i cash flow di Mps con quelli di Intesa, ovvero i ricavi della gestione ordinaria, meno salari e costi generali, al netto di un’aliquota normale di tassazione (27 per cento); epurando dal confronto tutte le poste valutative e di natura straordinaria (come ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) e quelle variabili (come i profitti da trading o l’uso di crediti di imposta) per renderlo omogeneo.
Usando queste grandezze, Mps ha un rapporto costi/ricavi del 73 per cento e un rendimento sul capitale del 6,5 rispetto, rispettivamente, al 50 e 9 di Intesa. Mps genera circa 67.000 euro di commissioni per dipendente contro i 92.000 di Intesa: per raggiungere la produttività di Intesa, oltre a dotarsi dei prodotti che non ha, dovrebbe, per esempio, tagliare i dipendenti del 27 per cento.
Vendere non è facile
Anche vendere è un’opzione molto costosa per lo Stato. Prima di tutto non ci sono compratori: i fondi non possono utilizzare attività fiscali e negative goodwill; le banche estere non ci sono o già impegnate (Credit Agricole con Credito Valtellinese); Bpm è troppo piccola, e Bper deve integrare gli sportelli acquisti da Ubi. Rimarrebbe Unicredit, che però ha già detto no.
Ma negli affari c’è sempre un prezzo per tutto; e Unicredit ha il potere negoziale dalla sua parte.
Lo Stato dovrebbe scorporare e accollarsi i rischi legali lievitati a 5,1 miliardi, di cui 3,8 sono però richiesti dalla Fondazione, che da azionista di controllo ha portato la banca allo sfascio (oltre ad essere sorvegliata proprio dal Mef); e moralmente non può sottrarsi alla responsabilità dei bilanci della banca, avendone sempre di fatto controllato la governance.
Ci sarebbero tanti modi per farlo. Per i costi di ristrutturazione il compratore potrebbe contare su 4 miliardi stimabili di negative goodwill, quota 100 (usata anche da altre banche) e qualche ammortizzatore sociale ad hoc. E usufruire dei 3,7 miliardi di attività fiscali di cui Mps non può beneficiare.
Il costo per lo Stato sarebbe salato, ma sarebbe anche l’ultimo. Per non rischiare di pagare domani più di quanto si potrebbe oggi. E mettere finalmente la parola fine alla crisi sistemica del nostro sistema bancario.
© Riproduzione riservata