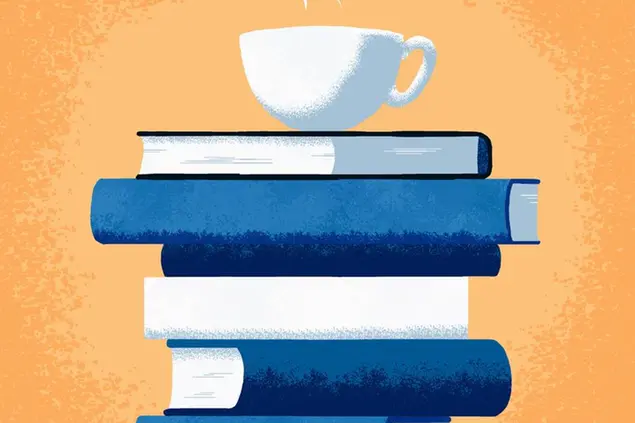Ogni storia ha un finale, ma per molti autori è difficile accettare che possa esaurirsi anche l’ispirazione. Si dovrebbe architettare un’uscita di scena in gran stile, nel massimo dell’ispirazione. Ma solo pochi ci riescono
Parlando delle carriere degli scrittori e della loro tendenza a durare più del dovuto, la romanziera canadese Margaret Atwood una volta mi ha detto: «Vorrei che accanto a me ci fosse un amico abbastanza caro da dirmi sinceramente quando la mia scrittura sta cominciando a declinare. Parliamoci chiaro: al punto in cui sono, se copiassi un elenco del telefono me lo pubblicherebbero».
È un’oggettività che molti non hanno, e sempre più spesso ci si trova assistere al declino dei grandi scrittori senza sapere bene cosa fare e con la disarmante sensazione che nemmeno la critica più sinceramente brutale potrebbe porre fine al doloroso corso degli eventi. Verrebbe presa come un atto di lesa maestà o di cattiveria nei confronti di una carriera avviata alla risoluzione.
E così, si trovano ovunque perifrasi che aggirino abilmente il problema e articoli che sintetizzino intere produzioni letterarie per non prendersi la briga di concentrarsi sull’ultimo, deludente, a volte imbarazzante, lavoro pubblicato. Come se non bastassero i recuperi postumi compiuti contro la volontà degli scrittori che in vita hanno ceduto all’impudenza di conservare i propri lavori meno riusciti in un cassetto, anziché affidarli a un cestino.
Gli ultimi giorni
Nel suo ultimo saggio, Gli ultimi giorni di Roger Federer – pubblicato dal Saggiatore per la traduzione di Katia Bagnoli – Geoff Dyer si occupa proprio del problema della fine: la fine delle carriere, la fine delle vite, i finali di film, libri e partite.
A volte la fine è grandiosa, un gran finale, un’esplosione accecante; altre è solo il frutto di una terribile corrosione, del consumarsi tedioso di un accanimento.
Mi è capitato di chiedere a Philip Roth, qualche anno dopo il suo celebrato ritiro, quale fosse l’aspetto che preferiva della sua nuova condizione di pensionato: «Non dovermi appoggiare alla scrivania ogni giorno a fissare una pagina vuota», ha risposto in maniera solo leggermente più colorita. «Ho visto troppi miei coetanei insistere contro un’ispirazione che non veniva più, per non rendermi conto che osservare un vecchio che cerca di rimanere giovane è uno spettacolo increscioso».
Dyer cita Jack Kerouac che ironizza sulla famosissima stroncatura ricevuta da Truman Capote: «Ultimamente non scrivo tanto bene», pare che abbia detto nei suoi ultimi anni di vita. «E nemmeno a battere a macchina me la cavo più».
Parlando di carriere santificate, quella di Kerouac è certamente una delle più contestabili: tolta la benzedrina e passato lo slancio di Sulla strada, il re dei beat era rimasto solo con la sua voglia di piantare tutto e la spinta creativa che si affievoliva sempre di più, indipendentemente da quanto provasse a invocarla.
Se ne rendeva conto – nota Dyer prendendosi la briga di mettere nero su bianco ciò che certamente molti hanno pensato ma in pochi hanno osato dire – ma ha ceduto alla pressione editoriale che gli concedeva di pubblicare quanti elenchi del telefono volesse.
Il rischio del ritorno
Negli ultimi mesi, per qualche scherzo del destino, la concentrazione delle pubblicazioni di fine carriera si è fatta ingente: se ne è andato Martin Amis, lasciando una specie di testamento letterario e umano nel suo ultimo La storia da dentro; Cormac McCarthy ci ha lasciati con la coppia di romanzi Il passeggero e Stella Maris (che in Italia uscirà postumo); è morta la fumettista Rachel Pollack, il poeta Russel Banks, perfino Alan Arkin e Richard Belzer sono usciti di scena lasciandosi dietro qualche pagina.
In alcuni di questi casi la fine, improvvisa o meno ma sempre prematura, ha lasciato i lettori storditi di smarrimento, in altri ha fatto tirare ai critici un sospiro di sollievo. Come scrive di nuovo Dyer, riferendosi al tennista Boris Becker: «A volte dietro una fine spettacolare, è in agguato uno spaventoso ritorno».
Il fatto di non dover temere un nuovo afflato di presunta ispirazione incontenibile che possa ravvivare una carriera ormai consunta, è decisamente un buon motivo per dormire sonni tranquilli.
Tenersi allenati
Il romanziere John Updike, che si sarebbe potuto definire a tutti gli effetti un grafomane impenitente, pur di non rinunciare alla sua dose giornaliera di battute ha passato gli ultimi tempi prima della sua morte, avvenuta nel 2009 a settantasette anni, a scrivere di golf e dei viaggetti che si concedeva con la sua ultima moglie, Martha.
Quando il biografo Adam Begley gli ha chiesto: «Non sei stufo?», Updike ha risposto: «Mi sono stufato appena ho finito il mio primo romanzo, ma poi ho scoperto l’automatismo. Ogni tanto scrivo qualcosa che penso davvero, ogni tanto no, l’importante è non smettere mai di allenarmi, altrimenti rischierei di non trovare le forze quando mi viene in mente qualcosa di veramente significativo».
Il punto, in effetti, è che piuttosto che smettere di scrivere, occorrerebbe in certi casi smettere di pubblicare. Per molti scrittori la teoria di Updike, che poi viene diffusa anche dalle scuole di scrittura creativa, non fa una grinza: sedersi al computer e battere un numero congruo di righe al giorno aiuta senz’altro a mantenere il cervello allenato e previene un blocco che rischierebbe di emergere al momento meno opportuno.
«Io ne avrei anche di cose da scrivere», ha detto una volta Fran Lebowitz, probabilmente la vittima più universalmente nota di blocco dello scrittore, «Solo che l’idea di farlo mi dà il disgusto».
Esattamente come accade a un tennista – non a caso Dyer cita Roger Federer – che ha appeso le racchette al chiodo: smettere di allenarsi equivarrebbe ad andare incontro a un decadimento fisico per niente salubre, ma questo non significa che dopo un certo punto si possa ancora sperare di giocare un Open senza essere spazzati via dalla giovane concorrenza.
L’eccezione
Qualche eccezione esiste, naturalmente, ma è così rara e inattesa che difficilmente può essere messa a sistema statistico. Nel suo ultimo romanzo, Babysitter – pubblicato in Italia da La nave di Teseo e tradotto da Chiara Spaziani –, Joyce Carol Oates ha trovato la forza e la voce per immergersi con sicurezza in una disturbante storia di serial killer, alta società e intrichi di potere conditi di una enorme dose di critica sociale e politica che spazia dal #MeToo a #BlackLivesMatter, attingendo al sempre presente e mai fuori moda preconcetto delle classi privilegiate.
Un’impresa per niente scontata per un’autrice la cui vasta produzione ha, nell’ultimo decennio, toccato momenti di stanca così evidenti, resi ancora più lampanti da un ritmo di pubblicazioni da fare impallidire Stephen King, da far pensare che il punto di non ritorno, quello oltre il quale nemmeno la voce amica che impone di riporre la penna può più nulla, fosse stato superato da un bel pezzo.
E invece, tenendo la mente allenata pronta, a 85 anni, è riuscita non solamente a occuparsi del presente come nessun altro romanziere della sua generazione ha saputo fare, ma a farlo con un ritmo e una credibilità assolutamente freschi e avvincenti. Certo, avrebbe forse potuto mantenere privati alcuni tentativi di romanzo andati a vuoto e saltare una decina di anni di confusione letteraria per tornare a mostrarsi in splendida forma, ma, di nuovo, è una questione di pubblicazioni, non necessariamente di scrittura.
Un’uscita spettacolare
C’è una leggenda che riguarda la morte dello scrittore e trombettista francese Boris Vian: pare che fosse andato a vedere l’adattamento cinematografico del suo capolavoro Sputerò sulle vostre tombe e che, un momento prima di collassare per non riprendere mai più conoscenza, stroncato da un arresto cardiaco, abbia esclamato rivolgendo allo schermo il suo sdegno: «Ah! Les americains!».
Molti dei celebrati autori qui citati avrebbero meritato un’uscita del genere: non solamente spettacolare, ma anche affermativa. Un punto fermo autoimposto alle proprie carriere, senza che un adattamento mal riuscito, uno sfortunato romanzo postumo o, peggio, il frutto della stanca e reiterata frustrazione che prima o poi coglie chiunque si imbarchi nella scrittura, potessero mai incrinarne la percezione o il ricordo.
Più spesso, il destino va al contrario, e tocca ai posteri prendersi la briga di dimenticare il declino e provare a celebrare una produzione ingiustamente strascicata per la paura di venire dimenticati.
© Riproduzione riservata