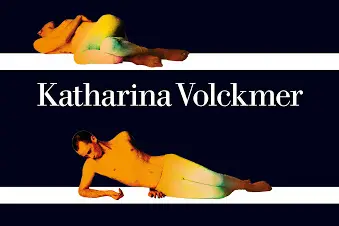Il romanzo di Katharina Volckmer è un racconto che molti non vorrebbero ascoltare ma che riflette sull’identità e sul passato che ci definiscono: vendicare le vittime della persecuzione diventando loro
- Vendicare le vittime della persecuzione diventando loro. Dice la protagonista di questa storia: «Quando ero più giovane pensavo sempre che il solo modo per superare davvero l’Olocausto sarebbe stato amare un ebreo».
- E poi, crescendo, alzare la posta: il desiderio di adeguare i propri organi sessuali all’identità di genere percepita, liberandosi allo stesso tempo del disagio per un’altra appartenenza non scelta: quella nazionale.
- Nella richiesta di intervenire sul singolo corpo concreto prende forma il desiderio di fare a pezzi l’intero corpo sociale, l’anatomia patologica e deforme della società.
Sognare di essere Hitler, e poi di farci sesso. Sognare di non essere più tedesca, donna, figlia sottomessa, prendere la propria origine, nazionale, familiare, e immaginare finalmente di disfarsene, pezzo dopo pezzo. L’identità come un cantiere, una faccenda tutta materiale. Cibo, cadaveri, organi sessuali, da estirpare/accogliere, rievocare, mangiare. Pane secco della propria terra, un campo di concentramento Lego, robot sessuali. Sognare e poi passare all’azione, pagare, pagare molti soldi – da dove arrivano tutti questi soldi?, lo scopriremo solo alla fine – affinché qualcuno ti renda altro da te. Ad esempio, per cominciare, sostituendo la tua (odiata) vagina con un pene.
Un pene circonciso, un pene ebraico. Vendicare le vittime della persecuzione diventando loro. Dice la protagonista di questa storia che molti non vorrebbero ascoltare: «Quando ero più giovane pensavo sempre che il solo modo per superare davvero l’Olocausto sarebbe stato amare un ebreo».
E poi, crescendo, alzare la posta: diventare un ebreo, diventare un uomo ebreo attraverso un cazzo ebreo. Dottore la prego mi aiuti, ecco qua i soldi. Nella richiesta di intervenire sul singolo corpo concreto prende forma il desiderio di fare a pezzi l’intero corpo sociale, l’anatomia patologica e deforme della società. È questo quello che accade in Un cazzo ebreo (La Nave di Teseo), acclamato e discusso esordio della trentatreenne Katharina Volckmer, scelto come libro dell’anno 2020 da The Times Literary Supplement e in corso di traduzione in 12 paesi, il cui titolo italiano – l’originale è The Appointment (Or, The Story of a Cock) – esplicita il movimento più eclatante del romanzo: il desiderio di adeguare i propri organi sessuali all’identità di genere percepita, liberandosi allo stesso tempo del disagio per un’altra appartenenza non scelta: quella nazionale.
Carne e Storia, insieme, connubio per molti oltraggioso (il corpo non conta, il corpo sta in basso). Il mondo non è stato cambiato dagli slogan, dalla politica, e neppure dalle emozioni? Ecco dunque il corpo che irrompe: «Al contrario di quello che dicono, hai bisogno di un corpo da amare. Tutte quelle fesserie che raccontano sulle anime sono semplicemente false, che puoi amare un’anima a prescindere dalla forma in cui si incarna».
Scambio di segreti
Non c’è però alcun conforto né linearità: il libro si presenta come un monologo di centododici pagine in cui prende vita una confessione, compatta e insieme fluviale, che straborda in territori sempre diversi, poggiando lo sguardo indomito e sferzante della protagonista su tante questioni difformi e centrali del nostro mondo. Un testo ibrido e provocatorio, che sembra far collassare nello stesso punto Thomas Bernhard, Hannah Arendt, Philip Roth (chiari i rimandi al Lamento di Portnoy) e Judith Butler, fondato su una vicinanza massima, intima e insieme violenta.
Dice a tal proposito Chiara Spaziani, traduttrice del libro: «C’è un passaggio in cui la protagonista afferma che è l’estraneità la condizione migliore perché possa compiersi un reale disvelamento di sé: solo tra sconosciuti riusciamo a confidare i nostri segreti più remoti, solo nelle mani di uno sconosciuto che rincasa la notte, quei segreti possono essere custoditi e baluginare come stelle polari. Tradurre il romanzo di Katharina – tradurre sempre, forse – è stato porsi nell’esatta condizione di condividere con qualcuno che non conosci la sua parola più intima, più nuda, una parola che precede addirittura quella del testo: scambiare parole tra lingue come scambiarsi segreti». Esperienza che si rinnova a pieno anche per il lettore.
Il rimosso
La fisionomia della vicenda – e della stessa protagonista – si svela per gradi: una donna (nonostante la disforia si presenta sempre come donna) tedesca, di mezza età, che vive a Londra, si trova nello studio del chirurgo plastico che la opererà ai genitali, e, complice la lunga visita, inizia a raccontare, affastellando memorabilia e progetti, verità, bugie.
Racconta dell’infanzia imprigionata in un corpo detestato, della dittatura della bellezza che amputa soprattutto l’esperienza femminile, dell’odio incamerato nei confronti di un mondo modellato dalla polarizzazione biologicista: «Non sono mai riuscita a capire per quale motivo questo debba essere il nostro principale modo di guardare alle persone, perché abbiamo avuto bisogno di creare un intero sistema, che arriva fino ai bagni pubblici, che separi i due generi».
Ma racconta anche delle conseguenze sospese della Shoah, il grande rimosso del suo paese, motivo di vergogna, vita che non scorre davvero: «Non siamo mai stati in lutto, semmai ci comportavamo assecondando una nuova versione di noi stessi – istericamente non razzisti in qualsiasi circostanza, e pronti a negare sempre qualsiasi differenza. All’improvviso c’erano soltanto tedeschi. Nessun ebreo, nessun operaio immigrato, nessun Altro. Eppure non abbiamo mai restituito agli ebrei lo status di esseri umani né abbiamo permesso che interferissero con la nostra interpretazione della storia, fino ad arrivare a quel triste cumulo di pietre che è stato messo a Berlino per commemorare le vittime dell’Olocausto. Ce l’ha presente, dottor Seligman? Io mi domando, seriamente, ma chi vuole essere ricordato in quel modo?».
Storie di altri
Un cazzo ebreo è un grande corpo a corpo, originale e caustico, con l’identità: quanto di ciò che siamo è irrevocabile? Cosa possiamo invece trasmutare, ricodificare? Il talento di Volckmer è quello di attraversare con passo prettamente letterario un campo fortemente contaminato da posizioni ideologiche e retoriche.
Nessuna pulsione è addomestica, siamo oltre l’ormai vuota contrapposizione politicamente corretto/scorretto. In questo nostro tempo pieno di convinzioni non contrattabili, Volckmer sceglie di costruire una narratrice inaffidabile, istrionica e contraddittoria, refrattaria a ogni ipocrisia, che sembra poter vantare più vuoti (e quindi desideri) che pieni (certezze). Un monologo tutto discese e risalite in questioni essenziali, e puntellato di aperture luminose: «E penso che in un certo senso siamo tutti questa cosa qui: storie di altri. È impossibile essere noi stessi, ho provato per così tanti anni a essere ciò che definiscono “autentico”, ma adesso so che non sono soltanto una, quanto il prodotto di tutte le voci che ho ascoltato e di tutti i colori che ho visto e che ogni cosa che facciamo è causa di sofferenza per qualcun altro».
Un nuovo immaginario
L’esordio di Volckmer è oggetto narrativo fluttuante, che mescola temi e registri, un torrente cangiante, percorso da tanti temperamenti diversi, persino antitetici: c’è molto sarcasmo, ma anche volute nostalgiche e afflato lirico. Un affabulare spietato, cattivo ma anche emozionante: i desideri frustrati spesso in queste pagine si fanno tristezza.
È un libro che reinventa un genere: si inserisce nella grande tradizione di narrazioni sulla Shoah e sulla relativa eredità, tutto quel filone che, nel corso del Novecento, ha cercato di metabolizzare lo sterminio ebraico. Si colloca lì, ma lo fa con una prospettiva dissacrante e non binaria, sceglie la chiave della non conformità sessuale per operare narrativamente amputando/innestando su due corpi: quello individuale, segnato dal eteropatriarcato, e quello sociale, marchiato da un lutto sospeso.
Dimostra che è possibile prendere sul serio la riflessione contemporanea senza per questo essere bidimensionali, didascalici, è possibile muoversi liberamente e con una gamma espressiva sorprendente nei nuovi territori liberati dai movimenti di pensiero di oggi, con buona pace di quelli (Bret Easton Ellis su tutti) che ritengono che il progresso in fatto di sensibilità e linguaggio collettivo determini di per sé la morte dell’arte.
Un cazzo ebreo tiene conto di tutto ciò, conosce bene il valore e la forza delle questioni in gioco, ma sa intravedere sentieri autonomi rispetto ai discorsi politici e degli attivisti: anche di identità nazionale, transessualità e femminismo è possibile occuparsi in modo specificamente narrativo, creando nuovo immaginario, e questo libro ce lo dimostra.
Katharina Volckmer è autrice del libro Un cazzo ebreo, edito da La nave di Teseo
© Riproduzione riservata