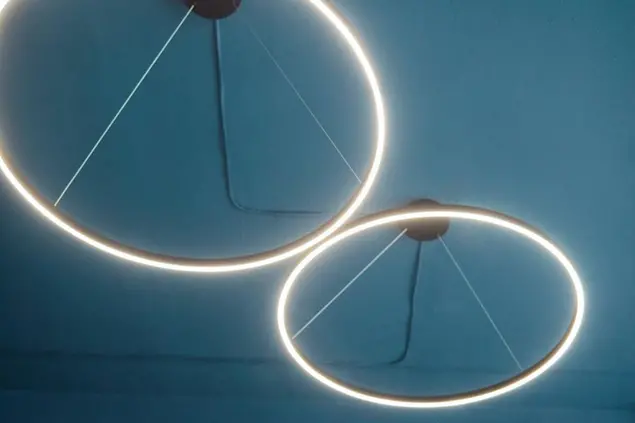- L’ultimo libro di Chiara Valerio, Tecnologia è religione (Einaudi) è pieno di aneddoti divertenti sul nostro rapporto con le tecnologie digitali, e ci appassiona con i suoi ricordi di un passato di videogiochi e computer che ci sembrano più lontani della preistoria.
- La tesi di fondo del libro, però, quella che vede nel nostro rapporto con la tecnologia una sorta di fede religiosa, presta il fianco a più di un dubbio. A cominciare dalla netta opposizione che Valerio vede tra la scienza, che prova, e la tecnologia, in cui si crede.
- Quando non si capisce si crede, scrive Valerio. Ma l’atteggiamento soggettivo nei confronti della verità dipende da noi, non dall’oggetto. Si può avere fede in tutto, anche nella scienza, come accadeva ai positivisti dell’Ottocento.
Tecnologia è religione. Sì, avete letto bene. Tra tecnologia e religione, nel titolo dell’ultimo libro di Chiara Valerio, c’è il verbo essere, la copula che stringe le due in una relazione di identità. Non la congiunzione e, che accennerebbe solo a qualche punto di contatto. La tecnologia è religione, la religione del nostro tempo.
Per provarlo, Valerio ricorre ai ricordi personali di nativa digitale o quasi, e siamo tutti con lei quando ci racconta le traversie cui è andato incontro un suo amico straniero che in tempi di pandemia aveva il green passa sotto forma di Qr code, suscitando i sospetti di un ristoratore, evidentemente poco digitale, che non lo voleva fare entrare nel suo ristorante, o quando si scontra con la pretesa che la sua firma (sempre digitale) depositata in banca anni prima non sia cambiata per niente nel corso del tempo.
E così pure ci appassiona quando ci trasporta nell’archeologia dell’elettronica, raccontandoci i suoi giochi di bambina sul Commodore. Niente invecchia più presto della vecchia tecnologia, e noi la ascoltiamo affascinati e perplessi come se ci raccontasse di un tempo favolosamente lontano, mentre è ancora vicino nella nostra memoria.
La narrazione affascina ma non basta
Ma quando dalla narrazione vogliamo passare all’argomentazione, le cose non ci sembrano più così persuasive. Il racconto fa aggio sui nessi logici, anche perché il ragionamento di Chiara Valerio procede per analogie.
Certo, si possono ritrovare somiglianze tra gli hikikomori giapponesi e i monaci medievali. Monaco vuole dire che sta da solo, e gli hikikomori sono quei giovani, per lo più adolescenti, che tagliano ogni rapporto diretto, personale col mondo isolandosi nelle loro stanze coi loro device e comunicando solo attraverso internet e i social.
Oppure: c’è davvero un rapporto tra l’obsolescenza della tecnologia (il Commodore che ci pare più lontano di Atene e Sparta) e l’invecchiamento dell’essere umano? I tempi sembrano molto differenti, se perfino i nativi digitali hanno visto passare sotto i loro occhi iPod e iPad, Blackberry e iPhone, second life e metaversi.
Se invece di rivolgere a Siri domande non proprio fatte per lui, tipo se c’è un Dio o chi era Wittgenstein, Valerio avesse interrogato ChatGpt, forse avrebbe avuto risposte non più intelligenti ma certo più articolate dei monosillabi che ci riferisce.
O ancora: se sui social c’è un’anima, e se Alexa continuerà a rispondere alle nostre domande anche quando non saremo più noi a interrogarla, avremo trovato la via della reincarnazione?
La tecnologia sarebbe riuscita a compiere il miracolo inseguito per secoli dalla filosofia e tuttora dalla religione: «Staccare dal corpo quel qualcosa che appartiene e afferisce alla nostra parte supposta immortale», a far tornare permeabile il confine tra spirito e materia.
Con l’analogia si può andare dove si vuole. Ce lo ha insegnato Robert Musil criticando uno che sull’analogia aveva fondato tutto il suo discorso, l’Oswald Spengler del Tramonto dell’Occidente. Con la logica, però, molto meno.
Provare per credere
L’impressione, allora, è che il libro di Chiara Valerio dia per scontate troppe cose. In primis, la distinzione tra scienza e tecnologia. Che per Valerio è chiarissima, radicale, al punto che la si può condensare addirittura in due soli verbi.
Il verbo della scienza è provare, quello della tecnologia credere. La scienza dimostra, mentre alla tecnologia ci si affida come a una fede. Ma è davvero così? Forse qui Valerio si è lasciata sviare da quella che i tedeschi chiamerebbero la sua Doppelbegabung, il suo doppio talento che le consente di essere, oltre che una scrittrice, una matematica.
Può darsi che nelle matematiche la differenza tra scienza pura e scienza applicata (ossia tecnologia) sia ancora netto. Ma altrove? Quanto è permeata di tecniche la ricerca nelle scienze sperimentali, per esempio in fisica, o quanto sono separabili i progressi della medicina o dell’astronomia dall’impiego di apparecchiature sempre più sofisticate?
Davvero la scienza consiste nella prova? Popper non sarebbe d’accordo, e direbbe piuttosto che consiste nella possibilità di confutazione, e anche qui probabilmente le cose stanno diversamente tra le matematiche, in cui si può contare su dimostrazioni certe, e le scienze empiriche, dove l’errore non può mai essere escluso.
Due sensi di tecnologia
Credo che Tecnologia è religione giochi un po’ troppo su due accezioni ben diverse del termine tecnologia. La prima accezione è quella antropologica, sulla base della quale ogni operazione umana, in quanto tale, presuppone e impiega una tecnica.
La magia, da questo punto di vista, è una tecnologia come la progettazione di un motore endotermico. E alla magia, certamente, bisogna credere, altrimenti si risolve nel nulla.
Ma il senso in cui usiamo la parola tecnica nel discorso comune è un altro, e ricorda molto di più la definizione che della tecnica dava, nientemeno, Aristotele, per il quale la tecnica era una capacità produttiva sorretta da conoscenze vere. Quella verità, quel fondamento che la tecnica magica, appunto, non possiede.
Allo stesso modo, Valerio sembra sorvolare troppo facilmente su alcuni dati di fatto, per inseguire le sue suggestioni. Sarà vero, ad esempio, che i nostri progenitori preistorici hanno scoperto la morte solo quando hanno iniziato a praticare l’agricoltura, e con essa il ciclo del rinnovo stagionale?
Ma quel che sappiamo mostra il contrario, se già i Neanderthal praticavano sepolture, e se nessuno più di un cacciatore sa cosa significa togliere la vita.
O ancora: si può dire, come fa questo libro, che il linguaggio è la prima tecnica, e che la tecnologia è nata dal linguaggio? Ma l’uomo aveva tecniche (rudimentali, ma tecniche, come la fabbricazione di manufatti in pietra) assai prima di avere linguaggio, al punto che forse è vero il contrario di quanto pensa Valerio: è dalla tecnologia, dalla capacità di progettare uno strumento col quale fabbricare altri strumenti che sono nate, probabilmente, quelle capacità che hanno consentito di elaborare lo straordinario strumento, il linguaggio, che ci consente di parlare di quello che non c’è.
Dubbi al posto di certezze
Troppe certezze su cui questo libro sembra contare ci guadagnerebbero a lasciar posto a dubbi. Per esempio, Valerio è convinta che quando non si capisce il funzionamento di qualche cosa sia aperta la strada per la paura e, attraverso la paura, per un ritorno a un rapporto magico con le cose.
Ma Max Weber, riflettendo cento anni fa sulla tecnica moderna, era arrivato a conclusioni diametralmente opposte. Per lui il nostro rapporto con la tecnica apriva la strada a quello che chiamava il disincantamento del mondo: nessuno di noi, a meno che non sia un ingegnere ferroviario, sa esattamente come funziona il tram su cui sale ogni mattina, mentre i popoli allo stato primitivo sanno certamente meglio di noi come funzionano l’arco e le frecce di cui si servono, ciò non ostante siamo convinti che la spiegazione ci sia e che ci sia qualcuno che lo sa.
Nessuno, nemmeno lo scienziato preso a modello nel libro di Valerio può davvero sapere come stanno le cose nei mille campi che non siano la sua specializzazione: la sua posizione, da questo punto di vista, non è diversa da quella dell’individuo comune.
Perché, alla fin fine, l’equivoco al quale sembra andare incontro Valerio è quello di scambiare il piano della credenza soggettiva con quello della comprensione delle cose.
Soggettivamente, si può avere fede, avere l’atteggiamento del credente che si affida anima e corpo, anche rispetto a cose che con la fede non c’entrano niente. Il filosofo positivista Comte, nell’Ottocento, aveva fatto della scienza una religione, con tanto di divinità e di feste comandate.
Norbert Wiener e Kurt Gödel, due padri fondatori della cibernetica e della logica contemporanee, avevano un’inclinazione mistica nei confronti dei loro oggetti di studio, e il secondo è arrivato a tentare una dimostrazione logica dell’esistenza di Dio.
Ma questo prova soltanto che ci avevano creduto troppo (alle loro discipline, non a Dio), e non che il loro atteggiamento fosse quello giusto.
© Riproduzione riservata