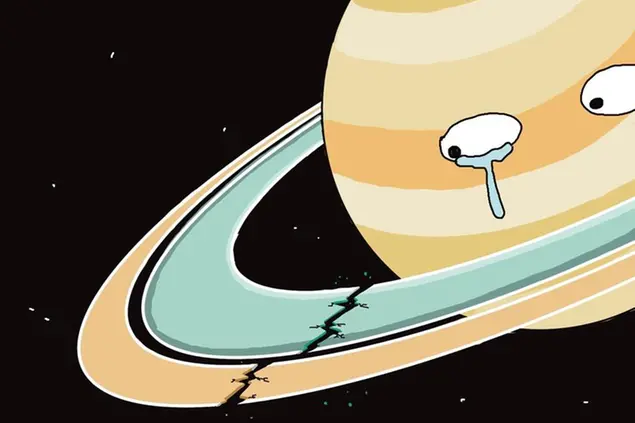Nella settimana della scienza, secondo una nuova ricerca le foreste miste sono più efficaci nello stoccaggio del carbonio rispetto alle foreste formate da un’unica specie. E il riscaldamento globale sulle Alpi procede a velocità quasi doppia rispetto alla media globale
Se realmente nel 2024 il noto mago David Copperfield farà “sparire” per alcuni minuti la Luna dai cieli della Terra (in un suo gioco di grande illusione allo studio da trent’anni), è certo che “Saturno in persona”, farà sparire i suoi anelli agli occhi di noi terrestri nel 2025.
Se nel primo caso sarà un grande gioco di illusionismo, nel secondo sarà un gioco della natura. Gli anelli di Saturno, che è noto essere composti da granuli di ghiaccio di dimensioni da pochi centimetri a qualche decina di metri e che si estendono fino a 280mila chilometri dal pianeta coprendo un’estensione paragonabile a quella di 30 Terre, hanno uno spessore che non supera il chilometro e mezzo.
Queste caratteristiche danno loro la possibilità di riflettere la luce solare, così da poter essere visti da Terra anche con un piccolo telescopio amatoriale o addirittura con un binocolo di elevata qualità e potenza. Questo, generalmente, perché sono leggermente inclinati su un lato rispetto al nostro pianeta.
Ma nel suo girovagare attorno al Sole l’inclinazione dell’asse di Saturno, e conseguentemente i suoi anelli, variano rispetto alla nostra vista e di tanto in tanto, questi ultimi, risultano esattamente allineati rispetto al nostro punto di osservazione. E dato il loro limitato spessore, praticamente scompaiono alla vista, anche se si osserva Saturno con un buon telescopio. E questo succederà il 23 marzo 2025, quando l’angolo d’inclinazione degli anelli scenderà a zero.
In base alla posizione della Terra e di Saturno la situazione visiva tra i due pianeti si ripete ad intervalli che possono andare da 13,7 anni a 15,7 anni, tant’è che dopo il 2025 una situazione simile si avrà il 15 ottobre 2038.
A fare da contraltare alla loro scomparsa vi sarà il momento in cui gli anelli si vedranno nel miglior modo possibile e questo si verificherà nel 2032, quando la massima inclinazione del pianeta rispetto alla Terra, che raggiungerà i 27 gradi, permetterà di vedere al meglio gli anelli e in quel caso anche l’area in prossimità del Polo Sud del pianeta, generalmente assai poco visibile
Gli anelli di Saturno non sono comunque destinati a sopravvivere per sempre. Secondo James O’Donoghue del Goddard space flight center della Nasa a Greenbelt, nel Maryland, infatti il sistema di anelli scomparirà in 100 milioni di anni, molto di meno rispetto a quanto si pensava nel passato, quando si ipotizzava che avrebbero potuto sopravvivere per almeno 300 milioni di anni.
In quel caso non sarà Copperfield a farli sparire per sempre, bensì la gravità di Saturno che attrae i corpuscoli di cui sono composti sotto forma di una pioggia polverosa di particelle di ghiaccio sotto l’influenza del campo magnetico del pianeta.
Non tutte le foreste sono uguali
C’è una strada che si può seguire per rallentare gli effetti del cambiamento climatico, conservare la biodiversità e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile: ripiantare gli alberi. Le foreste ripristinate immagazzinano carbonio nel suolo, negli arbusti e negli alberi.
Secondo una nuova ricerca, le foreste miste sono particolarmente efficaci nello stoccaggio del carbonio. Si è visto che specie diverse, con caratteristiche complementari, ne aumentano lo stoccaggio complessivo.
Rispetto alle foreste costituite da un’unica specie, le foreste miste sono anche più resistenti ai parassiti, alle malattie e ai disturbi climatici, il che aumenta il loro potenziale di stoccaggio del carbonio a lungo termine. Anche la fornitura di altri elementi ecosistemici è maggiore nelle foreste miste, che supportano livelli più elevati di biodiversità.
È uno studio importante, perché gli impegni di ripristino di molti paesi si concentrano sulla creazione di piantagioni di monocoltura. Visto il diffondersi di questa pratica, un gruppo internazionale di scienziati ha confrontato le scorte di carbonio nelle foreste miste con le scorte di carbonio nelle monocolture commerciali con le migliori prestazioni.
«Le foreste diversificate immagazzinano più carbonio di quelle a monocoltura, fino al 70 per cento in più», ha detto Emily Warner, ricercatrice in Scienze dell’Ecologia e della Biodiversità al dipartimento di Biologia dell’Università di Oxford e prima autrice dello studio.
Le foreste miste valutate nello studio variavano in ricchezza da due a sei specie. Nel set di dati con cui hanno lavorato gli scienziati, le miscele di quattro specie risultano i serbatoi di carbonio più efficaci. Uno di questi mix era costituito da diverse latifoglie, che si possono trovare in tutta Europa.
Le miscele con due specie immagazzinano fino al 35 per cento in più di carbonio rispetto a quelle a monocoltura. Le foreste composte da sei specie, tuttavia, paradossalmente non hanno mostrato alcun chiaro vantaggio rispetto alle monocolture. Il risultato dello studio dice che, visto lo slancio verso la rinascita di foreste volute artificiosamente, è giusto verificare quale strada intraprendere per avere il miglior risultato nell’abbattere il carbonio in atmosfera.
L’ultima glaciazione sulle Alpi
Il riscaldamento globale sulle Alpi procede a velocità quasi doppia rispetto alla media globale: un processo dalle conseguenze molto impattanti. E questo è curioso, tenendo conto del fatto che un recente studio condotto dall’Università degli studi di Trieste – appena pubblicato sulla rivista internazionale Climate of the Past – ha stimato come tra 26 e 21mila anni fa il clima delle Alpi abbia registrato valori di raffreddamento quasi doppi rispetto alla scala globale.
Lo studio, condotto da Costanza Del Gobbo dell’Università degli studi di Trieste e assegnista di ricerca all’Istituto di Scienze Polari del Cnr, ha richiesto quattro anni di lavoro, è stato finanziato dall’International Centre for Theoretical Physics e supervisionato dal premio Nobel Filippo Giorgi (Ictp), da Renato R. Colucci, ricercatore all’Isp-Cnr e docente di glaciologia all’Università degli studi di Trieste e da Giovanni Monegato, ricercatore all’Istituto di geoscienze del Cnr.
Durante l’«ultimo massimo glaciale» (Lgm), avvenuto sulle Alpi tra 26 e 21mila anni fa, i ghiacciai si spinsero nelle pianure pedemontane e sono ancora oggi identificabili grazie alle grandi morene frontali ben conservate, ad esempio quelle del Tagliamento a nord di Udine, del Garda a nord di Verona o nel comprensorio Ivrea-Verbano in Piemonte.
I ghiacciai sono fortemente controllati dalla temperatura e dalle precipitazioni e quindi sono eccellenti indicatori del cambiamento climatico. In questo lavoro è stato utilizzato un modello climatico regionale sviluppato dall’Ictp innestato nel modello paleoclimatico di più vasta scala del Max Planck Institute (Germania), che ha permesso di studiare alcuni dei processi fisici che hanno sostenuto i ghiacciai alpini 21mila anni fa.
I risultati del lavoro sono riusciti, per la prima volta, a trovare ottima coerenza con le evidenze geomorfologiche e geologiche sul terreno, dove invece i modelli precedenti presentavano grossi errori in diversi settori alpini a causa di errate stime legate alle precipitazioni. I risultati mostrano come il clima delle Alpi fosse mediamente 6.8°C più freddo rispetto ai livelli preindustriali, ossia del 1700/1800 dopo Cristo, quindi circa 9°C più freddo rispetto ad oggi e in particolare nei settori orientali. Le precipitazioni annuali erano più scarse di circa il 15 per cento.
La stagione a subire le variazioni più significative era l’estate con una diminuzione di 7.3°C rispetto ai livelli preindustriali, ossia quasi 10°C in meno rispetto alle estati attuali. Queste condizioni permettevano ricorrenti nevicate attorno ai 1000 metri di quota in piena estate, e a volte anche a quote inferiori, mentre le pianure del Nord Italia erano coperte di neve da novembre a maggio.
La distribuzione delle precipitazioni era molto diversa rispetto ad oggi, con l’estate come stagione più piovosa (in particolare sul settore alpino settentrionale), mentre l’inverno era verosimilmente molto freddo e secco a causa dell’influenza di una vasta area di alta pressione estesa dalla Scandinavia, dove aveva sede una calotta glaciale simile a quella della Groenlandia attuale, alla Siberia.
Solo sul settore meridionale delle Alpi le precipitazioni erano frequenti anche nel corso dell’inverno, prevalentemente a carattere nevoso fino in pianura. Questo studio ha aperto nuove prospettive sull’uso dei modelli climatici regionali per lo studio dei climi passati, in quanto tali modelli possono offrire un dettaglio spaziale che ci permette di capire meglio gli indicatori climatici rilevati sul campo soprattutto in aree, come quella Alpina, caratterizzate da morfologie molto complesse.
Un antico pianeta
Nel mantello del nostro pianeta (lo strato che sta al di sotto della crosta terrestre) potrebbero esserci pezzi di un antico pianeta che sono rimasti intrappolati dopo lo scontro tra i due. Da tempo è stato ipotizzato che la Luna nacque come conseguenza di un impatto tra un pianeta di dimensioni simili a Marte, che oggi chiamiamo Theia, e la Terra.
Il primo, praticamente, si sbriciolò e dai detriti nacque il nostro satellite naturale. È questa l’ipotesi chiamata dell’«impatto gigante». Theia tuttavia potrebbe non essere finito del tutto nello spazio, ma, secondo una nuova ipotesi, un paio di giganteschi grumi potrebbero essere finiti incastonati nelle profondità del sottosuolo, nel nostro mantello.
Da decenni i ricercatori sanno che ci sono due aree nel mantello terrestre, ciascuna di decine di chilometri di diametro, che si comportano in modo leggermente diverso rispetto a ciò che li circonda. Uno si trova sotto l’Africa e l’altro sotto l’oceano Pacifico. Questi corpi sembrano essere più densi del resto del mantello.
Qian Yuan del California Institute of Technology e i suoi colleghi hanno ipotizzato che l’impatto gigante e l’anomala densità dei due blob potrebbero essere correlati tra loro. I ricercatori hanno eseguito una serie di simulazioni su come si sarebbero comportate le macerie che si sarebbero formate dopo lo scontro tra Theia e la Terra.
Hanno scoperto che il materiale che componeva il mantello di Theia si sarebbe fuso e sarebbe affondato nella Terra fino al confine tra il mantello e il nucleo terrestre, creando uno strato sottile che ricopriva l’intero nucleo a circa 2800 chilometri di profondità. Poi, col tempo, si parla di miliardi di anni, la convezione all’interno del mantello terrestre (ossia la risalita e discesa del materiale che compone il mantello) avrebbe lentamente raccolto questo denso materiale e lo avrebbe portato verso la superficie, il quale si accumulò nei due grumi che vediamo oggi a profondità assai inferiori.
© Riproduzione riservata