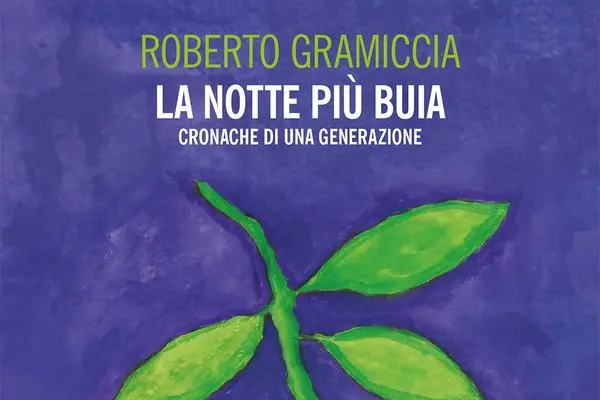Roberto Gramiccia è l’autore di un libro (La notte più buia, Mimesis, 288 p.) che è in realtà una lunga riflessione sul cuore della seconda metà del Novecento, con una coda interpretativa che tocca il primo scorcio del nuovo millennio.
Se si volesse farne una trasposizione cinematografica suggerirei per la prima scena di mettere in campo Pippo, il “sindaco” di Villa Certosa.
Siamo a Torpignattara alla fine degli anni Settanta. Tra la sezione Pci di via Bordoni e quella di via Torpignattara, appunto. Luoghi e anni di lotte, come quelle per lo smantellamento delle baracche e per l’assegnazione delle case popolari; e di scontri con i fascisti. Pippo, emigrato dal Sud e operaio delle Condotte di Acilia, è chiamato “il sindaco” a Villa Certosa, borgata di umanità e di passioni, fatiche e fragilità comuni. È il perno di un sistema di relazioni umane e politiche in cui la sua menomazione fisica (zoppica, fatica a usare il braccio e la mano destra) è il paradigma di una condizione di svantaggio che va colmata con la lotta politica e anche di una irregolarità che è la cifra stilistica ed estetica con cui si tenta l’assalto al cielo.
Con Pippo c’è Roberto Gramiccia, che è l’autore di un libro (La notte più buia, Mimesis, 288 p.) che in effetti è già una bozza di sceneggiatura. Il sottotitolo, Cronache di una generazione, chiarisce il profilo di un romanzo autobiografico che è in realtà una lunga riflessione sul cuore della seconda metà del Novecento, con una coda interpretativa che tocca il primo scorcio del nuovo millennio.
Il collettivo politico
Per questo partirei dal collettivo politico che Pippo anima con Roberto e Ivano, Luciano, Celeste, Claudio, Flavia, Ciro (Ciro Principessa, ucciso dalla lama di un neo-fascista nel 1979) e tanti altri. Perché questa militanza politica di quartiere, imbevuta di umanità, è davvero un pezzo essenziale delle storie di vita che Roberto racconta e che hanno segnato la generazione diventata adulta negli anni Settanta.
È da questa prospettiva che Gramiccia riflette sul Pci, inteso come grande scuola popolare, come progetto pedagogico autonomo, di trasformazione e di riscatto, ma anche come specchio della lenta mutazione genetica del Paese che nell’arco di vent’anni vede crollare sogni possibili, equilibri reali, ideologie. La fine del Pci — scrive Roberto — non a caso coincide con la perdita di senso di un’idea di democrazia partecipata e popolare ed è la certificazione (causa ma anche effetto) della debolezza di una vera coscienza di classe.
I ragionamenti sulla politica sono svolti allora a partire da questo grumo di questioni: la solidità e la concretezza del Pci, la sua storia, e poi l’evaporazione del suo radicamento, il rapporto con la sinistra extra-parlamentare (come il Collettivo di Medicina del Manifesto cui Roberto partecipa appena entrato in Università) e ancora le vicende di Rifondazione comunista, per la quale in anni più recenti assume ruoli e incarichi consistenti, continuando a cimentarsi con una politica sempre intesa come «disponibilità all’ascolto nei confronti dei desideri e dei bisogni umani».
Ma attenzione: il libro di Roberto, autobiografia e romanzo generazionale, è davvero molto altro. Banalmente perché Roberto è molto altro. È innanzitutto un medico, che attraverso la medicina e la sua crisi (che si colloca nella parcellizzazione del sapere, in una iper-specializzazione che perde di vista spinozianamente il generale, una realtà dell’intero che è più vera della somma delle sue parti), indaga la società e i corpi. I corpi fisici e i corpi sociali. Ammira la bellezza e scruta le impurezze e le asimmetrie, assegnando a entrambe funzioni catartiche e rivoluzionarie. Perché Roberto vive con il mondo in una tensione costante alla fascinazione e alla ricerca, con le parole e i gesti, con la coerenza tra le prime e i secondi, di un’estasi. Non gliene ho mai parlato in questi termini ma penso che non mi darà torto.
Più di una autobiografia
Del resto, Roberto è anche l’arte che studia, che colleziona, che critica, che fissa in opere la dimensione della seduzione. Dell’artista sul reale. Della realtà percepita, immaginata, vagheggiata sull’artista.
E le storie della vita che Roberto ci racconta parlano di ricerche seduttive, di amore, di un infinito apprendistato dell’amore che si deve godere a prescindere dagli orizzonti che dischiude, di fedeltà e di indifferibili tradimenti, di paure e di rivincite.
Ecco il titolo, La notte più buia, ricordando il primo ricordo, un risveglio solitario a quattro anni nel cuore della notte in un letto vuoto. E a seguire altre paure, altre fragilità ribelli, un percorso di emancipazione, educazione, iniziazione alla vita e alla cultura all’insegna della capacità reattiva, della voglia di trasformare l’insicurezza in consapevolezza e forza. Mordendo con voracità le passioni e i trastulli: la filosofia, il calcio, la letteratura, il poker. Fino alla seconda notte più buia, quella della pandemia, nel corso della quale Roberto ha scritto e della cui malinconica, disastrosa, apocalittica essenza il libro è segnato.
Dovremmo dire tanto altro, suggerire allo sceneggiatore altri spunti pescando negli aneddoti e negli affreschi che Roberto ci regala. Mi permetto soltanto un’ultima annotazione, la più banale ma la meno scontata in tempi difficili anche nel campo editoriale: è un romanzo scritto bene, con una intensità narrativa notevole. E con una predilezione per il «tipico» lukácsiano, per l’individuazione e la creazione di tipi tratteggiati in quei caratteri che colgono il significato profondo della realtà storica allineando «elemento umano eterno e […] individualità». Non realismo, ma capacità di disegnare il reale storico e l’universale umano attraverso figure e luoghi particolari. Il venditore di cozze o Raffaele, quattordicenne boss di quartiere, la signorina Podda oppure Elio, che insegna a Roberto le regole del poker. La sezione del Pci, la strada, la parrocchia, i salotti e le gallerie d’arte di Roma. Dialogano con il tempo, con la storia e, soprattutto, con la vita e le sue fratture.
© Riproduzione riservata