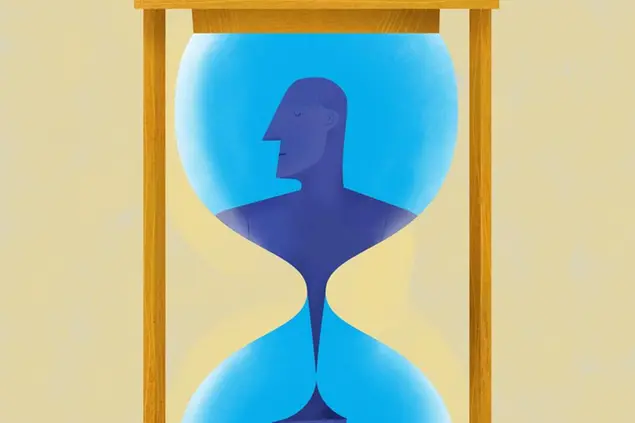- Ci sono parole orfane del concetto e concetti alla ricerca delle parole per dirsi. Ci sono anche formule addebitate a chi non le ha mai utilizzate e termini talmente logorati da non possedere più una paternità.
- Ora, dovendo pescare nel limitato vocabolario della politica attuale la voce in assoluto più inaridita di senso, direi che “riformismo” si colloca in cima alla lista.
- Perché battezzato e reclutato un numero tale di volte e da una quantità tale di soggetti da avere smarrito qualunque connotazione riconoscibile col risultato di coprire – lo stesso termine, intendo – pratiche opposte e, dunque, di essere rimasto parola depurata dal concetto.
Ci sono parole orfane del concetto e concetti alla ricerca delle parole per dirsi. Ci sono anche formule addebitate a chi non le ha mai utilizzate e termini talmente logorati da non possedere più una paternità.
Per dire, quel genio di Sherlock Holmes in nessuna delle sue avventure se ne è mai uscito col tormentone “elementare, Watson”, il che non ha impedito che nel senso comune la formula divenisse brand del personaggio. Pure il compianto, da pochi, Karl Marx non si è mai cimentato col “capitalismo”. Del “capitale” sì, ha parlato e scritto in abbondanza lasciando però ad altri, diciamo ai posteri, il compito di declinarne le applicazioni.
Ora, dovendo pescare nel limitato vocabolario della politica attuale la voce in assoluto più inaridita di senso, direi che “riformismo” si colloca in cima alla lista. Perché battezzato e reclutato un numero tale di volte e da una quantità tale di soggetti da avere smarrito qualunque connotazione riconoscibile col risultato di coprire – lo stesso termine, intendo – pratiche opposte e, dunque, di essere rimasto parola depurata dal concetto.
Comunque la si pensi, un pasticcio. In ogni caso un’insana confusione. Per un motivo in più. Che in passato il termine altroché se connotava la distanza tra destra e sinistra, conservazione e progresso, pensiero reazionario e radici illuministe. Nel 1942 con l’Europa in fiamme, Lord Beveridge redigeva il suo rapporto sulla sicurezza sociale. Immagino non sapesse quale influenza avrebbe avuto sull’architettura del welfare britannico.
Penso, invece, avesse ben chiara la matrice e natura riformista del disegno. Più o meno nello stesso arco di tempo, dopo undici anni di carcere e confinato a Ventotene, toccava a Ernesto Rossi riversare nel titolo più bello, «Abolire la miseria», lezioni apprese da letture economiche degli anni Trenta sul contrasto intollerabile tra la povertà di larghi strati e l’opulenza, usava proprio quel termine, di pochi privilegiati.
Denunciava il parassitismo di coloro che campano sulle rendite patrimoniali ereditate senza alcun merito e valorizzava il ruolo dell’impresa sana che produce, diremmo oggi che innova. Insomma, contrastava ogni forma di monopolismo stimando, invece, la creatività finalizzata al produrre per vivere che è cosa ben diversa dall’opposto. Nello stesso saggio rievocava la prima inchiesta sulle abitazioni degli italiani.
Risaliva al 1931 e aveva riguardato i comuni più popolosi dell’epoca. Su più di tre milioni di abitazioni censite, circa settecentomila erano senza cucina, poco meno di un milione e mezzo mancavano di una «latrina indipendente» e un altro milione non disponeva dell’acqua potabile. La conclusione, che poi del libro era la premessa suonava caustica, «Noi non abbiamo nessuna fiducia nell’armonia creata spontaneamente dalle forze economiche», e lo scriveva assai prima che l’egemonia del mercato capace di autoregolarsi allocando le risorse nella maniera più efficace prendesse il sopravvento.
Ma infine, in quel libro prezioso, era la metafora della malattia a lasciare una traccia nel dopo. Intendeva Ernesto Rossi una malattia sociale, la miseria appunto, per combattere la quale indicava misure terapeutiche a sanare la condizione di chi viveva in sofferenza, ma assieme al bisogno di azioni profilattiche se s’intendeva evitare che altre e altri dovessero pagare il prezzo di riforme mancate o interrotte.
Uno prendeva tra le mani quel lavoro di studio, di scavo, e subito capiva cosa fosse il riformismo. Investire risorse, e pensiero, nella volontà di impattare la condizione di vita di donne e uomini nati o costretti in uno stato di minorità.
Nello spazio dei beni fondamentali, a un tetto sulla testa, l’acqua da bere, la salute da curare, l’accesso allo studio. In altre parole, il diritto a sperare e a creare forme e strumenti della lotta capaci di tradurre quella speranza in traguardi condivisi. Ecco perché avere consentito al termine riformismo di indossare qualunque abito senza presidiarne il perimetro concettuale, e pratico, lo ha svuotato dell’anima.
E però sta esattamente qui il bisogno di restituire alla parola il suo significato. Non si è riformisti perché ci si proclama tali. Lo si è per il merito delle scelte e il coraggio della radicalità dimostrata in anni lontani da pensatori liberi non imprigionati nella camicia di forza delle classificazioni.
E allora, se vogliamo fondare una vera alternativa alla destra peggiore che oggi governa, conviene archiviare una buona volta il dualismo tra radicalità e riformismo per farsi convinti che solo una sintesi tra le due espressioni potrà restituircene il senso. Come non direbbe Holmes, “Elementare, Watson”.
© Riproduzione riservata