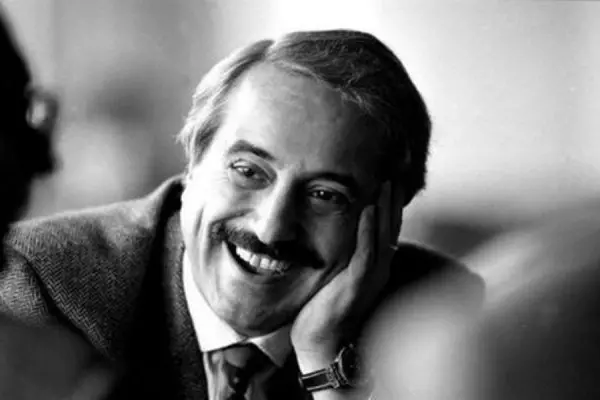Una volta imboccata la strada dell’attacco armato di stampo terroristico per costringere lo stato a venire a più miti consigli, non c’era alternativa alla scelta di proseguire su quella strada, fino a quando lo stato non avesse ceduto o mostrato segni di cedimento
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla trattativa stato-mafia.
Già nella seconda metà del 1990, ma ancor più nel periodo in cui Giovanni Falcone aveva ricoperto le funzioni di Direttore degli Affari Generali del ministero di Grazia e Giustizia, erano state varate, come già rammentato, una serie di misure e modifiche anche normative di straordinaria efficacia e incisività sul terreno della repressione del crimine mafioso, anche sotto il profilo dell’azione di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione del tessuto economico ed istituzionale.
Basterà ricordare tra i provvedimenti più significativi il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, recante “misure urgenti per limitare l’uso dei contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, poi convertito con modifiche nella legge 5.7.1991, ii. 197; il D.l 13 maggio 1991, n. 152, contenente misure urgenti “in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, convertito con modifiche nella legge del 12.7.1991 n. 203, decreto questo con cui si introducevano rigorosi limiti alla possibilità per i condannati per delitti di criminalità mafiosa di usufruire della liberazione condizionale e delle altre misure alternative alla detenzione e si prevedeva un’aggravante ad effetto speciale per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall‘art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nonché un’attenuante pure ad effetto speciale per i reati di criminalità mafiosa, da applicare nei confronti di coloro che avessero fornito un contributo rilevante nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei predetti reati.
I decreti normativi
Quest’ultima norma assumeva un particolare rilievo nella produzione legislativa in materia di contrasto alla criminalità organizzata perché introduceva per la prima volta, dopo lunghe polemiche ed incertezze, lo strumento – già collaudato con straordinari risultati nella lotta al terrorismo – dell’incentivazione premiale alla collaborazione di associati alle organizzazioni di tipo mafioso, tradizionalmente chiuse verso l’esterno dal muro dell’omertà.
Particolarmente significativi erano, altresì, il D.l 31 maggio 1991 n. 164, recante “misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso”, convertito con modifiche nella legge 22.7.1991 n. 221; il D.l 9 settembre 1991 n. 292, recante “disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimento di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti”, convertito con modifiche nella legge 8.11.1991 n. 356; il D.l 29 ottobre 1991, n. 345, poi convertito con legge 30.12.1991 n. 410, recante “disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”, che tra (‘altro istituiva nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza la Direzione investigativa antimafia (Dta), con il compito di coordinare le attività di investigazione preventiva in materia di criminalità organizzata e di effettuare indagini di polizia giudiziaria per i delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all’associazione medesima; il D.l 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8, contenente norme di “coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, che tra l’altro istituiva la Direzione Nazionale Antimafia (Dna), con il compito di promuovere e coordinare a livello nazionale le indagini per i reati summenzionati, che venivano attribuite in via esclusiva alle Direzioni distrettuali antimafia (Dda), una sorta di “pool” riconosciuto dalla legge, istituito presso le procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto; il D.l 31.12.1991 n. 419, relativo alla “ Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive”, convertito con modificazioni nella Legge 18.2.1992, n. 172; la Legge 18 gennaio 1992 n. 16, recante “norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”, che prevedeva tra l’altro delle cause di ineleggibilità a determinati uffici pubblici locali di coloro che avessero riportato condanne o fossero imputati di determinati reati.
E insieme alla produzione normativa, un’efficace azione di contrasto si giovava anche di misure concrete di organizzazione degli uffici giudiziari più sensibili, come nel caso della turnazione nelle assegnazioni dei processi in materia di c.o. alle sezioni della corte di Cassazione o del monitoraggio delle decisioni della suprema corte elevate a sospetto; o il dichiarato appoggio alla candidatura di Giovanni Falcone a ricoprire l’incarico di procuratore Nazionale Antimafia.
A questo implacabile trend normativo era andato ad aggiungersi l’esito disastroso del maxi processo che aveva per così dire suggellato la rottura definitiva del tacito patto di non belligeranza o di pacifica coabitazione nei rapporti tra le organizzazioni mafiose e la Politica, stroncando qualsiasi residua speranza di poter beneficiare di coperture e connivenze che per anni avevano assicurato ai mafiosi l’impunità per i crimini commessi, o la possibilità di godere di dorate latitanze.
Invertire questo trend negativo ricorrendo alla principale risorsa strategica e la più congeniale ai metodi con cui i corleonesi erano usi regolare i loro affari e tutelare i propri interessi, senza tuttavia trascurare la ricerca di nuove alleanze politiche (e in tale direzione convergono le propalazioni di Cancemi, Brusca e Giuffrè), era divenuta quindi una scelta obbligata per Riina e i capi corleonesi che si stringevano attorno alla sua leadership. E qui affondava le sue radici la decisione dei vertici mafiosi di scatenare un’offensiva senza precedenti contro lo Stato e le Istituzioni.
La strategia del terrore
Ebbene, la strage di Capaci, in quanto vero e proprio atto di guerra con evidenti valenze terroristiche, aveva segnato un punto di non ritorno di quell’offensiva.
Infatti, una volta imboccata la strada dell’attacco armato di stampo terroristico per costringere lo stato — che si presumeva ormai votato a incalzare le organizzazioni mafiosi con incisive misure normative e organizzative, ma pur sempre incapace di sopportare un costo di vite umane che ne avrebbe decretato il fallimento nella principale delle sue funzioni, e cioè quella di assicurare il rispetto dell’ordine pubblico e tutelare l’incolumità dei cittadini — a venire a più miti consigli, non c’era alternativa alla scelta di proseguire su quella strada, fino a quando lo Stato non avesse ceduto o mostrato segni di cedimento: pena il dover riconoscere, Riina e tutti i suoi luogotenenti, il fallimento di quella strategia, quando invece tra le ragioni che avevano indotto ad optare per l’uccisione di Falcone con modalità eccezionalmente eclatanti v’era anche quella di rilanciare, con una dimostrazione di forza senza precedenti, una leadership messa in discussione dall’esito disastroso del maxi processo e dagli effetti che cominciavano a farsi sentire delle misure varate dalla compagine governativa nel trascorso biennio (oltre all’insofferenza per i metodi autoritari di gestione dell’organizzazione che tre anni prima aveva prodotto una fronda interna stroncata nel sangue da Riina: il cd. complotto Puccio).
Sotto altro profilo deve convenirsi come possa ormai darsi per acquisito, all’esito dei tanti processi celebrati e definiti ormai con sentenze divenute irrevocabili, che a saldare la strage di via D’Amelio a quella di Capaci in un disegno criminoso unitario non fu solo la finalità ritorsiva – e cioè la vendetta da tempo covata contro due nemici “storici” di Cosa nostra – essendo i due eventi delittuosi accomunati anche dall’ulteriore finalità di ricatto allo stato.
Nel senso che si voleva esercitare sul governo e sulla classe politica, mediante reiterate esplosioni di inaudita violenza, una pressione tale da costringere lo Stato a venire a più miti consigli, e a recedere da quella Linea dura a cui Cosa nostra avrebbe opposto reazioni sempre più vilente e sanguinose, dimostrando di averne la capacità di metterle in atto (e su ciò convergono le propalazioni dei collaboratori di giustizia sia palermitani, come Cancemi, Brusca, Giuffrè, Cucuzza, o trapanesi, come Sinacori, che catanesi, come Malvagna, Pulvirenti e Avola), e in particolare a fare concessioni significative sui temi di maggiore interesse per gli affiliati mafiosi: la revisione del maxiprocesso,
L‘allentamento della stretta carceraria mediante l’ampliamento delle possibilità di accesso per i mafiosi ai benefici della Legge Gozzini, la revisione in senso più restrittivo della legislazione sui collaboratori di giustizia, e di quella in materia di misure di prevenzione, con riferimento ai sequestri e alle confische dei beni dei mafiosi erano già allora gli obbiettivi che stavano più a cuore dei mafiosi.
Ora, se ciò è vero, come ci dicono tanti processi e relative sentenze definitive, e lo confermano le prove testimoniali raccolte anche nel presente processo, allora una nuova manifestazione di terrificante potenza che facesse seguito nel più breve tempo possibile a quella esibita con la strage di Capaci, colpendo al pari di questa e con modalità altrettanto eclatanti un altro simbolo vivente della lotta dello stato a Cosa nostra, non solo era funzionale a quella strategia, ma ne costituiva il più naturale, logico e quindi anche prevedibile sbocco.
Come scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, nel processo “Borsellino ter”, «in sostanza può senz’altro affermarsi che la ragionevole prevedibilità della strage di via D’Amelio non è frutto di un giudizio formulato a posteriori, giacché le stesse modalità dell’attentato di Capaci avrebbero dovuto rendere palese che, nel mirino di Cosa nostra, c’erano i magistrati che l’avevano affrontato con maggiore determinazione, tra cui, in prima linea, Paolo Borsellino, naturale erede di Giovanni Falcone, ed ideale continuatore della linea da lui tracciata».
Ed il primo ad esserne convinto, tanto da sentire di avere i giorni se non le ore contati, con la lucida consapevolezza che gli derivava probabilmente anche dalla profonda conoscenza della logica e del mondo di Cosa nostra, era proprio Paolo Borsellino: come è emerso, in effetti, dalle drammatiche testimonianze dei familiari e dei colleghi di lavoro a lui più vicini, odi soggetti con i quali aveva avuto negli ultimi tempi contatti per ragioni legate al suo lavoro.
Spiccano su tutte le dichiarazioni rese dalla Signora Agnese Piraino Leto già nel primo processo (“Borsellino Uno”) su via D’Amelio, e riportate in diverse sentenze acquisite, secondo cui «mio marito era preoccupatissimo e mi diceva sino a quando ci sarà Giovanni vivo mi farà da scuso, Giovanni è morto ed era sì, molto, molto preoccupato. Mi diceva ‘faccio una corsa contro il tempo, devo lavorare, devo lavorare tantissimo, se mi fanno arrivare.... Io ho capito tutto della morte di Giovanni...».
E non meno drammatiche le testimonianze dei colleghi a dire dei quali dopo la strage di Capaci, il dott. Borsellino si definiva come “un morto che cammina”, o addirittura evitava di farli salire in auto con lui per evitare loro rischi inutili.
Ve n’è un’eco precisa anche in questo processo nelle parole di Fernanda Contri, la quale rammenta che, quando si videro con Borsellino circa 15 giorni prima della sua morte, le disse che stava facendo avanti e indietro dalla Germania, per sentire nuovi pentiti; e le raccomandò di caldeggiare presso il Presidente del Consiglio le proposte e i disegni di legge che riguardavano i collaboratori di giustizia, sottolineando che aveva molta premura. […]. E le stesse annotazioni sull’agenda di lavoro del magistrato trucidato con la sua scorta, incrociate alle testimonianze dei colleghi, documentano eloquentemente il ritmo incalzante e persino frenetico con cui si susseguirono i suoi impegni professionali (a far data in particolare dal 25 giugno, e comprese due trasferte a Roma per andare a sentire due nuovi penti, e una trasferta in Germania, sempre per andare a sentire nuovi pentiti).
D’altra parte, è di tutta evidenza che Paolo Borsellino non era solo uno dei tanti obbiettivi da colpire, ma fu fin dall’inizio dell’offensiva stragista che era stata varata nel corso delle riunioni della Commissione provinciale e della commissione regionale di Cosa nostra tra la fine del ‘91 e l’inizio del ‘92, uno degli obbiettivi principali di quella campagna di morte e di terrore.
© Riproduzione riservata