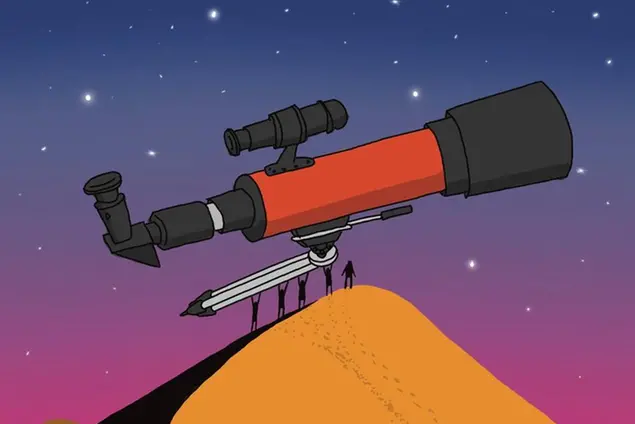I telescopi spaziali hanno rivoluzionato l’astronomia. Eppure gli ultimi 25 anni sono stati l’èra dei mega telescopi terrestri, grazie ai quali siamo stati protagonisti di importanti scoperte. Ci serviranno ancora in futuro? Probabilmente sì, per diverse ragioni
Dapprima l’Hubble Space Telescope, poi il James Webb Space Telescope: insieme a decine di altri telescopi spaziali che hanno osservato o osservano l’Universo nelle più diverse frequenze, hanno realmente rivoluzionato l’astronomia.
Eppure gli ultimi 25 anni sono stati l’èra dei mega telescopi, quelli da dieci metri di diametro o più, un’èra iniziata negli anni Novanta. Fino ad allora, il più grande telescopio ottico nell’emisfero occidentale era stato il telescopio Hale da 5,1 metri, costruito nel 1949 sul monte Palomar in California e utilizzato da Edwin Hubble negli anni precedenti alla sua morte.
Un telescopio sovietico chiamato BTA-6 lo ha battuto di un metro nel 1975, ma, per i successivi 40 anni, i più grandi telescopi terrestri sono stati tutti costruiti nella classe da quattro metri a cinque metri. C’erano varie ragioni per cui non se ne costruivano di più grandi, tant’è che tutti aspettavano i telescopi spaziali i quali, con dimensioni ridotte, avrebbero osservato molto meglio il cielo che non i telescopi terrestri, che da sempre hanno dovuto combattere con il velo dell’atmosfera terrestre.
Una di quelle ragioni era che gli specchi dei telescopi giganti erano incredibilmente pesanti, costruiti in vetro spesso per renderli immuni alle raffiche di vento, all’espansione termica e alle scosse di un terremoto. Si pensava che se si fossero costruiti specchi più grandi, si sarebbero piegati sotto il loro stesso peso, deformandone la forma e quindi rendendo sfocata la visione del telescopio.
La storia
Negli anni Ottanta però, grazie alla tecnologia e al lavoro di John Hill e Roger Angel dell’università dell’Arizona, Tucson, si è passati a costruire specchi di vetro di nuova concezione. Invece di usare un unico pezzo di vetro solido per realizzare lo “specchio” di un telescopio, si è iniziato a costruire specchi partendo da un nido d’ape dove veniva fatto fondere vetro in una fornace, mentre lo si faceva girare su una specie di giradischi.
La combinazione di forza centrifuga e gravità creava una forma parabolica allo specchio che una volta finito era leggero e rigido allo stesso tempo, proprio grazie alla struttura a nido d’ape interna. Così che si è reso possibile realizzare specchi fino a 8,4 metri di diametro e, improvvisamente si è passati a osservatori grandi quasi il doppio rispetto ai precedenti.
Anche prima che gli osservatori fossero in grado di utilizzare questa tecnologia, tuttavia, molti altri osservatori avevano aggirato le limitazioni dei grandi specchi per utilizzare una tecnologia che sarebbe diventata il futuro: specchi che erano il risultato dell’unione di sezioni esagonali più piccole e facilmente trasportabili.
Il gigantesco telescopio Keck I da 10 metri, costruito su un vulcano inattivo, il Mauna Kea, alle Hawaii, è stato il primo a utilizzare questa tecnologia segmentata nel 1993, offrendo il doppio dell’apertura del telescopio Hale. Il Keck II seguì nel 1996, così come il telescopio Hobby-Eberly da 9,8 m presso l’Osservatorio McDonald in Texas, che utilizzava anch’esso un design segmentato.
La loro costruzione diede il via alla corsa per costruire telescopi terrestri giganti nella classe otto-dieci metri. Il telescopio giapponese Subaru da otto metri ha visto la prima luce sul Mauna Kea nel 1999, i telescopi Gemini Nord e Sud da 8,1 metri rispettivamente nel 1999 e nel 2001 e i quattro telescopi che possono lavorare in parallelo da 8,2 metri del Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio Europeo Australe sul Cerro Paranal in Cile hanno visto individualmente la prima luce tra il 1998 e il 2000.
Da allora sono comparsi sulla scena diversi telescopi anche leggermente più grandi: il Large Binocular Telescope con due specchi da 8,4 metri in Arizona nel 2004, il South African Large Telescope da 9,2 metri nel 2005 e il gigantesco Gran Telescopio Canarias da 10,4 metri nelle Isole Canarie nel 2006, che è attualmente il più grande telescopio ottico del mondo. E così, nel 2002, gli astronomi hanno utilizzato il WM Keck Observatory per confermare l’esistenza di un buco nero da 4,1 milioni di masse solari al centro della Via Lattea, utilizzando i movimenti delle stelle vicine.
Ora, l’attenzione degli astronomi si è rivolta alla prossima generazione di telescopi estremamente grandi, con aperture di decine di metri. L’Extremely Large Telescope (ELT) da 39 metri dell’Osservatorio europeo australe è in costruzione in cima alla montagna Cerro Armazones in Cile, con l’intenzione di vedere la prima luce entro la fine di questo decennio. I suoi contemporanei saranno uno, se non entrambi, il Thirty Meter Telescope (TMT) e il Grand Magellan Telescope (GMT), che se verrà costruito avrà sette specchi larghi 8,4 metri che daranno un’apertura totale di 25,4 metri.
I risultati ottenuti
Cosa ha permesso di fare questo esercito di telescopi giganti? Ovviamente le scoperte sono state e sono innumerevoli, e raccontarle tutte sarebbe forse noioso. Però qualche esempio è utile. Quando le onde gravitazionali furono rilevate da una collisione tra due stelle di neutroni nell’agosto 2017, il bagliore residuo dell’esplosione, chiamato kilonova, fu individuato in una galassia a 140 milioni di anni luce di distanza.
Un altro esempio è quello raggiunto nel 2004 e confermato nel 2005 dagli astronomi che hanno utilizzato il Very Large Telescope, riprendendo l’immagine di un pianeta con una massa compresa tra cinque e sei volte quella di Giove, chiamato 2M1207b, in orbita attorno a una nana bruna (oggetto simile ad una stella, ma con massa troppo piccola per sostenere a lungo la fusione dell’idrogeno) a 230 anni luce di distanza. I primi esopianeti attorno a stelle simili al Sole furono scoperti nel 1995. Non servono grandi telescopi per trovare gli esopianeti: telescopi piccoli sono in grado di farlo.
Ciò di cui c’è bisogno, tuttavia, sono grandi aperture con sufficiente sensibilità per iniziare a caratterizzare questi mondi alieni, prima attraverso la spettroscopia delle loro atmosfere e poi cercando di fotografarli direttamente; in altre parole, dobbiamo scattare foto nitide. Sebbene, al momento, la fotografia diretta di un esopianeta sia possibile solo per mondi molto grandi che brillano intensamente nella luce infrarossa grazie all’energia che contengono ancora dalla loro nascita.
Ad esempio, l’esopianeta meno massiccio ripreso con SPHERE è AF Leporis b, che è tre volte la massa di Giove. Siamo ancora molto lontani dunque, dal riuscire a fotografare pianeti con massa simile a quella terrestre. L’obiettivo, tuttavia, è di riuscirci un giorno e magari catturare direttamente l’immagine di un pianeta con massa simile a quella terrestre che si trovi anch’esso nella zona abitabile della sua stella.
L’ottica adattativa
Tuttavia, per essere chiari, non è scontato che la prossima generazione di telescopi terrestri sarà in grado di realizzare questo. «La rilevazione diretta è davvero difficile perché si ha un rapporto di contrasto estremo tra la stella luminosa e i pianeti molto deboli», ha detto Verma. «A causa della sua grande apertura, l’ELT ha la maggiore possibilità di arrivare fino ai pianeti rocciosi e potenzialmente a qualcosa di simile alla Terra rispetto al TMT e al GMT. Anche se richiede un livello di correzione per la perturbazione atmosferica con “ottica adattiva” che è davvero impegnativo».
L’atmosfera del nostro pianeta impedisce un’osservazione chiara del cielo. Possiamo vedere gli effetti deleteri dell’atmosfera nel modo con cui le stelle scintillano, come conseguenza delle correnti termiche che perturbano l’atmosfera stessa. Ciò crea un limite a quanto bene un telescopio, indipendentemente dalle sue dimensioni, può risolvere un oggetto celeste. L’idea dell’ottica adattiva è che un telescopio si concentri su una stella artificiale prodotta sparando un raggio laser nel cielo.
Un sensore è quindi in grado di leggere la luce di quella stella guida, che scintilla a causa della turbolenza e conferisce ai computer del telescopio i dati che permettono a piccoli attuatori, ossia piccoli “pistoncini” che agiscono su uno specchio, facendo sì che questi si fletta su scale di millisecondi per contrastare la turbolenza e produrre un’immagine nitida della stella guida, e, quindi, qualsiasi altra cosa il telescopio sta guardando e ciò permette una risoluzione molto maggiore. Questa è la base di come funziona l’ottica adattiva standard, che ha permesso a grandi telescopi terrestri come Keck e il VLT di avvicinarsi alle capacità del telescopio spaziale Hubble negli ultimi 25 anni. Ed è un ottimo modo per riprendere mondi giganti lontani dalla loro stella. Per riprendere direttamente pianeti di massa terrestre nella zona abitabile della loro stella, tuttavia, ci vorrebbe qualcosa di ancora più speciale: un’ottica adattiva estrema.
Ne vale la pena?
Ma tutto ciò vale la pena visti i risultati degli ultimi telescopi spaziali? Non c’è dubbio che i risultati migliori si ottengono ancora dallo spazio, ma il James Webb Space Telescope è costato quasi 10 miliardi di dollari, mentre l’ELT costerà solo circa 1,6 miliardi. L’astronomia dallo spazio è costosa, quindi i telescopi spaziali saranno pochi, lasciando molti astronomi in tutto il mondo senza un facile accesso a un grande telescopio.
Ma non solo un telescopio spaziale posto dove si trova il Webb, ad esempio, risulta quasi impossibile da raggiungere e se dovesse guastarsi sarebbe difficile se non impossibile raggiungerlo. I grandi telescopi terrestri possono essere migliorati nel corso del tempo, se la tecnologia “inventa” qualcosa di nuovo. Insomma per l’astronomia c’è “spazio” sia per i telescopi spaziali che per quelli terrestri.
© Riproduzione riservata