Le nanoplastiche sono ancora più invasive rispetto alle microplastiche. Le loro dimensioni così piccole fanno sì che possano essere trasportate più facilmente su lunghe distanze, ancor più rispetto alle microplastiche
Dall’Everest fino agli oceani e al cibo, tutti i danni delle nanoplastiche
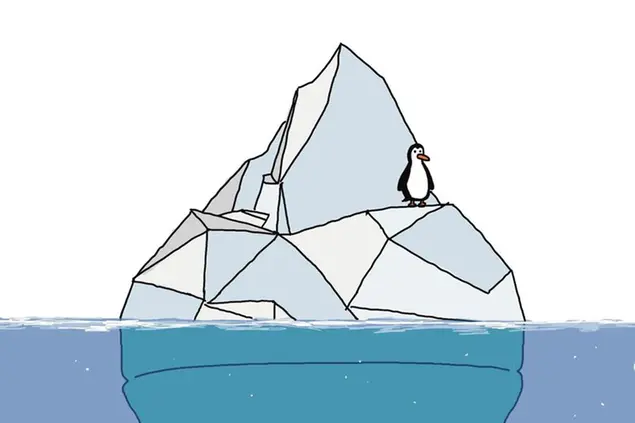
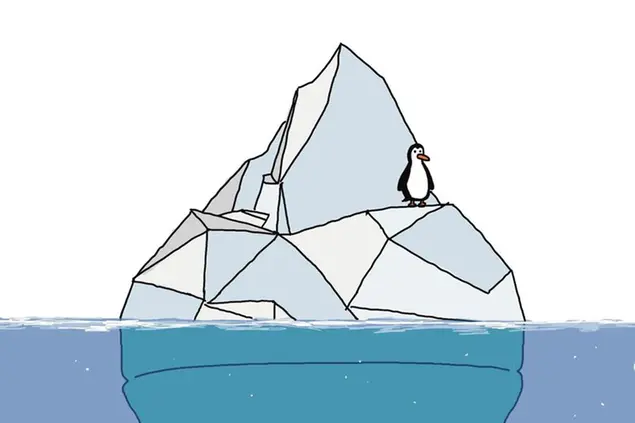
09 giugno 2024 • 17:32

