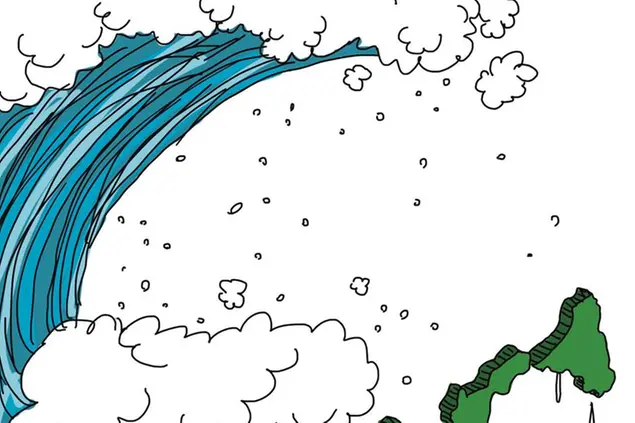- Uno studio condotto dall’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna (Cnr-Ismar) ha ricostruito e pubblicato su Scientific Reports le tracce di uno tsunami che circa 1600 anni fa ha colpito le coste del Mediterraneo.
- Lo studio si è concentrato su un deposito di sedimenti spesso fino a 25 metri presente nel mar Ionio. Sono il risultato di un forte tsunami avvenuto nel 365 d.C., originato a Creta e che ha coinvolto Calabria e Sicilia.
- Le caratteristiche di questo deposito hanno permesso di identificare altri due eventi più antichi avvenuti circa 15 e 40 mila anni fa. La ricerca coordinata dal Cnr-Ismar è stata pubblicata su Scientific Reports.
Uno studio condotto dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna (Cnr-Ismar) ha ricostruito e pubblicato su Scientific Reports le tracce di uno tsunami che circa 1.600 anni fa ha colpito le coste del Mediterraneo, incluse Sicilia e Calabria meridionale. La ricerca riguarda un’area abissale nel mar Ionio, tra l’Italia, la Grecia e l’Africa, dove un deposito di sedimenti marini che raggiunge i 25 metri di spessore è stato deposto in modo quasi istantaneo dalla forza catastrofica delle correnti indotte dall’onda di uno tsunami. Il mar Mediterraneo ospita fasce di subduzione lungo il limite tra le placche africana ed eurasiatica che hanno prodotto forti terremoti nel passato spesso associati a tsunami. Le aree di subduzione sono quelle dove una zolla della crosta terrestre si infila al di sotto di un’altra zolla. «Sulla base di descrizioni storiche e dell’analisi dei sedimenti prelevati dai fondali del mar Ionio, uno di questi eventi, avvenuto nel 365 d.C., ha interessato un’ampia area geografica incluse regioni distanti circa 800 chilometri dalla zona sorgente del sisma che si trova a Creta», spiega Alina Polonia del Cnr-Ismar.
La grande onda
«I campioni di sedimento analizzati hanno permesso di verificare che il materiale che si trovava in condizioni di acqua molto bassa è stato strappato dalla zona costiera e depositato a 4mila metri di profondità. L’onda dello tsunami ha prodotto molteplici frane sottomarine lungo un fronte di migliaia di chilometri, dall’Italia meridionale alle coste africane. Le correnti hanno trascinato sedimenti costieri nelle profondità abissali. Questo ha permesso la deposizione di un volume straordinario di sedimenti di oltre 800 km3 in tutto il Mediterraneo orientale».
Una conferma a quanto scoperto arriva da processi molto simili sono stati descritti anche durante il mega-tsunami del 2011 che ha devastato le coste giapponesi.
Le caratteristiche del deposito hanno permesso di identificare altri due eventi più antichi che rappresentano i predecessori di quello di Creta consentendo di acquisire elementi utili per una più corretta valutazione del rischio tsunami sulle nostre coste.
Sottolinea Polonia: «Lo studio dimostra che uno tsunami può scaricare volumi significativi di sedimenti e carbonio organico nelle profondità oceaniche, influenzando così il ciclo geochimico globale e gli ecosistemi dei fondali marini».
Uno studio che una volta ancora di più dimostra come tutte le coste del Mediterraneo e dunque della nostra Penisola siano a rischio di questo fenomeno che può causare migliaia di vittime se non si interviene ad istruire la popolazione del possibile rischio e sull’istruire le persone su come comportarsi in caso che si abbia tale evento.
Lo studio dell’universo primordiale
Si chiama Qubic (Q&U Bolometric Interferometer for Cosmology), il nuovo telescopio che si sta realizzando in Argentina per lo studio dell’universo appena nato e che utilizzerà per le sue ricerche una tecnica completamente innovativa. Qubic, infatti, osserverà e mapperà le proprietà del “fondo cosmico a microonde”, ossia l’eco, o se si vuole, quel che è rimasto come impronta residua del Big Bang.
Si concentrerà sulla «misura di particolari componenti dell’orientamento dell’oscillazione delle microonde della radiazione cosmica di fondo sul piano del cielo (polarizzazione), denominate modi-B, indicative delle possibili perturbazioni indotte dalle onde gravitazionali generate nei primi istanti di vita dell’universo».
Questa definizione della ricerca fa capire quanto sia estremamente complessa, ma che avrà come contraltare risultati finora inaspettati. Per i non addetti ai lavori il tutto lo si può semplificare dicendo che le ricerche si concentreranno sulla raccolta di informazioni per studiare e fornire le prove della “teoria dell’inflazione”.
Secondo tale teoria, la rapidissima fase di espansione dell’universo subito dopo il Big bang, durata meno di un centomillesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo (circa 10-32 secondi), avrebbe lasciato un debole fondo di onde gravitazionali, che a loro volta avrebbero prodotto particolari debolissime tracce, detti modi-B, nella polarizzazione del fondo cosmico di microonde.
In pratica, le onde elettromagnetiche del fondo cosmico non oscillerebbero in direzioni casuali, ma sarebbero invece leggermente allineate lungo direzioni che in cielo formerebbero un disegno vorticoso.
È evidente che se si avesse una simile conferma, ciò permetterebbe di essere ancora più certi che realmente il nostro universo partì dal Big bang. «Qubic è uno strumento originale ed estremamente complesso: per questo era necessario pubblicare in anticipo i dettagli del suo hardware e delle nuove metodologie di sfruttamento dei dati raccolti. È un passo essenziale per le successive misure di interesse per la cosmologia e la fisica fondamentale», spiega Silvia Masi, docente dell’Università La Sapienza di Roma e ricercatrice Infn, che coordina la partecipazione italiana all’esperimento.
In altre parole era necessario che gli astrofisici conoscessero al meglio le metodologie di ricerca per meglio interpregtare i risultati. «Qubic verrà portato nel sito di Alto Chorrillo entro pochi mesi. Le prime misure dimostreranno l’efficienza del nuovo metodo di ricerca per la prima volta osservando sorgenti astronomiche. Lo strumento verrà poi completato inserendo un maggiore numero di rivelatori, in modo da poter eseguire le misure di interesse cosmologico entro tre anni. La strada è lunga, e Qubic si presenta come estremamente originale e complementare a tutti gli altri che cercano di misurare questo elusivo segnale primordiale», spiega Aniello Mennella, ricercatore Infn e docente all’Università di Milano.
Il contributo italiano è stato fondamentale per lo sviluppo dello strumento, e continuerà ad esserlo nelle fasi successive dell'esperimento.
Uccelli alpini a rischio
La pernice bianca, lo spioncello, il sordone e il fringuello alpino, quattro specie di uccelli associate agli ambienti alpini e ai climi freddi che li caratterizzano, sono a rischio estinzione a causa dei cambiamenti climatici in atto negli ambienti di alta montagna sulle Alpi, dove gli effetti del riscaldamento globale sono più evidenti.
Tuttavia, possono sopravvivere grazie alla salvaguardia di circa 15mila km2 di rifugi climatici, ovvero aree che rimarranno idonee per queste specie a prescindere dal modello climatico considerato.
Lo studio internazionale, coordinato da Mattia Brambilla ricercatore in ecologia presso il Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell’Università degli studi di Milano, è stato appena pubblicato su Global Change Biology.
I modelli di distribuzione, basati su variabili climatiche, topografiche e di uso del suolo, sono stati “proiettati” su diversi scenari rappresentanti le condizioni attuali e quelle future, permettendo così di valutare le probabili variazioni nell’areale delle diverse specie.
Dalla situazione attuale al periodo 2041-2070, tutte e quattro le specie considerate andranno incontro a una modifica della distribuzione sulle Alpi, con un innalzamento della quota media di presenza, che potrà oltrepassare i 400 metri nei casi più estremi.
Con la parziale eccezione dello spioncello, queste specie subiranno anche una contrazione della superficie di aree idonee, compresa tra il 17 per cento e il 59 per cento a seconda delle specie e degli scenari climatici.
In questo quadro poco incoraggiante, ma purtroppo in linea con quanto lecito attendersi per queste specie, emerge un risultato che fa sperare e, al tempo stesso, chiama all’azione: circa 15mila km2 di territorio alpino risultano idonei per queste specie nelle condizioni attuali e lo rimarranno anche in futuro, a prescindere dal modello climatico considerato.
Si tratta quindi di siti di cruciale importanza per la conservazione degli ecosistemi alpini e della biodiversità di alta quota. Il 44 per cento di queste aree è attualmente incluso in aree protette, ma anche il restante 56 per cento dovrebbe essere tenuto in debita considerazione, considerata l’importanza di tali siti.
«Ipotizzare come la distribuzione delle specie d’alta quota cambierà, e quali aree continueranno a offrire condizioni idonee anche in un futuro caratterizzato da un clima più caldo, è di fondamentale importanza per la conservazione di questi organismi sensibili alle variazioni ambientali. Queste aree rappresentano dei “rifugi climatici” per la biodiversità alpina e devono essere salvaguardati, evitando alterazioni significative causate dalle attività umane e degrado degli habitat», commenta Brambilla.
Il concetto di “rifugio climatico”, sempre più frequentemente utilizzato nella letteratura ecologica in relazione agli effetti del climate change, indica quelle aree che sono in grado di mantenere le proprie caratteristiche fondamentali nonostante il cambiamento climatico, consentendo così la persistenza di organismi o risorse importanti da un punto di vista ecologico, fisico o socioculturale.
Civiltà di Tipo I
Partiamo da una premessa: Nikolai Kardashev, un astrofisico russo che visse tra il 1932 e il 2019, propose nel 1964 un metodo di classificazione delle civiltà in funzione del loro livello tecnologico che è diventata nota come Scala Kardashev.
Una “Civiltà di tipo I” è quella che riesce a ottenere il massimo rendimento da tutta l’energia che arriva dalla stella attorno alla quale il suo pianeta orbita. Quella di “tipo II” è una civiltà che riesce a sfruttare tutta l’energia della stella, anche quella che non raggiunge il pianeta.
Quella di “tipo III” sfrutta tutta l’energia presente nella sua galassia. Altri autori si sono poi spinti in ulteriori aggiunte, ma poco importa al momento, almeno per noi. Il nostro livello, in base a questa scala, è ancora ben al di sotto del primo gradino, in quanto segna un valore di 0,73.
Quando raggiungeremo il livello di “Tipo I”? Per arrivare a un livello di civiltà di tipo I dovremmo essere in grado di sfruttare molto intensamente ogni fonte d’energia, non solo quelle rinnovabili ma anche quelle relative ai combustibili fossili o al nucleare e dunque tutta quell’energia, comunque originata dal Sole, ma “immagazzinata” nella terra.
Al momento sappiamo utilizzare per bene quella fossile, anche se ora l’idea più o meno comune sarebbe quella di farne il più possibile a meno per evitare le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Ci manca invece la capacità di sfruttare appieno l’energia degli atomi che otterremo quando si riuscirà a sfruttare la fusione nucleare. E poi non siamo ancora in grado di raccogliere l’energia che ci arriva dal sole per convogliarla sulla terra. Insomma i passi da fare sono ancora tanti.
Quando allora ci arriveremo? I calcoli di uno studio pubblicato su Arxiv dicono che potremmo arrivarci nel 2371. C’è ancora molta strada, dunque, da fare, ma la scelta del percorso non sembra essere sbagliata. E per arrivare ad essere una Civiltà di “Tipo II”? Non si parla di secoli, ma di millenni, in quanto si dovrà riuscire ad imbrigliare l’energia emessa dal sole a 360° e inviarla sulla terra. Mentre per diventare una “Civiltà di Tipo III”, per la nostra umanità è ancora un sogno da fantascienza.
© Riproduzione riservata