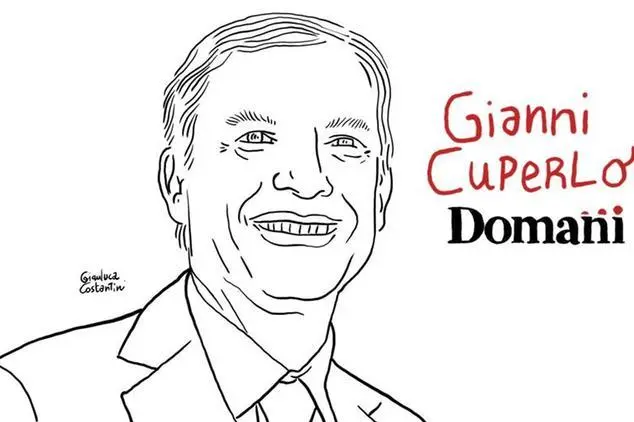A scorrere interviste, analisi, commenti sul turno amministrativo di domenica colpisce un dato, anzi due. Per un verso l’accanimento sulle pregiudiziali nelle alleanze future: «Con quelli mai. Letta scegli: o noi (leggi, Calenda, Renzi, centristi di varia foggia) o loro (leggasi Conte e M5s)». Questa rigidità ha trovato la spiega in risultati interpretati quale conferma della linea seguita, in altre parole «le urne ci hanno dato ragione», e ciò pure quando i numeri, a leggerli bene, dicevano altro.
Il secondo elemento è stato richiamare tutti al “merito” dei possibili accordi, da lì l’appello a misurare nel concreto affinità o distanze. Fisco, mercato del lavoro, scuola e sanità pubblica, fondi europei: l’elenco programmatico ha il taglio che sappiamo, in questo caso a segnare la differenza è stato lo spirito volitivo di chi – per parte mia mi annovero nel bel numero – è convinto sia possibile, oltre che necessario, bypassare i veti tramite una ricetta condivisa.
In sintesi, da un lato si è scatenata una polemica sulle alleanze politiche (quali sigle sommare nel centrosinistra che sfiderà la destra a trazione non più leghista), dall’altro è ripartito il confronto sul programma comune da sottoporre agli italiani. Allora tutto bene? Non proprio. Nel senso che entrambe le reazioni sembrano sottovalutare i due convitati di pietra di queste elezioni.
L’astensione patologica che impatta e incrina la tenuta stessa della nostra democrazia e le modalità con le quali ricostruire flussi di scambio e canali di partecipazione finalizzati anche, non solo ma anche, a rigenerare gli istituti della rappresentanza. Il punto è che per affrontare questo nodo, fondamentale per vincere la prossima sfida nelle urne, non basta sommare un certo numero di sigle o arruolare nello stesso perimetro leadership diverse. Neppure è sufficiente mettere nero su bianco le dieci o cento cose da fare nel primo mese di un governo progressista.
Poco meno di trent’anni fa l’Ulivo di Romano Prodi e i “Comitati per l’Italia che vogliamo” segnarono un cambio di stagione nel merito della proposta di governo e più ancora nel metodo con cui il disegno venne concepito e realizzato. L’intuizione di allora – unire in un’idea dell’Italia “da fare” l’impresa produttiva, il mondo del lavoro, l’arcipelago della cultura a partire da scuola, università e ricerca – si tradusse in una seria e faticosa azione di coinvolgimento e rigenerazione di un tessuto sociale che solo pochi mesi prima Berlusconi con la sua vittoria pareva avere spento per un tempo lungo. Quell’insegnamento – insisto, di metodo oltre che di merito – si rivelò decisivo. Credo che lo stesso dovrebbe accadere adesso.
Davanti a noi abbiamo una decina di mesi per attrezzare un campo il più esteso possibile di alleanze sociali, culturali e politiche. Ciò che dobbiamo sapere è che la vera chance a nostra disposizione ancora una volta sta nell’attivare, coinvolgere, rendere protagonisti pezzi di società oggi inascoltati e disaffezionati all’idea di una democrazia partecipata come radice di una cittadinanza consapevole. «Non è più tempo di fenomeni individuali», così l’altra sera Romano Prodi in un incontro pubblico nella sua Bologna.
Credo abbia profondamente ragione e se un segnale d’allarme il voto di domenica ha fatto scattare è proprio nell’invito a farsi carico di quest’opera laboriosa di associazione di un popolo che non intende cedere il passo alla destra regressiva di ora. Un tale bisogno Enrico Letta ha mostrato di comprendere a fondo. Altri sembrano fare più fatica, presi come sono nel gorgo di un protagonismo e personalismi fuori sincrono. Ma più di un motivo per coltivare l’ottimismo esiste. A una condizione: cominciare il lavoro per tempo senza attendere miracoli che non ci saranno. La vera differenza passerà da qui.
© Riproduzione riservata