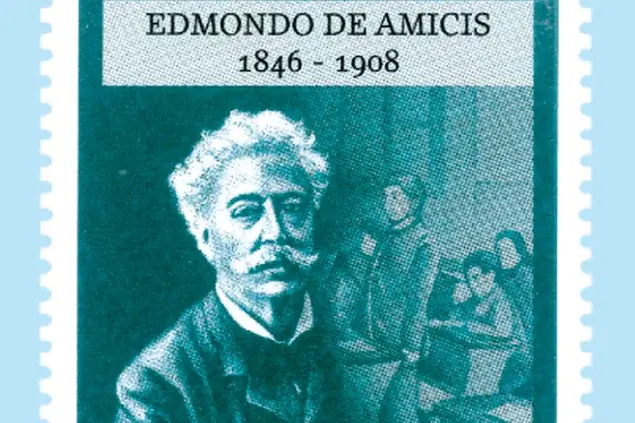Cuore e Pinocchio presi a riferimento da Loredana Perla nel libro “Insegnare l’Italia”. La professoressa è stata scelta dal ministro Valditara per riprogettare le indicazioni nazionali per i programmi scolastici. Un “pantheon” sbagliato, frutto di una lettura superficiale e corriva
Non c’è ragione di stupirsi, finanche perfino di indignarsi, per gli usi politici che possono farsi della letteratura (“giusti e sbagliati” che siano, come avrebbe detto Calvino). Nondimeno, è con un sentimento di stupore, venato di una certa inquietudine, che si leggono i capitoli III e IV del libretto di Ernesto Galli della Loggia e Loredana Perla, Insegnare l’Italia. Una proposta per la scuola dell’obbligo (Scholé).
Si tratta di quelli redatti dalla coautrice, docente di Didattica e pedagogia speciale presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, da poco nominata dal ministro Giuseppe Valditara coordinatrice di una commissione di studio che dovrà elaborare e formulare proposte volte alla revisione delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida relative al primo e al secondo ciclo di istruzione (ne ha scritto su questo giornale Italo Fiorin il 20 maggio scorso).
Non che siano da trascurare i primi due, vergati da Ernesto Galli della Loggia; ma si tratta, in quel caso, di una rielaborazione sintetica di concetti che lo storico ripropone da decenni: a proposito della questione dell’identità italiana (quasi una ossessione, la sua), nonché di una auspicata “riforma” della scuola, che faccia piazza pulita di mezzo secolo di innovazione didattica e dei principi della scuola democratica.
Non si risentirà, pertanto, il professore editorialista del «Corriere della sera», se a incuriosire di più sono le pagine di chi è preposta, appunto, a riprogettare i curricoli del sistema scolastico italiano prima dell’Università.
Cuore e Pinocchio
L’orientamento sembra essere proprio quello minacciato dal titolo del volume: incentrare il progetto pedagogico destinato a bambini e adolescenti sull’insegnamento dell’identità italiana, della sua storia, della sua geografia, della sua cultura.
Per suffragare la propria proposta, Perla ricorre a due classici della narrativa per ragazzi del secondo Ottocento: Cuore e Le avventure di Pinocchio, da riportare perentoriamente nelle aule scolastiche.
Come ci si poteva aspettare, dai due romanzi la pedagogista ricava un florilegio di spunti e suggestioni a sostegno delle sue tesi: l’istruzione come apprendimento dell’italianità («Cuore è un dispositivo didattico perfetto per insegnare le “coordinate di popolo”, quelle che ogni bimbo bimba italiani dovrebbero in interiore homine maturare»), il ripristino dell’autorità genitoriale (paterna, per lo più) e magistrale, la rimozione delle differenze (di classe, di genere…), la liquidazione della pedagogia «sessantottina» e di «una intera stagione che ha lasciato in eredità ai suoi posteri mille e una mela avvelenata».
«Il vostro fratello»
Sarebbe troppo facile e scontato criticare De Amicis accodandosi a una lunga lista di autorevoli denigratori (da Eco ad Arbasino, da Natalia Ginzburg a Paolo Poli), o evidenziarne l’anacronismo (nondimeno non si può non rilevare come venga ignorata, dalla studiosa, una più recente produzione di narrativa per ragazzi di altissimo livello).
Ci pare più interessante, semmai, rovesciare l’assunto da cui muove Perla, come ha fatto Marcello Fois ne L’invenzione degli italiani. Dove ci porta Cuore (che l’autrice cita, ma sembra avere letto distrattamente): non solo perché da quel paternalismo umanitario e ingenuamente irenico, «irrigidito in una retorica, in un sentimentalismo ricattatorio» (per citare un altro elogio di Cuore, quello di Filippo La Porta, anch’esso distantissimo dalle tesi del libro), da quella fiducia incondizionata per la nuova Italia, De Amicis si sarebbe affrancato pochi anni dopo, aderendo al Partito socialista e spostandosi su posizioni più radicali e conflittuali.
Ma, appunto, perché perfino il suo romanzo più celebre potrebbe essere riletto come un viatico per una scuola dell’inclusione, addirittura antesignana di quell’universalismo cosmopolita tanto deprecato da della Loggia e Perla.
Il muratorino che «sa fare il muso di lepre» anticipa il famigerato Cardini dei romanzi Ex cattedra e Sottobanco di Domenico Starnone e del film La scuola che ne ha tratto Daniele Luchetti, il cui unico talento è fare bene la mosca (e a questo si appiglia, per provare a salvarlo, il professor Vivaldi, campione di quella idea di scuola che gli autori vorrebbero spazzare via); il ragazzo calabrese che si è aggregato alla classe viene accolto con queste parole dal maestro Perboni: «Vogliate bene al vostro fratello venuto da lontano [...] Fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana mette il piede, ci trova dei fratelli»: facile immaginare chi possa essere, nella scuola dell’obbligo del 2024, lo scolaro «dal viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte; tutto vestito di scuro», italiano come i suoi compagni, a dispetto degli inaccettabili ritardi della legislazione italiana.
«Un ragazzino perbene!»
“Eccellenza”, lemma prevedibilmente assai ricorrente in Insegnare l’Italia, è il modo in cui Pinocchio appella Mangiafuoco, per blandirlo e convincerlo a non fare di Arlecchino legna da ardere. Le chiavi interpretative del capolavoro collodiano che lo rendono irriducibile a una pedagogia nazionalista di tale sorta, sono così numerose (oltre che ovvie) che è impossibile riassumerle qui: l’irrisione verso le figure della legge e del potere costituito (i gendarmi, il giudice scimmione, l’imperatore di Acchiappacitrulli); la crudeltà degli adulti nell’esercizio delle loro funzioni (il domatore di asinelli del circo, il proprietario del campo dove Pinocchio ruba l’uva, l’ortolano che come salario gli dà un bicchiere di latte); adulti che oltretutto si rivelano assai più frequentemente infingardi e mentitori di quanto non lo sia il burattino (la Volpe e il Gatto, l’Omino di burro); il maternage di Geppetto in una famiglia monogenitoriale e non-naturale...
Non meno cospicua è la bibliografia critica che lo affranca da corrive letture edificanti. Ci basti qui solo una notazione di Daniela Marcheschi: il punto esclamativo seguito dalla reticenza dell’ultima battuta del racconto («Com’ero buffo, quand’ero un burattino! E come ora son contento di esser diventato un ragazzino perbene!...», dice Pinocchio «dentro di sé con grandissima compiacenza») sono il varco testuale che l’umorista Collodi apre, con ironia e cercando la complicità del lettore, per lasciare fuggire il suo puer, affinché si sottragga al conformismo dei grandi e conservi la libertà e la vitalità, la curiosità e l’irriverenza dell’infanzia.
© Riproduzione riservata