- Arrivando al pranzo a casa del senatore Scheurer-Kestner, organizzato per discutere del processo ad Alfred Dreyfus, lo scrittore Émile Zola non aveva certezze
- Zola si avvicinò con lentezza all’affaire Dreyfus e quando ne comprese la portata sposò la causa principalmente per un motivo estetico. Perché era bella come un dramma. E lui ne voleva fare parte
- Ma fondamentale, per lo scrittore, fu l’incoraggiamento delle donne. Senza loro, probabilmente, non avremmo avuto il J’Accuse…!
Nell’istante in cui si accomodò a tavola, Zola era certo solo della posizione che stava per assumere sprofondando sulla sedia. Erano in cinque quel sabato 13 novembre 1897. Oltre a lui, il senatore Scheurer-Kestner aveva convocato a pranzo il drammaturgo Prévost, l’avvocato Leblois e il procuratore generale Sarrut. Il padrone di casa desiderava avere un consiglio da «uomini abituati a parlare con le masse». Émile Zola si avvicinava ai sessant’anni, era lo scrittore francese più tradotto nel mondo e non era interessato alla politica. Tantomeno all’Affaire (lo scandalo giudiziario generato, tre anni prima, dall’arresto per tradimento del capitano ebreo Alfred Dreyfus).
Il caso era giunto a un punto cruciale. Il senatore conosceva il nome del colpevole, il comandante Esterházy, e non poteva rivelarlo pubblicamente ma al tempo stesso non era riuscito a mobilitare nessuno del mondo politico: aveva incontrato il presidente Faure (29 ottobre), il ministro della Guerra Billot (30 ottobre), il primo ministro Meline (2 e 3 novembre) e il ministro della giustizia Darlan (5 novembre). Tutti gli avevano voltato le spalle.
Se si doveva perseguire la via legale, denunciando Esterházy, questa andava supportata con un movimento di opinione. Il piccolo drappello dei dreyfusardi si trovò quindi attorno a quel tavolo per organizzare una strategia capace di colpire l’invalicabile muro di resistenza del ministero e aprire così le porte a una possibilità di revisione del processo.
Il pranzo
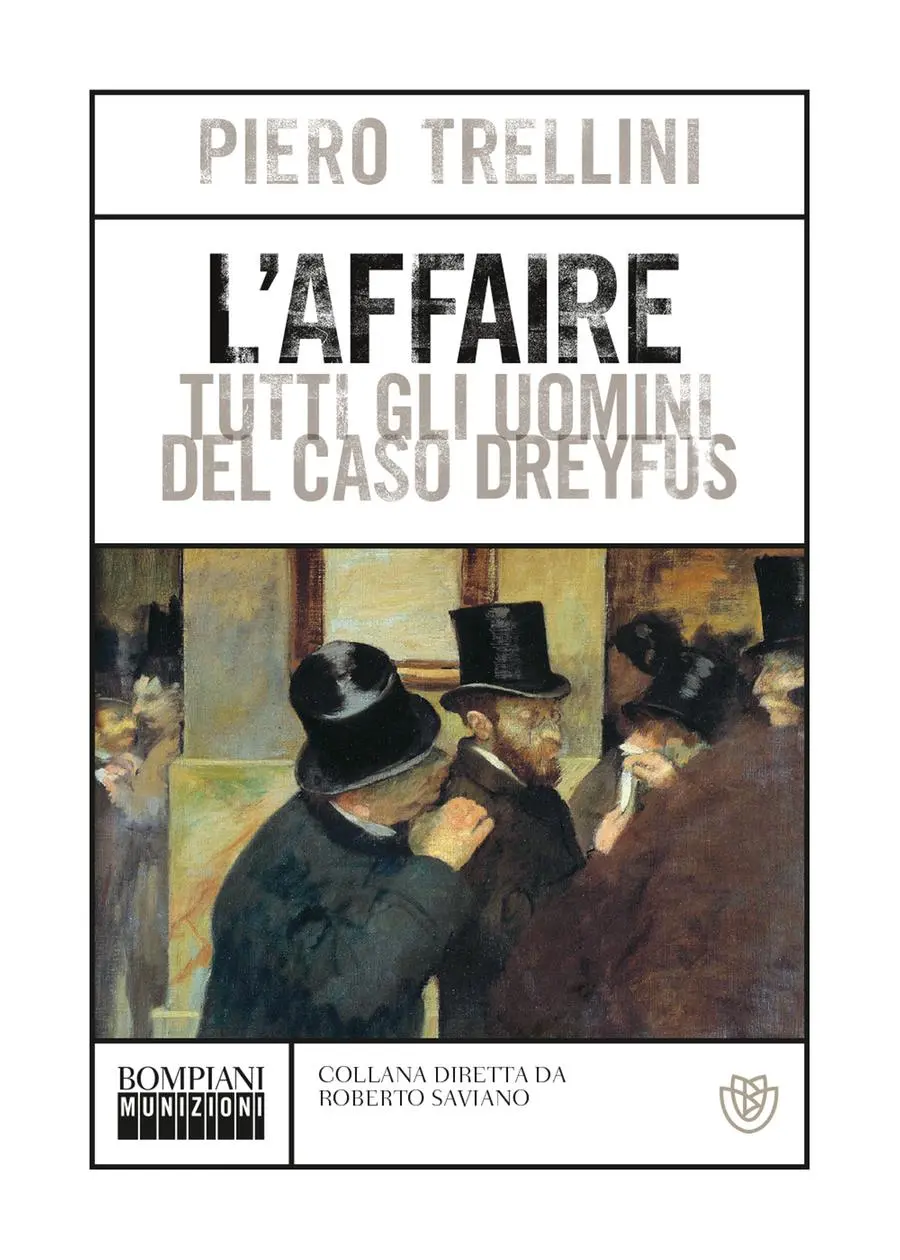
Zola assaggiò appena lo stufato di lepre, si tenne lontano dal vino e non fumò. Terminate le pietanze e conclusi i convenevoli, Scheurer-Kestner pregò Leblois (amico e confidente del colonnello Picquart, capo dal Servizio informazioni, destituito dopo il suo interessamento alla causa) di mettere al corrente quei signori di quanto sapeva. E lui incominciò. Mentre lo ascoltava Zola già fluttuava nella poesia. «È avvincente!», sussultava. E poi: «È appassionante!». E ancora: «È orribile!». E di più: «È un dramma spaventoso!». E di nuovo: «È la storia più incredibile che abbia mai ascoltato!».
Fu la vicenda che andò a incontrare Zola. Perché l’Affaire a quel punto era pronto per essere raccontato. Perché solo allora il melodramma gli apparve completo e lui ne vide finalmente i personaggi. Come nel Conte di Montecristo c’erano un innocente richiuso in un’isola sperduta e un colpevole libero di camminare per la strada. Ma in quel momento se ne era aggiunto un altro, silenzioso e attivo: il detentore della verità Scheurer-Kestner. Fu questo personaggio a farlo entrare nel dramma. Fu questo quadro a fargli percepire la bellezza. E la bellezza, inevitabilmente, lo risucchiò.
Dovette quindi scattare l’egoismo, un anelito di bene interessato, per poter fare un passo avanti. Fu esattamente in quel luogo, attorno a quel tavolo, che la natura estetica dell’Affaire ricevette il riconoscimento di Zola perché in quel piacere il suo senso vitale era stato chiamato direttamente in causa.
Terminato il pranzo ognuno sapeva cosa fare. Scheurer-Kestner aveva il compito di bucare il muro del silenzio. Zola quello di rendere avvincente la storia, dosandone le rivelazioni, come in un romanzo a puntate, in modo da tenere alta l’attenzione dei lettori. Questo avrebbe permesso di veicolare le iniziative degli altri evitando di farle cadere nel vuoto.
La sera Zola scrisse a sua moglie Alexandrine (in Italia dal 10 ottobre): «Mi sembra assolutamente certo che Dreyfus non abbia compilato il documento per il quale è stato condannato; ed è anche certo che al ministero della Guerra lo sappiano da un anno, senza che un solo ministro si sia mosso. È mostruoso».
Parigi rimase sepolta dalla nebbia. La mattina del 24 novembre, Zola non riusciva più a dormire, si sentiva ossessionato dalle parole, doveva liberarsene. Guardò fuori dalla finestra e gli sembrò di trovarsi a Londra. Quando alle nove e mezza entrò nel suo studio, dovette accendere la luce elettrica per lavorare. Si mise al tavolo e iniziò a fare ordine. Gli era insopportabile il pensiero che in mezzo a milioni di individui che intendevano custodire la facilità della propria esistenza, Scheurer-Kestner avesse preferito avere una vita difficile, perché incapace di evitare di dire la verità. Sentì di dover prendere posizione. Dentro di lui questa mutazione di prospettiva fu rapida ma non indolore. Misurò i rischi del suo impegno e scelse di non sottrarsi al ruolo che gli era stato proposto.
Così Zola iniziò: «Che dramma straziante e che personaggi magnifici! Di fronte a documenti di una bellezza così tragica che la vita ci pone davanti, il mio cuore di romanziere freme di appassionata ammirazione». Eccolo il melodramma. Eccoli i suoi attori: «Da questo momento, appartengono a me, che sono soltanto un passante con gli occhi aperti sulla vita».
L’articolo
Durante la stesura venne disturbato da quattro visite. Alle dodici e mezza finì il suo articolo, il primo direttamente a favore di Dreyfus (concluso con il più bello dei moniti: «La verità è in marcia e niente potrà fermarla»), si vestì di corsa e andò a pranzo dal suo editore Eugène Fasquelle, che lo attendeva da un’ora e un quarto nel suo nuovo appartamento, al 134 del boulevard Haussmann. Mangiò ostriche di Marennes, piedino di maiale tartufato di Jamais, quaglie e piselli. Uscito da casa Fasquelle, Zola camminò lungo il boulevard avvolto in una tremenda nebbia gialla entro la quale lasciò vagare indisturbati i suoi pensieri. Alle nove, dopo aver cenato con i bambini, corse alla redazione del Figaro per rivedere il suo pezzo. Tre quarti d’ora dopo, tutto era compiuto.
Appena rientrò scrisse ad Alexandrine: «Credo che il mio articolo sia molto buono e che avrà un grande effetto. Ho trovato vigliacco rimanere in silenzio. Temo per le conseguenze, ma sono abbastanza forte e coraggioso. Domani mattina, ho l’impressione che tutti i cronisti di Parigi saranno appesi al mio campanello». E così andò.
Il giorno dell’uscita dell’articolo – era il 25 novembre – Zola aveva pranzato con gli scrittori Barrès e Bourget da Durand, un raffinato ristorante al 2 di place de la Madeleine. Intorno a loro, gli sguardi dei commensali erano diretti tutti verso lo scrittore. Terminato il pranzo, Zola era tornato a casa e aveva trovato 20 lettere, tutte di congratulazioni per l’articolo della mattina. «Finalmente un piccolo omaggio alla mia onestà e al mio coraggio», aveva scritto alla moglie.
Esaltato da quei primi incoraggiamenti due giorni dopo aveva aggiunto: «È una tempesta davvero terribile. Non hai idea del disastro. Non ho mai visto una simile bufera infuriare sulla stampa». Fu proprio la stampa, però, a voltargli le spalle. Bastarono, infatti, altri due articoli (usciti il 1° e il 5 dicembre) per far sollevare i lettori del Figaro e portare il direttore Fernand de Rodays ad abbandonare la partita. Ma gli avvenimenti erano in cammino e Zola li aspettava, risoluto a dire tutto, a lottare fino alla fine perché la verità risplendesse e venisse fatta giustizia. Ormai era dentro. Continuò la sua campagna da solo con una lettera «ai giovani» e una «alla Francia» che fu costretto a fare uscire come opuscoli (il 14 dicembre 1897 e il 6 gennaio 1898).
Per calmare gli animi, intanto, era stato allestito un processo a Esterházy. Zola stava progettando di scrivere un romanzo sulla vicenda quando l’11 gennaio giunse la notizia dell’assoluzione del comandante. Sembrò la fine di tutte le battaglie. E in fondo lo era. L’innocenza riconosciuta del colpevole confermava definitivamente la colpevolezza dell’innocente. Invece accadde qualcosa di assolutamente inaspettato. Un colpo di scena che avrebbe cambiato tutto. Per sempre.
La stesura
Zola capì che quello era il momento. Così si sedette al tavolo e iniziò a scrivere.
Lavorò per un giorno e due notti. Quando alzò la testa aveva steso 44 su 40 fogli numerati nell’angolo in alto a destra. Lui stesso li contrassegnò da 1 a 39 (perché nella fretta aveva nominato due volte la pagina 23). Scrisse ordinatamente, in bella grafia, una media di venti righe di testo per foglio. 4.576 parole, 23.074 caratteri alfabetici tracciati, a mano, sulla carta tra 4.534 spazi ritmati ai fini di una rappresentazione (du Paty de Clam prima apparetre poi entre en scène, Esterhazy prima entre en scène poi paraît).
Il flusso emerse lucido, furioso e senza incertezze. 134 cancellature e appena dieci aggiunte. Eliminò perlopiù ripetizioni, e soprattutto le mezze misure. Se aggiunse o corresse fu solo per rafforzare o per connotare moralmente i fatti senza lasciar spazio a sfumature. Non per spiegare (expliquer), dunque, ma per giustificare (justifier) la condanna si erano mossi i militari (pagina 13). Così anche per il secondo consiglio di guerra, aveva scelto dapprima l’aggettivo «ingiusto» che poi sostituì con «criminale» (pagina 25). Allo stesso modo, dunque, le indagini sul colonnello Picquart non erano solo «ingannevoli», scelta che cancellò, ma smisuratamente «oltraggiose» (pagina 31).
Usò «certamente» (certainement) una sola volta, riferendosi a Billot, alla sua paura di esporsi, sostituendolo a un più tenue «può darsi» (peut-être). Definì poi l’inchiesta condotta da de Pellieux e Ravary inizialmente «straordinaria» (pagina 23). Ma ci ripensò adottando «scellerata». E quello fu l’attributo che avrebbe ripreso per loro alla fine (pagina 36). La scelta oculata dei suoi aggettivi fu indirizzata a uno scopo preciso. Escludendo i più sterili determinanti, su 304 ne scelse 268 soggettivi, di questi 129 esprimevano un giudizio di valore, 95 dei quali erano negativi. Fu modellando questi che Zola fece passare le sue idee per rendere i fatti incontestabili e il pubblico sdegnato.
Per il romanziere sarebbe stato lui stesso, con quei fogli, a dare il calcio di inizio all’Affaire: «È solo oggi che comincia il caso, poiché oggi solo le posizioni sono chiare» (aggiungendo in extremis, a pagina 33, il secondo seulement). Prese il lavoro e lo fece stampare, come aveva fatto per le due lettere precedenti, ma nel momento di metterlo in vendita gli venne in mente di dare a questa sua terza missiva una più vasta risonanza, facendola pubblicare su un quotidiano.
La vigilia della pubblicazione
Era la sera dell’11 gennaio. I pensieri di Zola furono interrotti dall’entrata improvvisa di sua moglie: «Émile, stanno per servire la cena». Alexandrine posò gli occhi su quel mucchio di fogli sopra la scrivania del marito per poi sgranarli non appena lesse su una busta:
Manuscrit de ma “lettre à M. F. Faure”
«Pensi davvero che farà qualcosa?» chiese lei.
«Non ha importanza».
«Perché?».
«Quando uscirà saranno costretti a processarmi».
«Non te lo lascerò fare».
«Qualcuno deve portare il caso in tribunale».
«Allora lascia che lo facciano altri. Non riguarda te».
«Riguarda ognuno di noi».
Zola aveva diffamato cinque generali, un colonnello, un maggiore, tre periti e 14 membri di due tribunali marziali. Voleva farsi perseguire per portare il caso alla luce del sole e i testimoni a parlare.
«Credi di riuscire a convincere qualcuno a stamparlo?».
«Pensavo di tornare da chi ha pubblicato la mia prima poesia a Parigi 37 anni fa».
Quell’uomo era Georges Clemenceau, per tutti “il Tigre”.
La mattina del secondo giorno, il 12 gennaio 1898, Zola lasciò in un magazzino le copie del suo opuscolo e si recò in rue Montmartre a portare il suo pezzo alla redazione dell’Aurore. Sebbene appena nato, il giornale aveva già dimostrato indipendenza e coraggio. Clemenceau coinvolse il direttore responsabile Ernest Vaughan e i due chiesero a Zola di leggerlo ad alta voce. L’intera redazione si fermò. E quando lo scrittore ebbe finito rimasero tutti senza parole. Si domandarono cosa mai spingesse uno come lui che, a partire dal suo aspetto, non aveva nulla di eroico, a esporsi in quel modo per un capitano di artiglieria a lui sconosciuto. Zola aveva combattuto per gli impressionisti, i minatori, i derelitti e, in generale, per le vite degli altri, ma in quel momento stava decidendo di mettere a rischio la sua stessa vita. Perché?
La spinta delle donne
Se il primo motore era stata la bellezza era stato poi altro a spingerlo avanti. Un evento che poteva risiedere solo nel suo intimo, e che probabilmente aveva a che vedere con una moltitudine a lui sconosciuta e cara. Tra il 1° dicembre 1897 e il 28 febbraio 1898 – il periodo più caldo del suo impegno dreyfusardo, intrapreso con i tre articoli sul Figaro – lo scrittore aveva ricevuto 2.199 lettere. Duecentottanta di queste erano state scritte da donne. L’Affaire non era più una faccenda per soli uomini.
Croniste temerarie come Séverine, mogli coraggiose come Lucie Dreyfus, marchese impegnate come Marie-Louise Arconati Visconti o salottiere eclettiche come Geneviève Straus erano lì a dimostrare che le donne rappresentavano il reticolato sul quale erano state erette le quinte che contenevano quel dramma. E se quelle sentivano il bisogno di prendere carta e penna era perché avevano qualcosa da dire. Gli scrissero per incoraggiarlo, ringraziarlo o elogiarlo.
«So che non potete farvi lusingare dall’omaggio di una donna sconosciuta», scrisse una di loro, «ma un insormontabile sentimento mi spinge a esprimervi l’ammirazione che ho per voi». Per molte Zola stava diventando un punto di riferimento. E fu decisivo per lui saperlo. «Mi avete reso una persona migliore. Per questo vi ringrazio». In quel mare di parole luccicavano, come illuminati dal sole, verbi che andavano in una sola direzione: avanti. «Proseguite», «Continuate», «Insistete», «Perseverate», «Non vi fermate».
Da quella spinta Zola non poté che trarne forza. Ciò che contava, per un approccio scientifico come il suo, era un dato. All’inizio di quel 1898 la presenza delle donne era quasi raddoppiata rispetto al mese precedente e più che quadruplicata rispetto a novembre (raggiungendo un picco di partecipazione che mai più sarebbe stato superato in qualsiasi altro momento della vita dello scrittore). Grazie a quel dato, Zola si accorse di avere nelle donne un pubblico, e quindi un sostegno che prima sembrava non esistere, solo perché silente. Si sentì approvato, incoraggiato e sollevato da quella platea.
Arrivato a quel punto non poteva più deluderla, non poteva più tirarsi indietro. E infatti andò avanti. Spronato da una tale moltitudine lui per primo rafforzò la consapevolezza del proprio ruolo, dell’essere, a suo modo, eroe. Grazie a quella spinta gentile si sentì forte. E con forza gridò il suo atto d’accusa. Le donne, quel sesso a torto considerato debole, avevano consegnato a un uomo la certezza di una sua invincibilità.
Scrittore, non ideologo
Zola era sempre stato solo un romanziere. Non un politico, non un attivista, non un ideologo. La sua letteratura denunciava i malanni del suo mondo ma non voleva prescriverne la cura. La terapia era affare della politica. Perché, in quello stesso mondo che lui descriveva, la divisione dei compiti era un fondamento incontrastabile. Durante il lunghissimo (1894-1906) Affaire le crepe originarie erano state appena provocate da uno storico (Gabriel Monod su Temps) e un chimico (Pierre-Émile Duclaux sul Siècle), primi a intervenire pubblicamente in un dibattito morale.
Ma, ancora pochi mesi prima dell’arresto di Dreyfus (3 marzo 1894), quando Le Figaro gli aveva chiesto come mai non firmasse la petizione a favore dell’anarchico Jean Grave – accusato di un reato d’opinione – Zola aveva risposto seccato: «Non è uno scrittore, uno di noi, è un politico, un militante. Che i politici se la sbrighino da sé. Io non faccio politica!». Ora la stava facendo.
L’Aurore difendeva una visione formalmente legalistica del caso Dreyfus. La sua innocenza doveva essere dimostrata in un nuovo processo, non su un giornale. Ma di fronte a quel testo il Tigre si inchinò: «Dio mio, è esagerato ma così potente!». La congiunzione avversativa significava un sì. «Questa lettera cambierà la storia della Francia».
Il titolo
Zola, dunque, affidò a Clemenceau i 40 fogli di quel testo fitto e furioso. Su queste pagine, chiamando in causa il presidente della repubblica Faure, Zola descriveva i fatti, passava all’affondo contro Esterházy e il collegio militare giudicante, elogiava Scheurer-Kestner e Picquart e infine, consapevole del rischio che andava a correre, batteva il suo puntuale attacco su dieci chiodi: «Accuso» il colonnello du Paty de Clam, il generale Mercier, il generale Billot, il generale de Pellieux, il comandante Ravary, i tre periti grafologi, signori Belhomme, Varinard e Couard, il ministero della Guerra e il primo consiglio di guerra.
Quel titolo – Lettera al signor Félix Faure, presidente della Repubblica – non aveva, però, nulla di giornalistico. Riprendeva i precedenti Lettera alla Francia e Lettera ai giovani. Era inadeguato, lungo, didascalico. Clemenceau capì immediatamente che non poteva funzionare. Era da folli, poi, pubblicare un titolo così su un giornale del mattino. Andava cambiato. Insieme a Vaughan iniziò a ragionare. Pensarono a una grande campagna cartellonistica per attirare l’attenzione del pubblico. L’informazione viveva nelle strade ed era sul marciapiede che la gente andava a prendersela. Il titolo doveva vedersi sulle locandine, anche a distanza, e poter essere urlato per le strade. Gli articoli del mattino fungevano anche da replica per quelli della sera.
Questi ultimi solitamente appartenevano a quella stampa a buon mercato, principalmente antidreyfusarda, che aveva l’abitudine di titolare la prima pagina con caratteri molto grandi. Era una forma di marchio, al contrario della grande stampa d’opinione che titolava in piccolo sulla sola colonna. Vaughan quindi iniziò la ricerca di un titolo che si potesse gridare. Insieme alla redazione ne appuntarono alcuni su un foglio. Ma Clemenceau improvvisamente prese una grossa matita e li cancellò. «Non lo vedete? È Zola stesso che ce lo dice». Poi, riprendendo l’affermazione perentoria da quella stessa lettera, aggiunse: «Ce ne può essere uno solo». E scrisse con grafia sicura:
J’Accuse…!
Con quel titolo, carico come nuvole prima di una tempesta, il pezzo sarebbe entrato nella storia.
Pietro Trellini è l’autore di L'Affaire. Tutti gli uomini del caso Dreyfus (Bompiani 2022, pp. 1376, euro 30)
© Riproduzione riservata


