-
Il testo si presenta come un romanzo di formazione, una quarantenne che è rimasta adolescente per vent’anni e ora raggiunge l’equilibrio grazie alla figlia che ha avuto con un intervento (capriccioso ma fatale) di procreazione assistita.
-
Una figlia senza padre, perché lei di Padre ne ha avuto troppo. Il grembo paterno è un libro non esente da difetti, ma il passo è stato fatto.
-
Dopo aver costeggiato una verità ovvia (i nonni danno ai nipoti ciò che non han saputo dare ai figli), il libro si chiude con un lieto fine a metà: la speranza di poter crescere senza mai diventare adulta, pregando la figlia di insegnarle come si fa a nutrire invece che ad aver fame.
La letteratura presa sul serio può alleviare il nostro passato
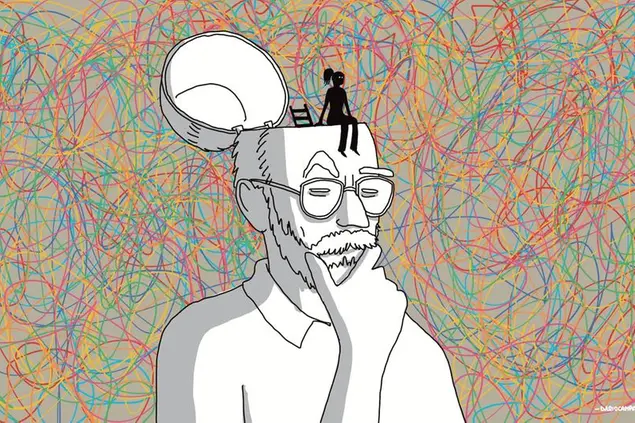
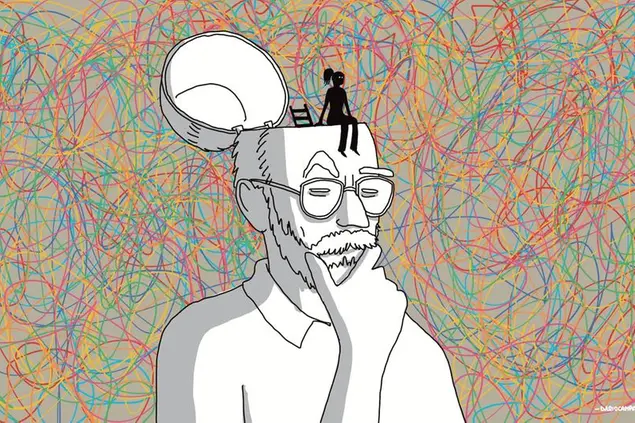
03 dicembre 2021 • 12:00

