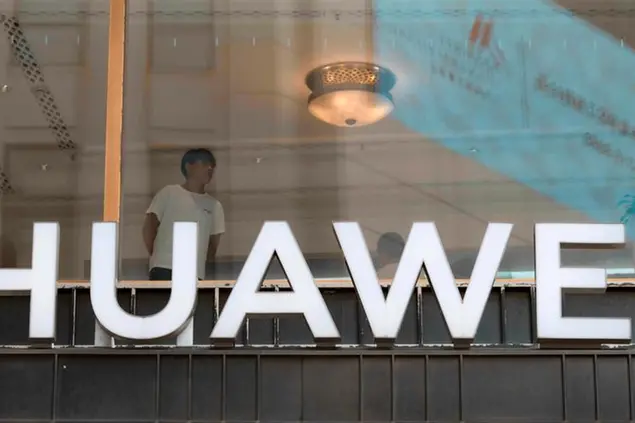L’86 per cento dei microchip dei nuovi smartphone Huawei è prodotto direttamente in patria. I divieti dell’amministrazione Biden non hanno rallentato l’autosufficienza tecnologica di Pechino
Pechino sta compiendo passi da gigante nella manifattura dei microchip, tanto che rispetto alla compagnia leader del settore, la taiwanese Tsmc, la principale concorrente cinese ha un ritardo di soli tre anni. A rivelarlo è uno studio di TechanaLye, un’azienda di Tokyo che ogni anno smonta un centinaio di gadget hi-tech, analizzando la qualità e le prestazioni dei singoli componenti. I progressi dei microprocessori made in China sono risultati evidenti da una comparazione tra lo smartphone Huawei “Pura 70 Pro”, in vendita dall’aprile scorso, e i modelli top di gamma della stessa multinazionale di Shenzhen usciti nel 2021.
Nel primo è montato un processore Kirin 9010, progettato dalla controllata di Huawei HiSilicon e prodotto dal colosso nazionale Semiconductor Manufacturing International Corp. (Smic). Il “vecchio” chip Kirin 9000 alloggiato nei cellulari del 2021 invece era stato anch’esso disegnato da HiSilicon, ma era uscito dalle linee della Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (Tsmc).
La shanghaiese Smic - soggetta all’embargo hi-tech decretato dagli Stati Uniti contro la Cina - è in grado di fabbricare al massimo microchip con tecnologia a 7 nanometri, mentre Tsmc, forniva già tre anni fa ai cellulari Huawei quella, più avanzata, a 5 nanometri. Ciononostante - conclude l’analisi di TechanaLye riassunta dal quotidiano giapponese Nikkei - i due microchip hanno dimensioni (118,4 e 107,8 millimetri quadrati rispettivamente) e prestazioni simili.
Innovazione autoctona
L’ultimo gadget di Huawei è più che mai il frutto di quella “innovazione autoctona” (zìzhŭ chuàngxīn) che rappresenta uno dei cavalli di battaglia di Xi Jinping. Infatti “Pura 70 Pro” è dotato di un totale di 37 semiconduttori che servono a memoria, sensori, fotocamere, alimentazione e funzioni di visualizzazione. Di questi, 14 sono fabbricati da HiSilicon, 18 da altri produttori cinesi e solo cinque da produttori stranieri: l’86 per cento dei chip del telefono è “made in China”. In sostanza i divieti varati dall’amministrazione Biden - dai quali la multinazionale fondata da Ren Zhengfei è stata tra le aziende più duramente colpite - non hanno rallentato la corsa verso l’autosufficienza tecnologica promossa dalle politiche di Pechino. Ciononostante l’amministrazione Biden continua su questa strada.
Le ultime restrizioni all’export nei confronti della Cina sono state varate dal dipartimento del commercio giovedì scorso e riguardano la manifattura dei semiconduttori avanzati e i computer quantistici, ovvero i super-computer in grado di risolvere i calcoli più complessi. In sostanza Washington ha allargato i divieti della cosiddetta “control list”, inserendovi 18 categorie di prodotti e aggiornando i 9 “Export Control Classification Numbers” (Eccn) finiti precedentemente sotto embargo, che si riferivano a componenti molto particolari.
A Washington sottolineano che, affinché tali misure siano efficaci, è indispensabile il coordinamento con i paesi “like-minded”, cioè con le democrazie liberali che sulla Cina nutrono preoccupazioni simili a quelle degli Stati Uniti. Eppure le perplessità nei confronti del containment tecnologico Usa crescono proprio in questi paesi. Christophe Fouquet, l’amministratore delegato di Asml - il colosso olandese leader delle apparecchiature per fabbricare microchip - mercoledì scorso ha dichiarato che la campagna guidata dagli Stati Uniti per limitare, in nome della «sicurezza nazionale», le esportazioni della sua azienda ai clienti in Cina sta diventando sempre più «motivata economicamente».
Secondo Fouquet, la resistenza contro tali misure aumenterà, perché «sostenere che si tratta di una questione di sicurezza nazionale sta diventando sempre più difficile». Anche il governo dell’Aia ha fatto sapere che difenderà gli interessi economici della compagnia, sulla quale Washington negli ultimi mesi ha esercitato pressioni affinché interrompa la manutenzione di alcune delle apparecchiature vendute ai clienti cinesi prima del 2024, ricadute nel frattempo all’interno delle nuove restrizioni. Misure che tolgono profitti a corporation grandi e strategiche ma che non riescono a frenare la rincorsa hi-tech di Pechino.
Incetta di macchinari
Il fatto è che i semiconduttori soggetti all’embargo Usa sono soltanto quelli all’avanguardia, utilizzati per l’intelligenza artificiale e le più avanzate applicazioni militari. Per tutto il resto, dal momento che la Cina è di gran lunga il primo mercato globale dei microchip, è di fatto impossibile frenarne lo sviluppo della manifattura e l’export. Lo stesso Foreign Affairs (autorevole rivista Usa di relazioni internazionali), con un articolo intitolato The Limits of the China Chip Ban, ha recentemente rilevato che «i controlli di Washington alle esportazioni potrebbero finire per aiutare Pechino».
Nel 2023 è stato venduto in Cina il 34,4 per cento dei macchinari per fabbricare microprocessori, circa il doppio rispetto alle concorrenti Corea del Sud e Taiwan. La strategia di Pechino è quella di dominare il mercato globale dei microchip che vengono impiegati nella stragrande maggioranza delle industrie, da quella informatica a quella automobilistica. E, a tal fine, anche in vista di ulteriori, nuove restrizioni che potrebbero arrivare da un’eventuale amministrazione Trump, fa incetta di macchinari.
Nel secondo trimestre di quest’anno la Cina si è confermata il primo mercato globale, in crescita del 62 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, acquistandone per un valore pari a oltre 12 miliardi di dollari. Per capire quanto il mercato cinese sia cruciale per le corporation (statunitensi, europee e asiatiche) del settore bisogna considerare che l’impennata della domanda in Cina ha contribuito ad aumentare del 4 per cento (a 26,8 miliardi di dollari) il fatturato globale dalle apparecchiature per semiconduttori, nonostante la contrazione delle vendite nei principali mercati, come quelli sudcoreano, taiwanese e statunitense.
© Riproduzione riservata