Un report Usa evidenzia un insospettabile vantaggio economico di Pechino in alcuni settori strategici. Sulle centrali nucleari è 15 anni avanti e produce il 62 per cento di veicoli elettrici a livello globale
Sorpresa, l’America va piano. Nell’hi-tech vince la Cina
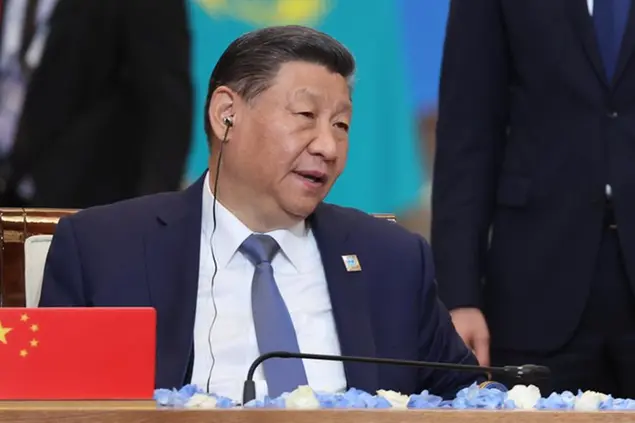
03 ottobre 2024 • 07:00

