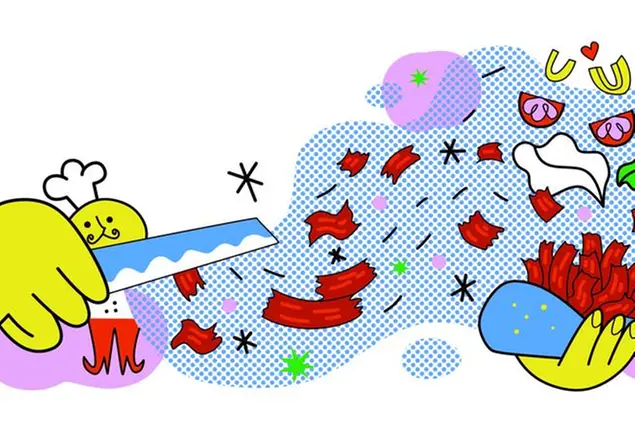Da pezzi di carne infilzati su una spada negli accampamenti militari in Turchia e Iran dell’alto medioevo, il kebab è arrivato fino a noi, ma non è più lo stesso. Dopo la rivoluzione che sposta in verticale lo spiedo (prima spada), il kebab viene portato in giro per il mondo. Lì si ibrida con le culture dei posti in cui approda. Emblematiche le insegne in tutta Italia “Pizza e Kebab” che ci ricordano che spesso è il cibo che traina gli umani verso il cambiamento
In principio lo spiedo era una spada. Nell’alto medioevo, negli accampamenti militari dove oggi ci sono Turchia e Iran, i soldati cacciavano gli animali, li tagliavano e poi infilzavano quanti più pezzi possibile con una spada che mettevano sul fuoco. Gli animali preferiti sembra fossero il montone e la capra. Più tardi verrà il turno dell’agnello, del pollo, del manzo e, quando il kebab si diffonderà globalmente arrivando anche in paesi non islamici, del maiale.
La svolta ottomana
L’idea del ferro con piccoli pezzi di carne infilzati piace, si diffonde e si trasferisce anche in contesti diversi da quello militare. In molte città mediorientali in breve la spada diventa spiedo. Il termine kebab (dal turco “arrostire”) per indicare questo tipo di carne appare per la prima volta in Turchia intorno all’anno 1100, ma lo spiedo è ancora orizzontale.
La svolta arriverà con l’espansione dell’impero ottomano, che regalerà al kebab una novità quantitativa e una qualitativa. Intanto, nel 1514 le truppe imperiali conquistano Erzurum, una città dove questo proto-kebab cotto orizzontalmente è tra i piatti più diffusi.
Gli invasori lo apprezzano molto e lo importano nelle loro città di origine. In breve il piatto si diffonderà in gran parte dell’impero, ampliando appunto la quantità dei suoi consumatori.
Rivoluzione verticale
Qualitativamente, invece, la rivoluzione arriva da un’altra città ottomana, Bursa, dove nel 1867 un ristoratore, Iskender Efendi, ha un’idea per risolvere il problema del grasso del kebab che gocciola sulla brace producendo scintille e un odore sgradevole: mettere lo spiedo in verticale, costruendo con le fette di carne ben pressate una piramide che si allarga verso il basso. Le porzioni vanno poi tagliate in verticale, dal basso verso l’alto. Efendi costruisce anche un grill apposito che ruota automaticamente. L’idea risolve il problema perfettamente: non solo il grasso non gocciola più sulla brace, ma scivolando lungo la piramide va a nutrire e ammorbidire la carne sottostante. Infine, Efendi rende il piatto più raffinato e facile da mangiare togliendo tutte le ossa dalla carne e servendo la pietanza su fette di pane con yogurt e salsa di pomodoro, e portando in tavola il burro, per ammorbidire la carne. È quello che ancora oggi viene chiamato Iskander kebab, proprio in onore del suo inventore.
Anche se l’apporto di Efendi nello sviluppo dello spiedo verticale è fuori discussione, una foto del 1855 fatta in Turchia dal fotografo americano James Robertson rimescola le carte della storia del kebab.
Dodici anni prima di Efendi, la foto (oggi è su diversi account Facebook e Instagram) mostra uno spiedo verticale non in un ristorante, come nel caso di Efendi, ma per strada. Qualcuno ha retrodatato l’invenzione di Efendi al 1830 per confermare il suo primato, ma è chiaro che ci troviamo di fronte a uno di quei labirinti della storia da cui è difficile venire fuori. Spesso, infatti, le novità sono nell’aria ed è difficile stabilire chi sia stato veramente l’inventore di qualcosa.
Mangiare in movimento
Chi passa alla storia è a volte non il primo, ma quello più furbo o più capace nelle pubbliche relazioni.
Comunque siano andate le cose, la verticalizzazione rende il kebab unico e lo avvicina moltissimo a quello che conosciamo oggi.
Da quel momento, il vero segreto di questa pietanza sarà antropologico più che gastronomico: il successo del kebab, infatti, si deve al fatto che chi lo mangia si sposta. Per necessità o intraprendenza, i popoli del kebab vanno a vivere altrove, portando con sé conoscenze gastronomiche che cambieranno i gusti e le abitudini alimentari di molti popoli, dagli americani ai russi agli europei. Come spesso accade, per poter fare breccia in questi nuovi palati bisogna che cambi anche il piatto, la sua preparazione e i suoi ingredienti.
Negli Stati Uniti, per esempio, nel secondo dopoguerra il kebab non si farà più con la carne di montone, che sparisce da quasi tutti i menu per una trentina di anni. Gli americani l’avevano mangiata forzatamente quando erano al fronte e non vogliono più vederla una volta tornati a casa dalle loro famiglie. Nato nei campi di guerra e diffusosi per aver stregato eserciti invasori, questo snack da migranti deve quindi anche la sua variante americana alla vita militare.
Il döner
In Europa, il kebab arriva prima a Londra negli anni Sessanta e poi nella Germania ovest degli anni Settanta, meta di una massiva immigrazione turca. A Berlino, dal decennio successivo, il kebab esplode come fenomeno gastronomico. Ancora oggi la capitale tedesca è il luogo dove si mangia il miglior kebab della Germania e probabilmente d’Europa.
Proprio a Berlino ovest, il 2 marzo del 1971 un immigrato turco, Mahmut Aygün, aprì una kebaberia dove servì quello che lui chiamò döner kebab (la parola döner richiama il verbo “ruotare” in turco). In quello stesso periodo un altro immigrato turco in Germania, Kadir Nurman, fece lo stesso vicino la stazione dei treni del giardino zoologico della città. Anche qui, chi sia stato il primo ad inventare il döner kebab resta un mistero, perché i supporter di uno e dell’altro schieramento contestano le date di apertura dei due locali. Le associazioni ufficiali sostengono Nurman: primato reale o abilità nelle relazioni pubbliche?
Per conquistare anche i tedeschi non di origine turca, in Germania il kebab cambia: diventa di pollo, tacchino, vitello e altre carni tenere.
In Italia
Dagli anni Ottanta altri paesi tra cui l’Italia aprono le porte al nuovo cibo. I dati oggi sono di tutto rispetto: in Europa un giro d’affari di cinque miliardi di euro che dà lavoro a più di 200mila persone e utilizza 400 tonnellate di carne al giorno. Non manca qualche problema. In Italia, ma non solo, la bottega del kebabbaro diventa un simbolo della supposta “invasione” mediorientale. Diversi sindaci, anche di sinistra, negli anni hanno ordinato la chiusura di questi e altri negozi di street food nei centri storici delle città, come se infangassero l’integrità della tradizione italiana e non costituissero, invece, un normale sviluppo della cultura del cibo. I dietologi invece esprimono dubbi sull’equilibrio nutrizionale, trovando nel kebab troppi grassi e quelle 1.000 calorie a porzione che sono davvero troppe, soprattutto se si considera questo piatto uno spuntino tra un pasto e l’altro. Che piaccia o no, oggi in Italia il kebab è parte acquisita dello scenario gastronomico e urbano. Il prodotto che si vende nelle nostre strade è stato aggiornato ai gusti soprattutto dei più giovani, che lo amano molto: come pausa pranzo del liceo, ma anche come spuntino di mezzanotte, dopo una serata.
È fatto con carni varie che vengono condite, i puristi del cibo passino al prossimo paragrafo, con ketchup, maionese o patatine fritte.
Autentiche ibridazioni
Ricerche sociali ci dicono anche che il kebabbaro costituisce a volte un luogo di autenticità: per alcuni consumatori è infatti uno dei pochi posti dove si può ancora trovare cibo “vero”, contrapposto a quello “finto” dell’industria o del fast food.
In Italia, comunque, l’immagine più significativa è nelle migliaia di insegne “Pizza e Kebab”. L’accoppiata è nata dall’esigenza pratica di avere un forno per cuocere il pane per accompagnare la carne. Ma la piramide rotante e la margherita, una accanto all’altra, sono molto più di un’offerta gastronomica. Il più italiano dei cibi e l’ospite che ha camminato tanto prima di venire a trovarci ci ricordano che il cibo si mescola e va avanti, e che a volte è lui a trainare gli umani verso il cambiamento.
© Riproduzione riservata