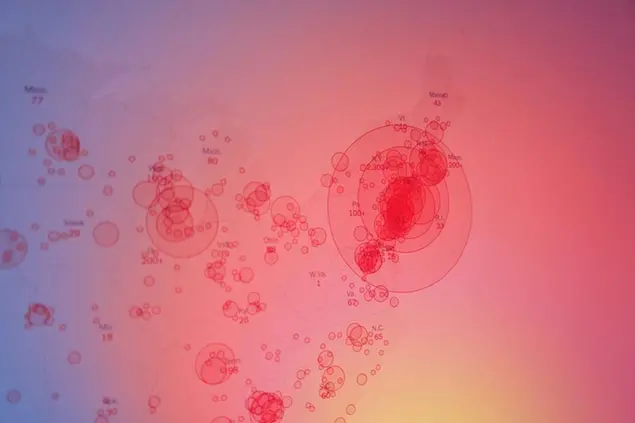- Una delle prime, fondamentali regole della comunicazione dell’emergenza: riconoscere l’incertezza di una situazione nuova e in evoluzione.
- Ma i nostri esperti non ci credono. Abbagliati dal paternalismo favorito da età e genere prevalenti nella classe dirigente italiana, sono convinti che ai cittadini si debbano dare certezze.
- Pensano di doverci dare come sicure solo le informazioni più confortanti, sorvolando su quelle sicure, ma sgradevoli.
Dopo i primi due anni e mezzo di pandemia, possiamo dire che per politici, medici e scienziati (pur con qualche meritevole eccezione) le parole più difficili da dire non sono “scusa” o “non ti amo più”, ma le semplici: “non lo so”.
Eppure è una delle prime, fondamentali regole della comunicazione dell’emergenza: riconoscere l’incertezza di una situazione nuova e in evoluzione, spiegarla al pubblico, sottolineare volta per volta gli elementi di conoscenza già consolidati, le domande rimaste aperte, quali ricerche sono in corso o azioni si stanno mettendo in atto per trovare le risposte necessarie.
Ma i nostri esperti non ci credono. Abbagliati dal paternalismo favorito da età e genere prevalenti nella classe dirigente italiana, sono convinti che ai cittadini si debbano dare certezze. Anzi, di più.
Non solo ritengono il pubblico incapace di prendere decisioni puntando su una valutazione tra le probabilità di rischi e benefici, come se ciascuno di noi non dovesse confrontarsi ogni giorno con l’evoluzione di un sentimento o di un tasso di interesse.
Pensano di doverci dare come sicure solo le informazioni più confortanti, sorvolando su quelle sicure, ma sgradevoli, come la consapevolezza che la convivenza con il virus non significa ignorarne l’esistenza.
«Oggi gli italiani hanno bisogno di messaggi positivi e rassicuranti», ha dichiarato di recente il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.
Il che è senza dubbio vero, ma il risultato cambia molto se le parole di conforto sono giustificate da fatti incoraggianti o solo dalla volontà di raccogliere consenso.
Per mesi si è propagandata la vaccinazione come strumento necessario e sufficiente a “tornare alla vita di prima”.
Dopo la terza dose, ci si poteva considerare protetti. Per 5-10 anni, prometteva a novembre 2021 l’immunologo del Comitato tecnico scientifico Sergio Abrignani, non si sa in base a che cosa.
Passato questo messaggio, ora molti si ribellano all’idea di una nuova iniezione. Quanto durerà? Quanto proteggerà? Perché non aspettare? Perché oggi la probabilità di contagiarsi è altissima (dato certo).
Perché la quarta dose può risvegliare il sistema immunitario anche contro questa variante, almeno per un paio di mesi (dato molto probabile).
Perché non sappiamo quando arriveranno vaccini più mirati, né sappiamo oggi quanto saranno più efficaci nei confronti delle nuove varianti (dato ancora incerto e non pubblicato).
Si dice spesso che la comunicazione dell’incertezza è una delle sfide più ardue per chi la deve affrontare.
Non credo sia così, se si ha l’umiltà di ammettere e distinguere quel che si sa e quel che non si sa, adattandolo nel tempo.
Perché non è solo il virus a mutare, ma anche noi, le nostre difese immunitarie, le norme imposte o sollevate, i nostri comportamenti e le conquiste della medicina e della scienza.
© Riproduzione riservata