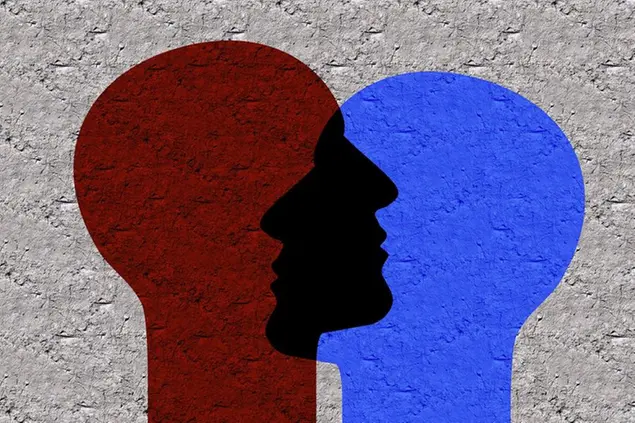- Quando mi ero posto la fatale domanda, «mi interessa di più Leopardi o un culturista nudo?», la risposta era arrivata netta e inequivocabile. Quindi andai avanti, pensando al mio futuro romanzo come a un salto nel vuoto. Per fortuna mi vennero in aiuto Proust e Dante.
- Io, per la mia trilogia, mi sono appoggiato a René Girard e a Hegel (nella lettura che Kojève fa della Fenomenologia dello spirito), cercando di capire come funziona la dialettica tra padrone e schiavo, e come si può demistificare il mito romantico del desiderio.
- Da dove deriva questa mia incapacità di staccarmi da me, oggettivandomi in trame di fantasia lungo il meraviglioso sentiero di Ulisse, di Sindbad il marinaio, di Lancillotto, di Pinocchio, di Alice, di Vautrin?
Quando nel 1982 cominciai a scrivere il mio primo romanzo, Scuola di nudo, Serge Doubrovsky aveva pubblicato Fils da cinque anni ma io non l’avevo letto, né avevo seguito le discussioni che ne erano nate; mi avventuravo in questo sottogenere nuovo (che già qualcuno aveva chiamato autofiction) come il Monsieur Jourdain del Borghese gentiluomo di Molière, che da anni parlava in prosa senza saperlo.
Mi ispiravo piuttosto a un libro di critica uscito nel 1975, Il patto autobiografico di Philippe Lejeune, nel quale si spiegavano tutti i trucchi usati dagli autori di autobiografie per assicurare ai lettori che le cose raccontate erano verità e non finzione. Io però ero diffidente nei confronti della verità, e mi piaceva moltissimo venir meno ai patti; quindi avevo utilizzato i trucchi di Lejeune ma per imbrogliare le carte, per fingere che le cose raccontate fossero verità.
Non pensavo che la mia povera vita valesse la pena di raccontarla se non esagerando e fingendo, e poi avevo paura delle conseguenze – temevo che, se i miei lettori più prossimi (parenti, amici e colleghi) avessero potuto avere le prove che le mie confessioni erano reali, mi avrebbero tolto ogni rispetto, odiato e ostacolato, forse anche cacciato con infamia dall’Università.
Non mi restava che confondere le piste, mi vergognavo delle cose che stavo scrivendo. Ma non potevo farne a meno: quando mi ero posto la fatale domanda, «mi interessa di più Leopardi o un culturista nudo?», la risposta era arrivata netta e inequivocabile. Quindi andai avanti, pensando al mio futuro romanzo come a un salto nel vuoto. Per fortuna mi vennero in aiuto Proust e Dante.
 Dall’autobiografia all’autofiction
Dall’autobiografia all’autofiction
Proust aveva confuso le carte della propria autobiografia, come si vede ora dai foglietti recuperati delle prime stesure: aveva fatto diventare ragazze i ragazzi, trasformato la mamma in nonna, mescolato i luoghi, negato la propria omosessualità ma affibbiandola a tutti gli altri personaggi; in compenso, aveva scoperto le leggi della gelosia e dello snobismo. Dante nella Vita nova trasforma le proprie crisi epilettiche in segni di un destino di profeta, nella Commedia addirittura inserisce i rancori privati nello schema di un percorso universale di salvezza.
Questo dunque era il segreto per non vergognarsi: trovare, sotto i minuti fatti della mia vita e sotto il fragile ombrello delle mie ossessioni sessuali, alcune regole generali portanti, qualcosa che valesse non solo per me. Ora, che le autofiction nascono spesso da emozioni estemporanee postate sui social, credo sia necessario ricordare che per passare dall’autobiografia all’autofiction non basta la brillantezza dello stile.
Le autobiografie possono essere pregevolissime dal punto di vista letterario (come quelle di Rousseau o di sant’Agostino): si basano sull’eccezionalità dell’esperienza e sul coraggio dell’autoanalisi, ma non hanno molto bisogno di una struttura, perché la struttura è data dalla vita stessa e da quel che si è imparato. Le autofiction invece, soprattutto se scritte da antieroi che il loro tempo esistenziale lo hanno sprecato, devono per forza avere una struttura ferrea; devono essere costruite come cattedrali di perfette spinte e controspinte, architettoniche e ingegneristiche.
La trilogia
Io, per la mia trilogia, mi sono appoggiato a René Girard e a Hegel (nella lettura che Kojève fa della Fenomenologia dello spirito), cercando di capire come funziona la dialettica tra padrone e schiavo, e come si può demistificare il mito romantico del desiderio. Durante i lunghi dodici anni di gestazione del romanzo, la svolta principale è avvenuta quando ho intuito che le mie estasi scriteriate nell’inseguire i culturisti avevano la stessa struttura della nuova totalitaria “société de consommation”, e che dunque io appartenevo nel profondo proprio alla società che stavo criticando.
Da questa consapevolezza non potevo più tornare indietro, io ero la mia contemporaneità. Analogamente, la mia rimozione del mondo femminile dipendeva dall’aver perso la competizione coi padri donatori di vita, dal non aver saputo morire nella lotta all’ultimo sangue con loro; avevo chinato la testa e avevo porto il deretano come fanno i leoni sconfitti, da lì nascevano le mie pulsioni sadomasochiste e il desiderio di sottomettere i maschi apparentemente potenti.
La mia vita non poteva essere che quella di un disadattato, di un nemico della vita e dell’umanità, antagonista ribelle e ridicolo. Di fronte a una prospettiva così atroce, l’unica trama romanzesca che mi si offriva (la speranza romanzesca è sempre un metodo, cioè una strada) era quella di pensare la trilogia autofittiva come un ‘romanzo di formazione’ novecentesco che dal rifiuto portasse all’adattamento.
Per prendermi in giro da solo, mi ero abituato a definirlo un body-bildungsroman. All’inferno del primo romanzo succedeva il purgatorio del secondo, Un dolore normale, col primo tentativo di amore di coppia; e il paradiso di Troppi paradisi, appunto, dove il possesso di uno degli angeli sempre fino ad allora soltanto sognati si accompagnava a un progetto di integrazione sociale.
La riduzione del danno
Esaurita quella forma, l’autobiografia empirica è rispuntata, negando l’architettura e il lieto fine romanzesco: ho capito che non potevo inventare liberamente come speravo, non potevo scrivere escludendomi dai miei testi.
La ‘formazione’ non si era compiuta, non ero davvero guarito dalla mia sociopatia; la malafede della mia Bildung dipendeva dal persistere dell’ossessione, dalla cancellazione del femminile e in generale di tutto quello che poteva rappresentare la vita naturale (per esempio, degli animali).
Persisteva una sproporzione tra il desiderio erotico e tutto il resto; la mia macchina desiderante era a trazione intellettualistica, preferivo capire piuttosto che cambiare. Non mi restava che volere quel che la mia condizione mi permetteva, cioè trasformare la vita in destino, o vocazione. Prigioniero della letteratura a dominante biografica, ormai per sempre. Il mondo non si era lasciato divorare, l’amore perfetto e corrisposto non sarebbe arrivato; la perversione era il basso continuo, l’inconscio brontolava laggiù.
L’unica prospettiva era una riduzione del danno. Se quel Walter Siti, il personaggio romanzesco che usurpava il mio nome e cognome, era molto più interessante di me, e per di più era un bugiardo matricolato, bisognava tenerlo a freno, renderlo meno arrogante, ridurgli gli spazi espressivi. I romanzi che ho scritto dopo la trilogia autofittiva non fanno che umiliare volutamente il personaggio Walter Siti: nel Contagio solo qualcuno lo chiama Walter, io come narratore onnisciente lo chiamo solo e sempre “il vecchio” – un ragazzino rumeno, che lo vede aggirarsi come un mendicante nei luoghi dove viveva la persona amata, gli dice alla fine «vai a casa, vai, che la morte ti sta cercando e tu sei in giro».
In Autopsia dell’ossessione Walter è l’antagonista del personaggio principale, che lo odia; cioè è visto con gli occhi del suo nemico. In Resistere non serve a niente Walter non è che lo scrittore ormai noto a cui il protagonista del libro chiede di raccontare la propria storia, e ha pochissime pagine tutte per sé. Il punto estremo di aggressione al narcisismo del personaggio Walter è in Bruciare tutto, il romanzo sul prete pedofilo, dove è presente solo in un minuscolo cammeo (alla Hitchcock) senza che per altro venga fatto il suo nome, mentre le note sono a cura del Siti narratore.
Ma non era questo il punto, lo sapevo; il punto era che dicendo “io” mi autoescludevo dalle pulsioni che “io” non poteva sapere perché appartenevano al territorio del suo inconscio. “Io” mi tagliava fuori dall’Es. Alcune cose che serpeggiavano in profondità (la pedofilia appunto, il sadomasochismo, il matricidio) non avrei mai potuto raccontarle in prima persona perché non ne ho mai fatto esperienza.
Gli stuntmen
Da lì è nata l’idea degli stuntmen, cioè delle controfigure che recitassero per me le scene pericolose; un po’ come Alfonso Nitti in Una vita di Italo Svevo, che si suicida al posto del suo autore. È la tecnica che ho usato per Bruciare tutto, per le scene del locale sadomaso in Autopsia e soprattutto per La natura è innocente, dove Walter ritorna soltanto per accorgersi che le due vite apparentemente così diverse che ha raccontato non sono che due aspetti complementari della propria nevrosi. È, credo, la tecnica che userò anche nel mio ultimo romanzo, I figli sono finiti, in cui il settantacinquenne Augusto che fa amicizia con un ventenne hikikomori sarà l’estrema delle mie controfigure.
Da dove deriva questa mia incapacità di staccarmi da me, oggettivandomi in trame di fantasia lungo il meraviglioso sentiero di Ulisse, di Sindbad il marinaio, di Lancillotto, di Pinocchio, di Alice, di Vautrin? Per due mancanze, direi, soprattutto: la prima è che da bambino mi sono mancate le favole, ero troppo concentrato sulle mie angosce, il governo di cui ero sede non aveva un ministero degli esteri; la seconda è il nessun interesse per la Storia, questo capitale dei padroni.
Io posso raccontare soltanto il presente, o al massimo gli ultimi settant’anni a cui ho assistito. Dunque sono condannato a stare chiuso nella mia bolla, parlando delle donne solo quando sono malate o mutilate, pestando il grano delle mie impotenze e dei miei misticismi un tanto al chilo? Ho ancora fiducia in quella che all’inizio avevo chiamato la mia “mossa cartesiana”, cioè capire l’ignoto a partire dall’unica cosa di cui sono sicuro, la mia inquietudine. Si tratta di raffinare il metodo degli stuntmen, fare in modo che essi rappresentino sempre meno la mia psiche ormai incartapecorita e sempre di più lo spirito dei tempi, fiutando l’architettura dell’oggi.
L’autofiction necessita di una visione da lontano: è il contrario dell’immediatezza dei social. E non deve aver paura di concentrarsi sul privato anche in tempi storici di emergenza, quando ogni sguardo al proprio ombelico può passare per diserzione. I nodi storici di più lungo periodo hanno la loro radice in ciò che ribolle dentro ognuno di noi, e viceversa (Marx e Engels avevano ragione soltanto a metà).
Parlare dei disastri della cronaca può diventare una fuga. Quanto della storia mondiale dipende dalla smania di possedere e dal desiderio di competere, dall’erotomania e dall’invidia? Quanto la pigrizia e il conservatorismo stanno accelerando l’estinzione della nostra specie? L’egotismo e la voracità sono frutti del capitalismo o della natura umana? L’autofiction può essere politica quanto la fantascienza o il romanzo sociale.
Dal 6 all’8 giugno a New York il nuovo festival di narrativa italiana contemporanea Multipli Forti. Tra i protagonisti, Teresa Ciabatti, Claudia Durastanti, Carlo Lucarelli, Valerio Magrelli, Walter Siti e Sandro Veronesi.
© Riproduzione riservata