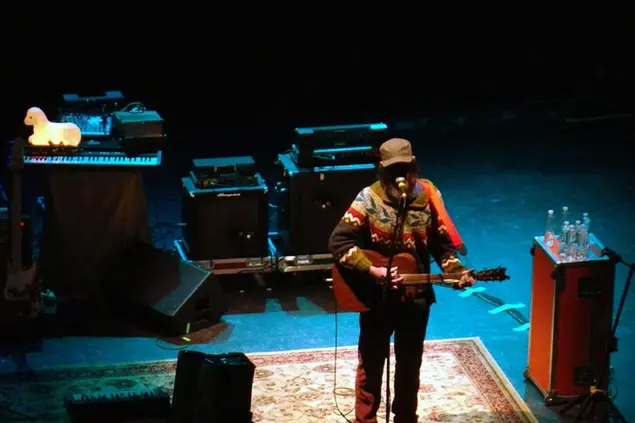- Alla metà degli anni Novanta nel pop-rock non si capiva nulla. Era appena morto Kurt Cobain, Tupac l’avrebbe seguito a breve e con altrettanta violenza
- Dopo i venti di cambiamento dei Sessanta, gli esperimenti e il rumore dei Settanta, gli eccessi e l’estetica degli Ottanta, nei Novanta si cominciò ad avvertire con sconcerto la distanza dalla Storia, quella con la “s” maiuscola, quella che “siamo noi
- I guppi nati in questo periodo si tenevano lontani da quella che chiameremmo realtà. Niente rancore evidente, nessun risentimento politico, né rivendicazioni sociali. Nella land of hope and dreams, loro sceglievano di lavorare col repertorio onirico
Nel 1996, al termine di Murder Ballads, a Nick Cave scappò un sorriso. Quale conclusione migliore, per un album su morti, femminicidi e vendette sparse, se non riunire le sfavillanti collaborazioni del disco per una versione di un piccolo classico nascosto di un Dylan anni Ottanta, Death is not the End? Quando l’aveva composto, Dylan era appena uscito dal millenarismo cristiano che l’aveva afflitto per qualche tempo.
Per chiudere le “ballate assassine”, Cave riprese quella outtake del progetto di Infidels, all’epoca prodotto da Mark Knopfler. Accanto a lui e Blixa Bargeld, i timbri di Shane MacGowan e Kylie Minogue, PJ Harvey e Anita Lane ripetevano ora cavernosi ora soavi, sempre ironici e inquietanti, i versi di Dylan. Cose come: «quando sei a un bivio che non riesci a capire / ricorda che la morte non è la fine». Il crossroads, il bivio, l’incrocio che ha fondato il rock, lì dove Robert Johnson aveva stretto il patto col demonio, veniva plasmato da voci angeliche e diaboliche: quando non capisci, ricordati che la morte non è la fine.
La fine della storia
E alla metà degli anni Novanta, effettivamente, nel pop-rock non si capiva nulla. Era appena morto Kurt Cobain, Tupac l’avrebbe seguito a breve e con altrettanta violenza, ma alcuni numi tutelari cominciavano a morire non di colpo, ma per malattia, come i vecchi. Alcuni generi che avevano cambiato il mondo erano oggetto di revival, a volte causa di semplice noia.
E poi c’era il mondo fuori. Il rock si era sempre percepito come rivoluzione, poi come rivolta, a volte come distruzione necessaria per ricominciare, da una prospettiva “eight miles high”. Ma ora, negli anni Novanta, sui giornali e sui libri si insisteva su una parola d’ordine bizzarra: fine della Storia. Dalla caduta del muro di Berlino, morto e sepolto il socialismo reale, si continuava a proclamare a gran voce che era finito tutto: cominciò Francis Fukuyama, che ancora vive e lotta insieme alla sua idea, e tutti ripresero il verbo gioiosamente e confusamente. Dal 1989, si diceva, c’era un unico mondo, liberale e democratico, un unico modello di produzione e consumo uguale per il globo. Alternative non ce n’erano.
La cosa ebbe delle ripercussioni notevoli non tanto a livello geopolitico (curioso che alcuni dei genocidi più efferati del secolo si siano svolti appena Fukuyama aprì bocca), quanto sul piano dell’immaginario.
Anche nel rock, dopo i venti di cambiamento dei Sessanta, gli esperimenti e il rumore dei Settanta, gli eccessi e l’estetica degli Ottanta, nei Novanta si cominciò ad avvertire con sconcerto la distanza dalla Storia, quella con la “s” maiuscola, quella che “siamo noi”. Di cui si era sancita urbi et orbi la fine. Restare vivi, e pure con uno strumento tra le mani da brandire davanti alle folle, cominciò a suonare strano. Allora in America, al di là delle scorpacciate hip hop sulle due coste, dopo il violento autodafé del grunge, alcuni, in zone più marginali dell’enorme terra musicale usa ai sogni e alle speranze, cominciarono a guardare al passato in una forma deviata, musicalmente efficace, oggi indimenticabile.
Repertorio onirico
Tutto avviene nella cintura meridionale degli Usa, nei pressi del Delta, ma il blues delle origini è solo un vago ricordo. Tra la Georgia dei R.E.M., la Louisiana e il Colorado, gruppi come Olivia Tremor Control, Apples in Stereo e Neutral Milk Hotel, per pochi, intensissimi anni, prendono sul serio la fine, la fanno suonare per un’etichetta bislacca chiamata Elephant 6.
Nascono tutti insieme: a volte non si capisce chi tra i membri faccia parte di un gruppo, chi dell’altro. Vivono insieme, fanno base ad Athens, la città universitaria dove l’underground delle college-radio era diventato mainstream mondiale. Registrano a Denver, in Colorado: il loro studio si chiama Pet Sounds. E sono in effetti Brian Wilson moltiplicato per trenta, impazzito definitivamente, sporcato dagli ultimi residui grunge.
Se tutti riprendevano voci e armonie dei Sixties con un’attitudine ancora punk, se nessuno di loro aveva mai guardato all’obiettivo ultimo dell’ultimo uomo di Nietzsche (guadagna e crepa consumando), tutti questi gruppi si tenevano lontani da quella che chiameremmo realtà. Niente rancore evidente, nessun risentimento politico, né rivendicazioni sociali. Nella land of hope and dreams, loro sceglievano di lavorare col repertorio onirico.
Prima di ogni retromania, di ogni riciclo e ripetizione di un archivio già sterminato ma non ancora digitale, quei progetti musicali partono dai sogni. Gli Olivia Tremor Control dicono ai fan di mandargli i loro, poi li rimodulano nelle code acide di Define a Transparent Dream. Jeff Mangum dei Neutral Milk Hotel si appunta i propri e li fa diventare canzoni popolate di spettri. Gli Apples in Stereo scrivono Submarine Dream, rivivendo trent’anni dopo l’utopia di Ringo Starr. Ma il sottomarino ora è una macchina del tempo dove «il mondo è perso».
Viaggio psichedelico
Come in una riedizione psichedelica di profezie apocalittiche, i ragazzi della generazione X – una croce al posto di un nome – raccontano la nuova rivelazione in una lingua onirica. Ma cosa si annuncia? La fine della storia, naturalmente. Il tempo della fine è spostato lì dove le cose sembra che accadano e fanno pure soffrire, ma è una sfera d’irrealtà: nei sogni.
Non è certo la prima volta che il rock – come ogni espressione sociale – si occupa di sogni, ma stavolta lo fa per mettersi all’indice. Dispersi in accordi gentili e voci tenui (gli Apples), urlati con voce spezzata in storie surreali (i Neutral), distesi nei rumorismi psych degli Olivia, i sogni raccontati da queste band rivelano colpe, assegnano responsabilità, imputano un’inerzia a una generazione senza nome. I sogni servono a dire il senso di colpa. Mettono su piste sonore il senso di colpa di non essere più capaci di storia.
Sarà per questo che a Woodstock nel 1994, una riedizione nel fango del sogno flower-power del 1969, l’elettronica notturna andò molto meglio dei concerti di rock tradizionale. Una musica senza struttura narrativa e senza autori, a volte senza voci, parlava meglio la lingua di un’epoca senza chance di storia.
Anche nella corrente bizzarra della psichedelia di Athens e dintorni, notturna, ancora ritmata da bassi e rumori bianchi, l’apocalisse avviene in sogno. Perché nei sogni come nel mondo ci sei e non ci sei. E nell’intermezzo suoni. Da qui parte il viaggio psichedelico, di un esperimento talmente acido, nel caso dei Neutral Milk Hotel, da essere definito «folk rock suonato dai Motörhead».
Apocalisse cattiva
Ma al fondo di tutta quella melodia, di tutto quel rumore, c’è un rifiuto, ed è totale. Se Death is not the end, come cantavano Nick Cave, i suoi sodali e le sue complici angeliche al termine di un album di ammazzatine atroci, se la morte non è la fine è, semplicemente, perché la fine della storia è un incubo, una cattiva apocalisse, un racconto venuto male.
Il bug di quel sistema musicale di fughe all’indietro e sublimi autoaccuse accadde quando nei sogni di Jeff Mangum, accanto alla sua infanzia, ai traumi dell’anonimato, della precarietà esistenziale di una comunità di sradicati, comparve un personaggio storico eppure già mitologico. Per puro caso, tra le letture del frontman dei Neutral Milk Hotel, entrò una ragazza olandese di cinquant’anni prima, Anne Frank. E la sua storia, il suo privato nello scenario enorme in cui si era dato. Il fantasma di Anne divenne la ragazza per cui provare amore fuori tempo massimo.
E allora la colpa di non poter cambiare più nulla si tradusse in furia scrittoria, in canzoni indimenticabili, in fantasmi ovunque presenti e ancora attivi: nacque In the Aeroplane over the Sea. La colpa svanì tra melodie e suoni mai uditi, e spettri che rivivono in corpi che sudano e desiderano. Davvero la morte non fu più la fine.
Olanda, 1945. Anne Frank e i Neutral Milk Hotel (Nottetempo 2023, pp. 160, euro 15) è un libro di Massimo Palma
© Riproduzione riservata