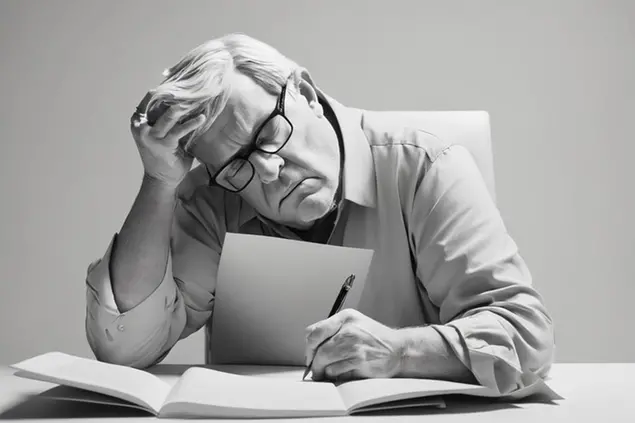L’autore racconta il suo soggiorno in una residenza per scrittori in Catalogna, paragonandolo a una situazione simile a un fumetto horror in cui un demone offre ispirazione creativa in cambio di parte dell'anima degli artisti. Qui esplora la frustrazione del blocco dello scrittore, confrontandolo con l'insonnia e la depressione
Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Il modo migliore che conosco per inquadrare il labirinto di operazioni mentali che a malincuore devo chiamare “il processo creativo” deriva da un fumetto horror che ho letto a dodici anni, in un pomeriggio d’estate. Questa frase ricalca l’inizio di uno splendido testo sul “processo creativo” di David Foster Wallace, che però citava Mao II di Don DeLillo, (Einaudi). Ognuno pesca il biglietto che pesca.
La storia è questa: un investigatore specializzato in fenomeni paranormali viene contattato dai proprietari di un castello infestato. Non ricordo perché. Forse c’erano state delle sparizioni misteriose. Forse qualcuno era impazzito. In ogni caso qualcosa di malvagio aleggiava su quella lussuosa villa circondata da una tenuta boschiva, simile a un sanatorio svizzero per miliardari afflitti da malinconia. E in effetti era stata qualcosa di simile: una clinica per artisti, scrittori e musicisti in crisi, che non riuscivano a sbloccare il loro, appunto, “processo creativo”. Aveva avuto un enorme successo.
Chiunque l’avesse frequentata – artisti di ogni disciplina, affermati, felici – attribuivano al loro soggiorno il merito di una rinascita artistica, di un picco di carriera. Le ragioni per cui comincio così un testo che parla di una residenza per scrittori non devono essere troppo misteriose.
Lo erano invece le ragioni di quelle rinascite artistiche: nel sotterraneo della clinica si annidava un demone. Naturalmente, proponeva agli ospiti un patto. Come ogni demone voleva la loro anima, ma era un demone ragionevole e gliene bastava un pezzetto: voleva un briciolo del loro spirito creativo, delle loro aspirazioni e ambizioni e visioni. In cambio avrebbero ricominciato a scrivere dipingere comporre per sempre, attingendo a un serbatoio immaginativo destinato a non esaurirsi mai. Accettavano tutti. Funzionava.
Non ricordo il resto della storia (probabilmente c’erano cadaveri smembrati e mostri tentacolari, perché c’erano sempre) ma il punto mi sembra evidente, e articolato con una chiarezza maggiore di molti dei diari in cui scrittori e scrittrici, me incluso, hanno tentato di spiegare la vertigine che provano i cosiddetti “scrittori bloccati”. Capita a molti, forse a tutti, prima o poi. Hai sempre scritto con piacere e libertà – hai scelto di farlo proprio per questo, perché è qualcosa che ti dà gioia – e da un giorno all’altro non ci riesci più. Non sai perché. Le idee le hai, ti sembrano tutte valide prima di cominciare. Hai qualcuno di interessato a leggerle – agenti, editori, anche solo amici. Però hai paura. Cominci e ti fermi. Niente ti convince.
Come l’insonnia, come la depressione, il blocco arriva di colpo a interferire con quella che sino ad allora ti era sembrata una capacità naturale; e come l’insonnia, come la depressione, la paura che questo stato di cose vada avanti contribuisce a farlo andare avanti.
E come l’insonnia, come la depressione, la cosa più crudele è questa sua inspiegabilità. Com’è possibile che c’è questa cosa che sai fare, che sai di saper fare, questa pratica che coltivi da anni, decenni; e ci sono le tue idee e aspirazioni che ti rigiri nella mente come gioielli amati di cui esplori in appunti e note vocali ogni sfaccettatura; e non vuoi, non chiedi, non pensi ad altro che al momento in cui finalmente avrai il tempo e la concentrazione e lo spazio e il silenzio per mettere tutto giù e dargli un’esistenza… E poi il momento arriva e non lo fai. Esiti. Perdi tempo. Hai mal di testa. Devi rileggere una cosa. C’è quell’articolo da consegnare. Inizi, vai un po’ avanti, torni indietro. Ricominci. Tiri fuori un paio di paragrafi, una goccia di sangue alla volta; ma non ti convincono. Finché non ti convincono non ha senso andare avanti. Passi giorni lentissimi a levigarli come saponette. Ti convincono sempre meno.
Ecco, la sensazione che hai in quei momenti – che conosco a singhiozzo da più di dieci anni, e che persino quando non c’è, quando riesco a scrivere, mi tormenta col timore di un ritorno altrettanto inatteso e inspiegabile della sua scomparsa, come l’insonnia, come la depressione – la sensazione che hai non è che ti manchi qualcosa. È che tu abbia qualcosa di troppo, e che la tensione coesiva del troppo-pieno impedisca a ciò che tieni dentro di fluire. Forse sono gli standard inarrivabili del perfezionismo; forse le aspettative tue, del tuo agente, di tua mamma; forse un eccessivo affastellamento di immagini che ti interessano, temi che vuoi toccare, personaggi che hai abbozzato, ognuno dei quali valido e interessante ma che non vedi come contenere in un unico disegno complessivo, e finché non capisci il disegno non ha senso cominciare e perder tempo su una falsa pista; quindi non lo fai. Oppure cominci, e perdi tempo su una falsa pista.
Se solo potessi liberarti di qualcosa. Se solo potessi abbassare gli standard, ignorare le aspettative, rinunciare a un’immagine o un tema. Se solo potessi buttar via i vestiti. Se solo potessi cedere un pezzetto della tua anima. Questa introduzione si sta dilungando ma non so bene come rimediare (troppo-pieno? È una falsa pista?). Quello che volevo dire è: ho sempre capito istintivamente il patto demoniaco di cui parlava quel fumetto. Nei momenti di difficoltà – durati quasi otto anni – sentivo in modo confuso che per riuscire a scrivere liberamente, come ai primi tempi, doveva essermi tolto qualcosa.
Per questo nel marzo del 2024 sono arrivato in Catalogna per passare un mese a Sanià, una residenza per scrittori in una specie di castello bianco a picco su una scogliera, nel mezzo di un parco naturale sulla costa catalana. Lì non mi sarebbe stato tolto niente, anzi: mi sono stati dati tempo e concentrazione e spazio e silenzio e letti rifatti quotidianamente e pasti gustosissimi impiattati con la cura di un influencer e viste marine mozzafiato attraverso le chiome dei pini parasole scosse dal vento forte di sud-est. La barzelletta si scrive da sola.
Scrivere è un’arte che richiede molto tempo e frutta pochi soldi, che sono l’unità con cui il capitalismo misura il tempo, che quindi, per chi scrive, risulta doppiamente scarso. Le residenze sono istituzioni nate per alleviare questo problema. In senso molto generale, per un periodo che può essere due settimane o due mesi offrono a chi scrive una stanza e uno spazio di lavoro e una comunità di persone affini, a volte di una sola disciplina, a volte più. Può esserci da mangiare, può esserci un paesaggio struggente, e a Sanià c’erano. È un lusso inconcepibile.
È anche strano. Una residenza è un luogo in cui per un po’ convivono un certo numero di adulti, lontani da ogni rimando alla loro realtà quotidiana, sforzandosi di fingere che quella sia la realtà quotidiana. Non si conoscevano prima, spesso parlano lingue diverse. Li accomuna solo la professione, che è la più solitaria dell’universo nonché una delle più inclini a generare invidie e segreti rancori. Passano le giornate a praticare quella professione, o a non praticarla e disperarsi in silenzio. A volte fanno amicizia, a volte litigano, a volte scopano, ma generalmente sviluppano un rapporto al contempo intimo e distaccato che esiste solo nelle residenze, come commilitoni spediti in una missione rischiosa ma priva di eroismo e il cui senso non vedono appieno. Mangiano insieme, ignorando giovialmente, generosamente, gli evidenti segni di disagio che alcuni di loro prima o poi inevitabilmente manifesteranno. Si scambiano i numeri, si taggano nelle foto. Dopo un po’ ripartono ed è probabile che non si vedano mai più.
È difficile spiegare il senso di una cosa del genere. Perché per chi scrive, o chi fa arte, è particolarmente importante farlo da un posto speciale, accudito da mille cure? Perché non ci sono residenze per sarti, per calzolai, per geometri, per avvocati? Solo per un retaggio secolare, perché nel passato era un’occupazione da miliardari afflitti da malinconia? Come spiego a mia sorella che fa 60 ore di ufficio a settimana, a mia nonna che passava sei giorni su sette in cartoleria, che esistono persone e istituzioni che mettono a disposizione ville e castelli a qualcuno perché seduto al loro interno scriva una storia? Come lo spiego alle persone che in quel castello lavano i pavimenti e riparano i muriccioli a secco che fanno da parapetto sulla scogliera, che servono i carpacci di pesce e le riduzioni di finocchio e zenzero in disposizioni geometriche con formine d’acciaio? Come spiego io stesso di averne bisogno, come giustifico questa mia convenientissima necessità di accedere a una vita principesca perché la mia scrittura gluisca? Borbotto “arte”, borbotto “capitalismo”, oppure non lo spiego. Dico spesso “grazie”, come un bambino beneducato.
E in effetti c’è qualcosa di bambinesco, di poco adulto, nella scelta di passare la vita a scrivere, cioè a pensare alla vita di persone che non esistono. Ogni scrittore sa o sospetta segretamente di essere, in parte o a intermittenza, un bambino (di sicuro lo sono io): capriccioso, volubile, insicuro, piagato di fragilità custodite con cura o sbandierate con fierezza, eccessivamente interessato a ciò che accade nella sua mente, da cui però è spesso distratto senza ragione. Qualcuno se ne vergogna. Qualcuno lo rivendica con orgoglio. Qualcuno lo ritiene un modo di mantenere viva l’immaginazione e la fantasia, che nelle parole di Calvino è «un posto dove ci piove dentro». Lo ammette persino Joan Didion, nonostante il suo perenne aplomb da unica-adulta-nella-stanza: «Because I had been tired too long and quarrelsome too much and too often frightened of migraine and failure and the days getting shorter, I was sent, a recalcitrant thirty one year old child, to Hawaii, where winter does not come and no one fails and the median age is twenty three».
Il senso di una residenza è questo. Per due settimane, per un mese, qualcuno ti cucina, ti fa il letto, si prende cura di ogni tua necessità: sei un bambino viziato e molto solo, con di fronte a te un’estate di pomeriggi infiniti. Nei pomeriggi estivi ti annoi. Vaghi con la mente. Pensi alla vita di persone che non esistono.
Quella in Catalogna non era la mia prima volta. Quattro anni prima mi era capitato di trovarmi in una residenza simile – una tenuta sperduta fra i colli della Toscana, con una torre anch’essa simile a un castello medievale (c’era un demone sotto?) e declivi di uliveti, il posto più bello in cui fossi mai stato prima di stare a Sanià. C’era una porta scolpita da un esponente di spicco dell’arte cinetica. C’era un cenotafio a forma di piramide. C’era una camera con le pareti maiolicate e una ricavata da un vecchio granaio da un architetto famoso, con le pareti in mattoni a sbalzo da cui la luce filtrava screziata e mutevole come in una radura boschiva. Le stanze avevano dei nomi: quello era “lo studio di Bruce”. Io avevo “lo studiolo di Emmanuel”. Erano solo nomi di battesimo.
Ero arrivato in Toscana con grandi aspettative. Non pensavo al demone rintanato sotto il castello. Pensavo a scrivere: da un anno e mezzo non ne avevo avuto tempo. Stavo ristrutturando un casolare con un gruppo di amici per farne una specie di comune, una di quelle utopie spacciate in partenza che spingono le persone a cui la annunci a sorriderti con tenerezza pensando Ma certo. Sarebbe tutto deragliato pochi mesi dopo, ma all’epoca durava ancora: e da diciotto mesi avevo passato ogni giorno in cantiere, dalle sei e mezza alle diciotto, col sole o con la neve – fresando pareti e scalpellando intonaci, sostituendo travi, innestando putrelle dove il sesto di una porta aveva ceduto. Era sfiancante ed elettrico, liberatorio; al contrario della scrittura, in cui non finivo un libro da anni, in cantiere ogni sera osservavo con una gioia esausta il lavoro della giornata, misurabile in metri quadri o cubi o lineari. Certo, non avevo tempo per scrivere. Rimandavo.
E quindi è comprensibile che fossi arrivato in Toscana carico di speranze, convinto che l’anno e mezzo in cui avevo buttato giù molte pareti ma neanche una riga mi avesse in qualche modo rifocillato di energie, che il mio spirito creativo, in mancanza di vie di sfogo, si fosse ricaricato, che il serbatoio fosse di nuovo pieno. Non usavo queste espressioni, naturalmente. Nessuno dice “spirito creativo” credendoci, e io ci credevo.
Rifocillato. Ricaricato. Pieno. Troppo pieno. La barzelletta si scrive da sola.
Nel 2024 arrivavo a Sanià: cinque anni dopo aver iniziato quel libro, quattro dopo averlo iniziato, tre dopo averlo finito, tutto sempre a marzo. I mesi precedenti erano stati impegnati da due traslochi e dagli strascichi della promozione, e avevo rimandato a quell’occasione di quiete l’inizio di un nuovo progetto. Avevo qualche idea ma non sapevo bene cosa avrei fatto.
La casa si trovava su uno sperone di scogliera, un’ora e mezzo a nord di Barcellona, raggiungibile attraverso uno sterrato chiuso da una sbarra perché è in una riserva naturale. Il mare era ovunque, bordato di pini marittimi scossi da un vento incessante, inframezzati di palme e di cespi di macchia mediterranea che cominciavano a fiorire di rosa. C’erano delle scale di pietra intagliate nella roccia che scendevano serpeggiando alle due calette private. C’erano delle panche di legno nascoste in punti panoramici a strapiombo sull’acqua o più su, nei margini in apparenza trascurati di un parco privato tanto grande da essere visibili nelle fotografie scattate dallo spazio. C’era, naturalmente, una piscina.
La mia suite (eravamo in quattro) occupava l’intero secondo piano dell’edificio principale. Avevo una stanza da letto e uno studio. Dallo studio si vedeva il mare attraverso sei finestre ad arco, che sono più di quelle del mio intero appartamento. Un estremo della stanza era occupato da un divano in cui potevano stare comodamente dieci persone, più grande della cucina di casa mia. Il televisore, sulla parete opposta, aveva le dimensioni di un letto singolo. Queste non sono esagerazioni. Ho misurato. Sul divano c’erano ventitré cuscini, tutti dello stesso beige. Il fatto che fosse un numero primo mi turbava. Se n’era perso uno? Qualcuno lo aveva rubato? Chi poteva decidere di mettere esattamente ventitré cuscini su un divano?
Quel mobile mi ossessionava. La sua stessa esistenza sembrava un indovinello crudele. Era troppo profondo per essere comodo. Era tanto largo che in due, sdraiati alle estremità opposte, non riuscivamo a toccarci i piedi. Non capivo come fosse passato dalle porte. Ne ho mandato la fotografia a parecchie persone, nei primi giorni. Il mio ex fidanzato ha risposto: «Può servire solo per un’orgia». Il mio agente ha risposto: «Agli scrittori serve vivere nel lusso». Mia mamma ha risposto di non sporcarlo.
Oltre i vetri premeva il vento dal mare. È stato una presenza costante nel mio mese di residenza, una novità per me abitante della terra. Era fragoroso e violento e non sostava mai. Sibilava di notte attraverso le fessure dei falsitelai. Sbatacchiava le imposte e le zanzariere contro gli stipiti. Ti investiva con una forza inconcepibile appena accennavi a schiudere una finestra, spalancandola, spruzzandoti di salsedine e odore di resina e pioggia, sempre più impetuoso di quanto te lo saresti aspettato vedendo le onde schiantarsi sugli scogli o i pini flettersi, più umido e freddo. A volte pensavo che quel suono incessante mi avrebbe fatto impazzire ma più spesso sentivo che mi infondeva un’energia nervosa, uno stato di trepidazione e allerta come un poderoso rullo di tamburo. Il primo giorno ho fatto una lunga passeggiata sulla scogliera, screpolandomi la pelle per lo schiaffo del vento saturo di salsedine; per la prima volta ho dormito bene, e la mattina dopo mi sono svegliato deciso a sfruttare quell’occasione, pieno di energie, carico di aspettative.
Pieno, carico. La barzelletta si scrive da sola.
A Festivaletteratura Mantova 2024 Vincenzo Latronico incontrerà Emmanuel Carrère, mercoledì 4 settembre, e condurrà una serie di incontri dal titolo La parte dei critici come mai la critica letteraria ha smesso di criticare?. Parlerà di Umberto Eco con Tim Parks; di Sally Rooney e Lilian Fishman con Sara Marzullo, autrice di Sad girl, la ragazza come teoria (66thand2nd); di Elena Ferrante e Michela Murgia con Anna Vollmer, giornalista delle pagine culturali del Frankfurter Allgemeine Zeitung; di Emmanuel Carrère e Annie Ernaux con Fabrizio Maria Spinelli, poeta e critico letterario.
© Riproduzione riservata