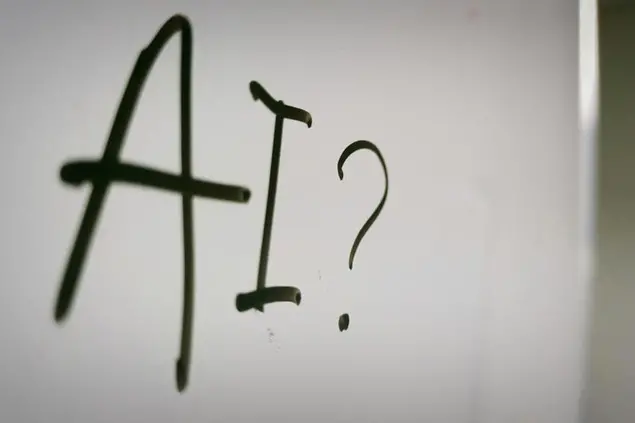I dati allarmanti per il futuro dei lavoratori non trovano sempre riscontro in ciò che sta avvenendo oggi: forse stiamo interpretando la questione nel modo sbagliato
Quanti posti di lavoro perderemo a causa dell’intelligenza artificiale? Secondo un report molto citato, pubblicato da Goldman Sachs nel 2023, questa cifra potrebbe raggiungere nei prossimi anni quota 300 milioni. Ovviamente, non tutti i lavori sono ugualmente esposti alle nuove tecnologie generative in stile ChatGpt: sempre secondo il report, i sistemi basati su intelligenza artificiale potrebbero automatizzare il 46 per cento delle mansioni amministrative e il 37 per cento di quelle ingegneristiche, ma – per via delle capacità manuali necessarie – soltanto il 6 per cento delle mansioni nel campo delle costruzioni e il 4 per cento in quello delle riparazioni.
Di conseguenza, i lavoratori delle nazioni economicamente più avanzate, e la cui economia è maggiormente basata sui servizi, sarebbero quelli più a rischio. In Regno Unito, Giappone, Hong Kong e negli Stati Uniti, per esempio, la quota di posti di lavoro che rischiano di essere spazzati via dall’intelligenza artificiale è pari, sempre secondo Goldman Sachs, al 28 per cento.
Ce n’è abbastanza per suscitare ondate di panico a livello globale, ma quanto dobbiamo dare credito a questo genere di report? In realtà, ci sono ragioni per pensare che – ancora una volta – questo tipo di allarmismo sia parzialmente infondato. E che, semmai, la perdita potenziale di lavori sarebbe causata dalla volontà delle aziende di tagliare i costi anche a scapito della qualità del risultato.
Previsioni fallaci
Andiamo con ordine. Parecchi precedenti storici fanno pensare che l’essere umano non sia particolarmente bravo a prevedere l’impatto delle nuove tecnologie sul mondo del lavoro. Non c’è bisogno di risalire fino ai tempi dell’introduzione del motore a vapore e dell’elettricità: basta infatti fare riferimento a un notissimo studio di Oxford pubblicato nel 2013, in cui si sosteneva che, nel giro di due decenni, il 47 per cento dei lavori sarebbe scomparso a causa delle nuove tecnologie.
All’epoca, il nemico dei lavoratori non erano tanto i chatbot, ma i robot basati su intelligenza artificiale. Che avrebbero gradualmente fatto sparire professioni come il taxista, il camionista, il cuoco di fast food, il cameriere, l’imbianchino, ecc. Tutte professioni manuali a basso tasso di specializzazione e quindi facilmente rimpiazzabili grazie all’avanzata di robot sempre più sofisticati.
Giunti a metà dei due decenni previsti dallo studio di Oxford, possiamo dire che l’avanzata dei robot intelligenti si è fermata incredibilmente presto: le auto autonome che avrebbero dovuto sostituire taxisti e camionisti funzionano ancora oggi – nonostante le continue promesse – solo in pochissimi ambienti attentamente circoscritti, i camerieri robot vengono usati esclusivamente come curiosità e nessuno affiderebbe mai l’imbiancatura della propria casa a un robot.
I robot stanno addirittura perdendo punti nel loro luogo d’elezione: le catene di montaggio. Negli ultimi anni, Toyota (il primo produttore di auto al mondo) ha ridotto il numero di robot impiegati, sostituendoli con esseri umani al fine di “migliorare la flessibilità delle sue fabbriche di fronte ai cambiamenti”.
Anche in tempi recenti, insomma, la possibilità di rimpiazzare gli esseri umani con dei sistemi automatizzati è stata ampiamente sopravvalutata, al punto che uno studio dell’Ocse del 2016 aveva rielaborato di dati di Oxford e ridotto la quota di lavori sostituibile dai robot dal 47 al 10 per cento (e anche questa cifra, finora, sembra essere sovrastimata).
E se la storia si stesse ripetendo anche oggi? Se stessimo sopravvalutando, nell’èra delle intelligenze artificiali generative, l’impatto sul lavoro di sistemi in grado di produrre automaticamente testi, immagini, musica e anche video, come già ne abbiamo sopravvalutato le abilità e l’impatto economico? Che il modo in cui stiamo interpretando il rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro abbia alcuni aspetti problematici si intuisce anche da come la questione viene spesso inquadrata.
Un processo dal basso
Solitamente si parla infatti della possibile perdita di posti di lavoro in seguito all’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle aziende, come se questa tecnologia fosse qualcosa che si acquista in blocco e che può immediatamente sostituire i lavoratori del terziario avanzato. L’integrazione, in realtà, avviene in maniera molto più graduale: non è che si “acquista l’intelligenza artificiale”, ma semmai si iniziano gradualmente a utilizzare sempre più software che sfruttano anche il deep learning e che vengono comunque utilizzati, gestiti e supervisionati da esseri umani.
In più, una larga parte di questa iniezione di deep learning sta avvenendo dal basso, dai lavoratori, spesso senza che i quadri aziendali ne siano nemmeno a conoscenza. All’interno del Microsoft Work Trend Index del 2024 è stato coniato un acronimo proprio per dare un nome a questo fenomeno: Byoai, bring your own Ai (“porta la tua Ia”). È ciò che avviene quando sono gli stessi impiegati a sfruttare di loro iniziativa ChatGpt, Midjourney o Copilot per portare a termine alcune mansioni.
Secondo lo studio di Microsoft, già oggi il 75 per cento di tutti i “lavoratori della conoscenza” utilizza in qualche misura un sistema di intelligenza artificiale, magari solo per ottenere alternative a uno slogan non convincente, per tradurre una frase o per generare l’immagine da usare in un depliant. Tutte operazioni quindi complementari al proprio lavoro, non sostitutive. Ancora più interessante è un altro dato: oltre la metà degli intervistati afferma di non voler ammettere con i propri capi di utilizzare ChatGpt o simili, per paura che ciò li faccia sembrare più rimpiazzabili.
I rischi reali
Questi ultimi dati suggeriscono due cose: prima di tutto, l’intelligenza artificiale non può rimpiazzare un’intera professione, ma (con qualche rara eccezione) si limita ad assistere il lavoratore, aumentandone la produttività a parità di risultati ottenuti. È però proprio questo elemento a presentare i rischi maggiori per gli impiegati: se un singolo professionista, assistito da ChatGpt, è in grado di velocizzare l’esecuzione del proprio lavoro, ciò pone l’azienda di fronte a un dilemma: aumentare la quantità di compiti eseguiti da un singolo lavoratore nella stessa unità di tempo (quindi tagliando i costi e il personale) o aumentare la qualità del lavoro, fornendo ogni impiegato di un assistente artificiale che gli consente di focalizzarsi sugli aspetti più importanti (smettendo per esempio di trascorrere ore a compilare slide)?
La possibilità che le aziende optino per la prima soluzione, al fine di ottenere risultati finanziari di breve termine, è ovviamente concreta e presenta quindi rischi occupazionali. La stima effettuata ancora una volta da Goldman Sachs – secondo cui grazie all’intelligenza artificiale generativa la produttività aumenterà dell’1,5 per cento nei prossimi dieci anni – fa però pensare che l’impatto di questi sistemi, per quanto non trascurabile, potrebbe essere ridotto.
Anche il secondo scenario, quello in cui i lavoratori mantengono il loro posto e vengono assistiti, e non sostituiti, dall’intelligenza artificiale presenta però dei rischi. Se tutti i professionisti possono impiegare un assistente automatico per svolgere le mansioni più elementari, che fine faranno gli assistenti umani e le posizioni junior? Se la gavetta viene in parte eseguita da ChatGpt, come faranno i nuovi arrivati a svolgerla? Un mondo del lavoro in cui si riducono in proporzione le posizioni junior è un mondo del lavoro in cui sarà ancor più avvantaggiato chi possiede una formazione scolastica di altissimo livello e quindi dai costi elevatissimi, alzando la soglia d’accesso per chi non possiede il necessario capitale socio-economico di partenza.
I rischi occupazionali legati all’intelligenza artificiale sono sicuramente presenti, anche se le cifre fin qui circolate sono probabilmente eccessive. Ciò su cui dovremmo concentrarci, allora, non è tanto (o non solo) la perdita dei posti di lavoro, ma il modo perverso in cui ChatGpt e i suoi fratelli potrebbero ulteriormente aumentare le disuguaglianze.
© Riproduzione riservata