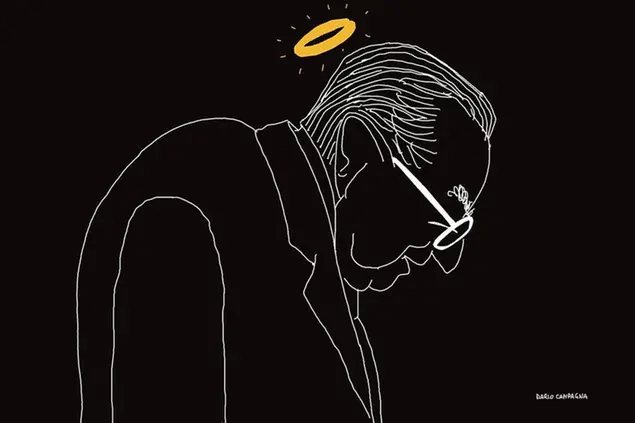La mancanza di trasparenza comportò che Ciancimino riuscì anche ad agevolare, in modo specifico, alcuni costruttori come, ad esempio, i Moncada, titolari di una delle imprese di costruzione più note di Palermo. Nel cantiere di tale impresa, qualche anno dopo, sarebbe avvenuto l'omicidio del noto mafioso Michele Cavatajo in un agguato comunemente noto come "strage di via Lazio" che per le sue modalità, suscitò grande allarme nella collettività
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro–tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza di primo grado che ha assolto l’ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. La sentenza di secondo grado, confermata in Cassazione, ha accertato invece che – fino alla primavera del 1980 – Andreotti aveva avuto rapporti con i boss Cosa Nostra
La mancanza di trasparenza comportò che il Ciancimino riuscì anche ad agevolare, in modo specifico, alcuni costruttori come, ad esempio, i Moncada, titolari di una delle imprese di costruzione più note di Palermo.
Nel cantiere di tale impresa, qualche anno dopo, sarebbe avvenuto l'omicidio del noto mafioso Michele Cavataio in un agguato comunemente noto come "strage di via Lazio" che per le sue modalità (centralità della zona, ora diurna, numero degli aggressori (5) e natura delle armi utilizzate - mitra e pistole), suscitò grande allarme nella collettività.
Moncada Girolamo stesso sarà poi, come si vedrà, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale della P.S. per tre anni, per le sue frequentazioni con individui mafiosi e per la protezione mafiosa di cui, proprio negli anni '60, godevano i suoi cantieri.
In ordine alle irregolarità commesse dagli organi comunali a suo favore il rapporto Bevivino accertò che l'impresa Moncada aveva, tra gli altri, costruito un edificio sito in via Lazio facente parte di una lottizzazione che non prevedeva corpi bassi e piano attico.
Il Moncada aveva presentato il progetto in data 12.6.1961 (cioè in un periodo di vacanza delle norme di salvaguardia del P.R.G.). Tale progetto era stato esaminato il 20.6.1961 dalla Commissione Edilizia che aveva espresso parere favorevole con esclusione dei corpi bassi e del piano attico che, appunto, non erano compresi nella lottizzazione.
Appena due mesi dopo tale parere, l'impresa Moncada aveva presentato una variante al progetto originario; variante che prevedeva l'aggiunta di uno stenditoio coperto e di corpi bassi.
Esaminata tale variante, la Commissione Edilizia aveva espresso parere favorevole. L'ispezione accertò anche che l'impresa non solo aveva realizzato il piano attico, ma aveva costruito i corpi bassi ampliandoli rispetto alla stessa variante, e che l'organo a ciò preposto (Ufficio Tecnico), non aveva effettuato alcun controllo.
L'inerzia dell'Ufficio Tecnico non può essere considerata un fatto casuale, infatti acquista un grande rilievo sintomatico del preciso intento di favoritismo che l'ha ispirata, se viene valutata nell'ambito del provvedimento adottato dalla Commissione Edilizia.
Dopo avere, in un primo tempo, escluso dal progetto i corpi bassi, tale organo, infatti, appena due mesi dopo e senza un valido motivo, approvò la variante ad essa relativa.
Ancor più significativo è l'episodio concernente i due fabbricati costruiti dal Moncada in via Nino Bixio in merito ai quali il rapporto Bevivino riferisce testualmente: «Il progetto venne presentato il 14 ottobre 1959. La costruzione, secondo il parere espresso dalla Sezione V dell'Ufficio Tecnico, rientrava in zona di espansione a densità edilizia urbana sino a 2,5 mc/mq, secondo il Piano Regolatore del 1956.
La Sezione III/B, osservato che l'edificio rientrava nella lottizzazione D'Arpa e fratelli, approvata dalla C.E. nella seduta del 1° dicembre 1958, rilevava che il progetto non si uniformava a detto piano di lottizzazione per la maggiore lunghezza prevista negli edifici: tre metri per l'edificio B e due metri per l'edificio C, con conseguente aumento di 1.000 mc di volume.
Non si uniformava inoltre allo stesso piano di lottizzazione per il minore distacco dagli edifici stessi in corrispondenza del collegamento a terrazza (m. 4,70 anziché m. 6). Il progetto prevedeva, inoltre, un piano rientrante che non risultava arretrato in maniera regolamentare. Entrambi i piani attici risultavano arretrati, su tre fronti, di m. 2 anziché di m. 3,40, in corrispondenza del quarto fronte, erano a filo del fabbricato. La C.E., il 9 novembre 1959, espresse parere favorevole all'unica condizione che venisse eliminato il piano attico. Successivamente, in data 23 marzo 1960, il Moncada presentò un progetto di variante.
La Sezione III/B, esaminato il progetto di variante, osservò che la planimetria non corrispondeva alle previsioni del progetto e che era prevista una maggiore altezza di quella indicata nel piano di lottizzazione D'Arpa e fratelli (m. 25,40 anzichè m. 21). La Commissione edilizia, il 31 gennaio 1961, espresse parere favorevole a condizione che il piano attico venisse arretrato su tutti i fronti in misura regolamentare e che fossero rispettati i distacchi e gli arretramenti previsti nel piano di lottizzazione.
Venne ancora presentata altra variante, in data 1° luglio 1961, consistente nella costruzione di un piano attico nei due edifici e di ulteriori ambienti sopra il piano attico (già escluso, come si è detto sopra, dalla Commissione edilizia). La Sezione III/B osservò che la variante non era regolamentare, perché non solo non venivano arretrate le fabbriche, come aveva prescritto la C.E., ma anche perché venivano ulteriormente ridotti gli arretramenti e l'interpiano (ridotto a m. 2,90). La C.E. espresse, per altro, parere favorevole alla variante il 4 luglio 1961, senza porre alcuna condizione. La licenza di costruzione (nr. 1006) venne concessa il 25 luglio 1961».
Tale episodio dimostra allora, specie se collegato al precedente, il persistente atteggiamento di favore mantenuto dagli organi comunali facenti capo all'imputato, nei confronti del Moncada.
Nonostante la competente sezione dell'Ufficio Tecnico avesse sottolineato, più volte, che il progetto e le varianti presentate dall'impresa Moncada non si uniformavano alla lottizzazione e, perfino, agli stessi pareri espressi dalla Commissione, quest'ultima non esitò a formulare, il 4.7.1961, un parere incondizionatamente favorevole, consentendo al Moncada di ottenere indebitamente e, peraltro dopo poco meno di venti giorni, la licenza di costruzione.
Ora le deliberazioni della Commissione, debbono farsi risalire certamente all'operato del Ciancimino. Non solo egli quale Assessore ai LL.PP. era il membro più autorevole di essa, ma, come gli atti dimostrano, ne era addirittura il Presidente (...) dato che il Sindaco, per prassi, non partecipava alle sue sedute.
Giova, inoltre, sottolineare che Moncada Salvatore, fratello di Girolamo e contitolare dell'impresa di costruzioni, come si vedrà, sarebbe entrato a far parte della I.S.E.P., società facente capo al Ciancimino e a noti esponenti mafiosi.
E che l'impresa dei Moncada avesse una forte connotazione mafiosa è rimasto accertato dal fatto che nel settembre 1973 Moncada Girolamo veniva sottoposto, dal Tribunale di Palermo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per tre anni (...).
Quei giudici mettevano in luce che il predetto si era mostrato disponibile ad instaurare rapporti con noti mafiosi come Di Trapani Nicolò (e cioè l'individuo che era "vicino" al Ciancimino fin dagli anni '50) il quale, infatti, nel 1962 era stato tratto in arresto proprio nel cantiere dell'impresa Moncada.
Si legge, ancora, nel detto provvedimento, che il Moncada si giovava certamente di protezioni mafiose come si desumeva dal ritrovamento del suo numero telefonico in possesso di D'Alba Salvatore e Diana Bernardo, individui di certa estrazione mafiosa. Il Diana, infatti, sarà indicato da Tommaso Buscetta come vice e grande amico dello stesso Stefano Bontate (...).
Ed ancora si evidenziavano i rapporti dei Moncada con il Cavataio, noto affiliato a "Cosa Nostra", indicato dal Buscetta come capo della "famiglia" mafiosa dell'Acquasanta, autore di gravissimi delitti quali l'omicidio di Calcedonio Di Pisa (...). Non è senza significato, infatti, che il Cavataio sia stato ucciso proprio nel cantiere dell'impresa Moncada. Essa, dunque, quantomeno per la protezione di cui si avvaleva, sfruttando la potenza intimidatrice derivante dalla notorietà del vincolo associativo del Di Trapani, del Cavataio, del D'Alba e del Diana, era un'impresa mafiosa. (…) Gli elementi più altamente significativi che anche da soli rivestono una univoca valenza probatoria a carico dell'imputato sono costituiti dalla sua partecipazione in imprese
mafiose. (...)
La società I.S.E.P. (Istituto Sovvenzioni e Prestiti) venne costituita il 24 gennaio 1951 (...) da tale Boselli Davide, Boselli Giovanni e Cappadonia Salvatore. Il 3.2.1951 (e, cioè, dopo appena nove giorni dalla sua costituzione) Boselli Giovanni e Cappadonia Salvatore trasferirono le loro quote a Di Bella Susanna, (...) moglie di Sorci Antonino (...) e a Di Carlo Angelo (...).
A questo punto è necessario soffermarsi sulla personalità di tali individui che avendo acquistato le quote societarie appena nove giorni dopo la costituzione della società ne erano i veri titolari. Il 3 aprile 1933 Sorci Antonino veniva sottoposto alla diffida di P.S., il 18.2.1938 veniva assegnato al confino di polizia per quattro anni e il 18.3.1952 la Questura di Roma, indagando su un traffico di stupefacenti, lo aveva notato in compagnia di Lucky Luciano, individuo su cui non è necessario spendere parole per delinearne la personalità mafiosa ormai storicamente acquisita. Ed ancora, il 13.8.1963, Sorci Antonino veniva sottoposto alla diffida, ma il provvedimento non poteva essergli notificato perchè, nel frattempo, si era reso irreperibile (...).
Fin da giovanissimo, dunque, il Sorci gravitò in ambienti mafiosi, riuscendo ad accumulare un enorme patrimonio che gli valse il soprannome di Nino Sorci "'u riccu". Ed infatti, il 14.11.1964, la Polizia Tributaria di Palermo riferiva che egli aveva realizzato lucrose speculazioni nel campo edilizio perchè nel periodo 1950-1961, investendo la somma di 35 milioni di lire, era riuscito a ricavare un utile di 95 milioni di lire e ad assicurarsi una considerevole proprietà immobiliare (...).
Anni dopo sia Tommaso Buscetta che Francesco Marino Mannoia lo indicheranno come il capo della "famiglia" mafiosa di Villagrazia, strettamente legato a Stefano Bontate e passato, dopo l'uccisione di questo, ai "vincenti". Ma tale scelta di campo non servì a salvargli la vita, perchè egli venne ucciso il 12.4.1983, nell'ambito della guerra di mafia, unitamente al figlio Carlo (...).
Non meno criminale la personalità del Di Carlo, nato a Corleone nel 1891. A suo carico, infatti, risulta (...), che dopo essere stato assolto per insufficienza di prove dall'omicidio di tale Bosco nel 1926 venne condannato, con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 18.6.1930 per il delitto di associazione per delinquere. Venne diffidato nel 1964 e tratto in arresto nuovamente per associazione per delinquere (in concorso, tra gli altri, con Luciano Leggio), ma decedette nel 1967.
Sebbene non sia stato indicato dai collaboranti come un "uomo d'onore" non v'è dubbio che, pur in mancanza di una formale affiliazione, il Di Carlo era inserito stabilmente nel sodalizio e soprattutto nella cosca dei corleonesi.
Oltre ad essere cugino del noto capo mafia di Corleone Michele Navarra, egli fu socio di Luciano Leggio nell'attività armentizia di "Piano di Scala" in Corleone e nella gestione dell'Ippodromo della Favorita in Palermo (...), divenendo poi il bersaglio di richieste di denaro dallo stesso Leggio allorchè intraprese, unitamente al Sorci, l'attività di concessione di prestiti con la I.S.E.P. (v. dichiarazioni di Tommaso Buscetta...).
Fin dagli anni 30, dunque, sia Antonino Sorci che Angelo Di Carlo appartenevano al sodalizio mafioso e i loro capitali avevano origine illecita. Ed è con tali individui che il Ciancimino allaccia e mantiene per anni rapporti societari, entrando, per il tramite della moglie, a far parte della società I.S.E.P. Dal libro soci si rileva, infatti, che fin dal 3.7.1963 il capitale sociale risulta sottoscritto, tra gli altri, anche da Scardino Epifania Silvia (moglie del Ciancimino) che era titolare di 11.538 azioni per un valore di lire 11.538.000. Va detto, a questo punto, che il Ciancimino ha negato di conoscere Antonino Sorci e perfino Angelo Di Carlo e ciò nonostante questo fosse nato e vissuto a Corleone, asserendo che la Scardino aveva investito nella I.S.E.P. il denaro (donatole dal padre), su suggerimento dell'Ing. Garofalo, vecchio amico di suo suocero. Tali circostanze, però, non solo non hanno ricevuto alcun riscontro, ma sono state smentite dagli atti.
L'assunto secondo cui la somma di denaro investita dalla Scardino e, cioè, lire 11.500.000 (non ingente, ma pur sempre consistente se si considera il potere di acquisto della lira nel 1963) provenisse dal padre della predetta non solo non è sorretto da alcun elemento di prova, ma risulta fantasioso sol se si considera che il suocero del Ciancimino era un maresciallo in pensione che non svolgeva alcun altra attività e non era titolare di alcun bene immobile (...).
Che poi la Scardino (e, dunque, il Ciancimino) non avesse rapporti con il Sorci o il Di Carlo e il loro referente nell'ambito della I.S.E.P. fosse il Garofalo, è anch'essa una circostanza smentita dagli atti. Ed infatti dal libro dei soci si desume che all'assemblea dell'I.S.E.P. del 16.12.1963 le azioni della Scardino vennero rappresentate da tale Gucciardi Angela che agì quale sua delegata (...). Ora la Gucciardi è la moglie di Perrino Vincenzo (...) nipote di Di Carlo Angelo, in quanto figlio della sorella del Di Carlo, socio dello zio nella I.S.E.P. e in altre attività imprenditoriali.
Tale fatto dimostra allora che la partecipazione del Ciancimino alla I.S.E.P. è da ricondursi alla stretta comunanza di interessi proprio con i soggetti mafiosi di cui la società era espressione.
La natura di impresa mafiosa della I.S.E.P. non emerge, poi, soltanto dalla qualità dei personaggi che erano interessati ad essa, poichè la stessa attività della società era finalizzata al riciclaggio di denaro in quanto mascherava i capitali del Sorci e del Di Carlo e attuava il travaso di denaro illecito in attività apparentemente lecite.
Nel corso di una perquisizione effettuata nell'abitazione di tale Garofalo Francesco (nato a Castellammare del Golfo nel 1891), vennero rinvenuti, infatti:
1) un cartoncino dell'I.S.E.P.;
2) un foglio dattiloscritto riguardante una rimessa di denaro di 5.000.000 di lire alla I.S.E.P.;
3) un ritaglio di busta su cui era trascritto l'indirizzo di New York di Di Carlo Lelio Calogero, fratello di Di Carlo Angelo (...), indicato dalla Polizia come un individuo coinvolto, al pari del Garofalo, nel traffico internazionale degli stupefacenti.
Il Garofalo, sottoposto alla sorveglianza speciale della P.S. per cinque anni con provvedimento del Tribunale di Palermo del 16.11.1968 (...), era poi da tempo noto agli inquirenti come un personaggio di spicco di "Cosa Nostra", affiliato ad una delle cinque grandi "famiglie" che dominarono la malavita di New York, quella cioè capeggiata da Bonanno Giuseppe, anch'egli nato a Castellammare del Golfo.
Il Garofalo, dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti, nel 1957 aveva fatto rientro in Italia stabilendosi a Palermo ove era stato indicato dalla Polizia come uno dei partecipanti alla nota riunione di mafiosi siculo-americani svoltasi presso l'Hotel des Palmes nell'ottobre del 1957 (...). A suo carico era emerso ancora che si era più volte incontrato, sia in Roma che in Palermo, con tale Cerrito Joseph, esponente della "famiglia" di Joseph Proface e di Frank Matranga ed ancora, gli inquirenti avevano accertato che il Garofalo era depositario di considerevoli somme presso una banca svizzera (...).
Proprio tale circostanza induce ad escludere che la somma di 5.000.000 di lire, versata nelle casse dell'I.S.E.P., avesse a che fare con prestiti o sovvenzioni ricevuti dalla I.S.E.P., di cui il Garofalo non aveva certo bisogno e che, per converso, attesa la qualità e lo spessore mafioso del personaggio, avesse, invece, provenienza illecita. Ma la I.S.E.P. era utilizzata dai suoi soci anche come paravento per altre loro attività imprenditoriali.
(…) Dunque, l'I.S.E.P. era una società sorta per riciclare denaro illecito e mascherare la provenienza dei capitali degli stessi soci e, cioè, per attuare quel travaso di capitali illeciti in attività apparentemente lecite che caratterizza, come si è detto nella parte generale, l'impresa di tipo mafioso. Del resto lo stesso imputato non ha potuto negare che la I.S.E.P. "non era un esempio di trasparenza" (v. pag. 9 della memoria nr. 7). Nè tale connotazione mutò con gli anni poichè, anzi, nel 1966 entrò a far parte di essa, tramite la moglie e i figli, anche Moncada Salvatore.
Costui, unitamente al fratello Girolamo, come già si è detto, era titolare dell'impresa di costruzioni nella quale sarebbe avvenuta, pochi anni dopo, la nota strage di via Lazio. Il fatto, poi, che ad essa abbiano partecipato soggetti non collegati a "Cosa Nostra" sottolineato dalla difesa per sostenere la buona fede del Ciancimino, è un elemento irrilevante.
Al contrario che per gli altri soci, infatti, sussistono decisivi elementi che inducono ad escludere tale buona fede e, cioè, innanzi tutto, i precedenti legami dell'imputato con individui di spessore mafioso (come quelli risalenti fin dal 1955 con Di Trapani Nicolò).
In secondo luogo va detto che l'estrazione mafiosa del Sorci e del Di Carlo non poteva essere sconosciuta al Ciancimino. L'ascesa economica del Sorci, come si è visto, si era realizzata proprio nel settore edilizio e negli anni in cui il Ciancimino ricopriva l'incarico di Assessore ai LL.PP. Provenendo poi il Di Carlo da Corleone ed essendo un individuo molto noto in quell'ambiente (in quanto cugino di Michele Navarra, accusato di un grave fatto di sangue quale l'omicidio del Bosco, nonchè socio dello stesso Luciano Leggio), sarebbe contrario alle più elementari regole del buon senso ritenere che il Ciancimino, che proveniva dallo stesso paese, ne sconoscesse la personalità.
A fronte di tali emergenze, che, in modo convergente, ne rivelano la comunanza di interessi con personaggi appartenenti a "Cosa Nostra", la circostanza che l'imputato non abbia tratto alcun guadagno dalla sua partecipazione all'I.S.E.P. è un fatto che, anche se fosse vero, nulla toglierebbe al valore sintomatico della sua condotta.
(…) Altro episodio che rivela che il Ciancimino usava la sua influenza per favorire indebitamente individui appartenenti a "Cosa Nostra" e trarre vantaggio dall'attività dell'organizzazione è quello relativo al mafioso Marsala Giuseppe. Fin dal 1964 costui era stato indicato da Polizia e Carabinieri come il "capomafia" di Vicari e sottoposto nel 1969 alla misura del soggiorno obbligato per quattro anni.
Parecchi anni dopo, le indicazioni degli inquirenti troveranno riscontro nelle dichiarazioni di Marsala Vincenzo, altro collaborante le cui dichiarazioni, puntualmente assistite da numerosi elementi obiettivi, sono state già sottoposte al vaglio della Corte Suprema (v. Cass. Sez. I^, 24.11.1986, Pravatà Michelangelo ed altri).
Il collaborante avrebbe confermato, infatti, che Marsala Giuseppe (Peppe Marsala), rivestiva un ruolo di spicco nell'ambito del sodalizio mafioso in veste di "capo mandamento" e membro della "commissione", organo posto al vertice di "Cosa Nostra", (v. e sent. di primo grado del procedimento contro Abdel Aziz Afifi ed altri ...). Ed è proprio in favore di un individuo di così grosso spessore che il Ciancimino intervenne per consentirgli il conseguimento di illeciti profitti. Nonostante, infatti, il Marsala risiedesse a Vicari e fosse colà proprietario di case e terreni, risultò assegnatario di un appartamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, mercè l'intervento di Vito Ciancimino (...).
Tale circostanza, contestata al Ciancimino dal G.I. dott. C. Terranova, non fu da lui negata; non escluse, infatti, di essere intervenuto a favore del Marsala probabilmente per corrispondere alla richiesta del figlio di questo, dipendente comunale, che per due volte gli era stato assegnato in qualità di autista, nè che il Marsala si fosse adoperato per la riuscita della sua campagna elettorale (...). E proprio in quest'ultima affermazione va individuata la chiave di lettura dei rapporti tra i due individui.
Anni dopo le dichiarazioni rese dal Ciancimino al Giudice Terranova, Marsala Vincenzo avrebbe, infatti, affermato: «Marsala Giuseppe dava a tutti l'indicazione di votare, tra gli altri, anche per Vito Ciancimino» (...). […] Tale vicenda costituisce oltre che un sintomo della personalità dell'imputato anche un altro valido elemento di riscontro delle chiamate di correo esistenti a suo carico perchè dimostra la "disponibilità" del Ciancimino in favore degli associati a "Cosa Nostra". (…) In ordine ai rapporti economici intrattenuti dall'imputato con costruttori il processo ha rivelato soltanto quelli con Zummo Francesco, Maniglia Francesco e Caltagirone Francesco. (…) Ancora più oscuro è l'episodio concernente Caltagirone Francesco.
Dalla perizia è emerso, infatti, che il suddetto in data 14 marzo e 16 maggio 1977 emise due assegni tratti su due c/c intrattenuti presso la succursale del Banco di Santo Spirito per l'importo di venti milioni di lire cadauno, che confluirono nel deposito a risparmio "Portatore" di pertinenza del Ciancimino (pag. 35).
Ora l'imputato ha ricondotto tale versamento ad una sovvenzione a favore dei partiti politici. Ma essa è smentita dagli atti poichè l'unico versamento di una certa consistenza, effettuato dal Ciancimino a favore del suo partito, è quello di 21 milioni di lire (pag. 69) che è avvenuto il 6 dicembre 1978 e, cioè, a distanza di un anno e nove mesi dal versamento del Caltagirone e per una somma di gran lunga inferiore e, dunque, non può trovare spiegazione in esso.
Come si vede allora i rapporti d'affari del Ciancimino con i costruttori sono rimasti oscuri e non trovano affatto la loro causa in un rapporto societario sia pure occulto e fiduciario, come l'imputato ha voluto far credere, poichè gli atti forniscono, semmai, elementi utili per individuare nell'imputato più che un socio occulto un soggetto che, pur non apportando nessun contributo alle varie società, ricavava egualmente ingenti utili dalle attività economiche di essa, come la vicenda del palazzo acquistato da Zummo Francesco ampiamente comprova.
E se i costruttori palermitani hanno subito, per anni, tale condotta prevaricatrice del Ciancimino senza opporre nulla alle sue esose richieste, ne deriva che le medesime non potevano non essere accolte proprio perché il Ciancimino costituiva, al contempo, un canale politico irrinunciabile e un individuo assai temibile per i suoi notori legami mafiosi.
[…] Già si è detto come nella valutazione della prova in tema di delitti associativi di tipo mafioso, uno degli elementi che va preso in considerazione è l'ambiente in cui il soggetto ha agito. (...)
A tal proposito il processo offre molteplici e convergenti elementi per affermare che il Ciancimino si è mosso in un clima di diffusa intimidazione e di generale compiacenza che, non trovando alcuna plausibile giustificazione, è anch'esso un elemento di riscontro alle accuse dei collaboranti, perché indica l'esistenza di una trama sottile ed insidiosa che ha condizionato la condotta degli individui che, in vario modo, sono entrati in contatto con lui.
A tal riguardo vanno sottolineati gli episodi relativi a Galante Salvatore ed Alessi Alberto.
Costoro, entrambi Consiglieri Comunali all'epoca in cui il Ciancimino fu Sindaco di Palermo, riferivano, nella fase istruttoria, di avere votato contro la sua elezione a Sindaco facendo di tale voto contrario dichiarazione pubblica in seno al Consiglio Comunale (v. deposizioni rese al P.M. rispettivamente il 17.11.1984 e 21.1.1984).
A seguito di tali dichiarazioni l'Alessi era stato denunciato ai probiviri del partito; gli era stata tolta la tessera e per due legislature gli era stato impedito di partecipare alle relative competizioni elettorali, essendo stato escluso dalle liste del partito.
Ma, fatto ancor più grave, dopo la audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia (...) aveva ricevuto telefonate anonime di avvertimento. Il Galante aveva riferito poi che qualche tempo dopo il voto contrario manifestato nei confronti dell'imputato, aveva subito l'incendio della sua autovettura.
[…] Non può poi tacersi il fatto che sia l'Insalaco che il Martellucci, che avevano con la loro azione politica mostrato di voler ostacolare la realizzazione degli interessi di cui il Ciancimino era espressione (soprattutto nella vicenda del rinnovo degli appalti della I.C.E.M. e della L.E.S.C.A.), subirono entrambi, gravi "avvertimenti" consistenti nell'incendio dell'autovettura dell'Insalaco (16.10.1984) e nell'attentato dinamitardo che distrusse la casa di villeggiatura del Martellucci (16.12.1980).
In un primo tempo gli inquirenti avevano indiziato l'imputato del concorso in tali reati.
Successivamente, però, hanno disposto nei suoi confronti l'archiviazione degli atti per mancanza di ulteriori indizi. Cosicchè, se è vero che egli è estraneo ai due gravi episodi, è però altrettanto vero che essi dimostrano una sorprendente convergenza tra gli interessi rappresentati dal Ciancimino e quelli degli ignoti autori degli attentati.
Infatti il Martellucci a quella data era Sindaco da pochi mesi ed il Ciancimino gli era notoriamente ostile, tant'è che, sentito dal G.I. in data 19.10.1984, il Martellucci dichiarò che le sue dimissioni erano state ispirate e volute da Ciancimino in particolare (...).
L'Insalaco, poi, (che da poco aveva dismesso eguale carica) pochi giorni prima era stato sentito dalla Commissione Parlamentare Antimafia riferendo, in quella sede, che la crisi della sua giunta trovava causa proprio nell'ostilità del Ciancimino nei suoi confronti.
Pertanto non può non rilevarsi come individui di diversa estrazione sociale e culturale, vicini o avversari del Ciancimino siano stati tutti trasversalmente uniti dal convincimento che opporsi alla realizzazione degli interessi rappresentati dall'imputato era un fatto estremamente pericoloso.
Del resto, la lunga, ininterrotta serie di omicidi di personaggi politici anche di primo piano che non trova riscontro in alcun’altra città italiana e che fa di Palermo una città simbolo delle devastanti conseguenze dell'intreccio tra attività politica e criminalità, ha contribuito certamente a rafforzare tale convincimento.
Di ciò vi è riprova, oltre che nelle dichiarazioni del Galante, dell'Alessi, nel convincimento del Bontate sulla causa dell'attentato al Martellucci, nonché nelle deposizioni dell'Insalaco e del Vaselli il quale ultimo ha dichiarato, senza mezzi termini: «chiedo che si tenga conto del fatto che data la situazione ambientale, anzicchè prestarmi ad operazioni illecite ho preferito soggiacere alle richieste di miei interventi nel campo degli spostamenti di denaro attraverso Istituti di Credito"» (v. deposizione dell'8.10.1984...).
Ed ancora, più apertamente: «Ho esaudito le richieste di Vito Ciancimino perché, data la qualità del personaggio, sarebbe stato impossibile non accoglierle» (v. deposizione resa l'8.4.1987...)
Ma il 26 marzo 1985 il predetto aveva, perfino, spontaneamente affermato: «Vorrei riferire altre cose che finora non ho detto per timore della mia incolumità personale» (...).
Nel 1970, l’elezione del Ciancimino a Sindaco del Comune di Palermo fu osteggiata – tra gli altri – dall’on. Lima.
Nel ricostruire le reazioni alla candidatura del Ciancimino a Sindaco di Palermo, il teste on. Alberto Alessi, esaminato all’udienza del 20 giugno 1996, ha riferito di avere preso parte ad una riunione con Achille Occhetto (allora capogruppo del P.C.I. nel Consiglio Comunale di Palermo) e con l’on. Lima (che “si opponeva in modo determinato contro la candidatura di Ciancimino”), nel corso della quale si decise che alcuni componenti del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana e tutti quelli appartenenti al gruppo consiliare del Partito Comunista l’indomani, nel corso delle dichiarazioni di voto, avrebbero presentato le loro dimissioni.
Questo proposito di rassegnare le dimissioni non venne, però, più messo in atto. Anche dalla deposizione testimoniale resa all’udienza del 19 giugno 1996 dall’on. Mario D’Acquisto si desume che la corrente andreottiana nel 1970 si oppose alla candidatura del Ciancimino a Sindaco di Palermo.
Il teste ha specificato che l’opposizione era determinata da ragioni di opportunità politica, essendosi già sviluppata un’accesa polemica attorno al Ciancimino. A seguito delle insistenze di Michele Reina e di Rosario Nicoletti, anche l’on. Andreotti e l’on. De Mita (che erano i capi delle correnti cui i primi due rispettivamente aderivano) rilevarono l’inopportunità dell’elezione del Ciancimino a Sindaco di Palermo.
Conseguentemente, il Ciancimino rimase in carica soltanto per un brevissimo periodo. Alcuni anni dopo, tuttavia, i rapporti tra il Ciancimino e la corrente andreottiana mutarono profondamente.
© Riproduzione riservata